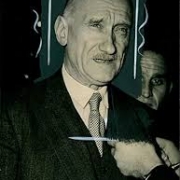Ha sicuramente suscitato un’onda profonda di sdegno e di orrore la profanazione oltraggiosa nei confronti della partigiana e deportata Lidia Rolfi Beccaria con la vergognosa scritta apparsa sulla porta della sua casa a Mondovì, dove vive il figlio Aldo: “Juden hier” e la stella di David.
Una caccia all’ebreo, come tanti anni fa, ma sulla porta di casa di una donna che ebrea non lo è mai stata. Un oltraggio alla memoria di una donna che lottò, la vita intera, per i valori in cui credeva e che trovò il coraggio, dopo anni di silenzio, di raccontare il dramma subito da lei e da tante altre compagne di sventura nel terribile lager solo femminile di Ravensbrück.
Chi è stata Lidia Rolfi Beccaria? Una grande testimone dell’orrore dei campi di sterminio, come Primo Levi. Attraverso i suoi libri, attraverso i suoi racconti, i suoi interventi, i suoi silenzi, la sua capacità di porsi come capofila nel difficile sentiero della Memoria.
Alcuni anni fa ho intervistato il figlio Aldo, lei non c’era già più. Il figlio Aldo, che continua il lavoro prezioso della madre, nelle scuole, nelle istituzioni, con articoli di giornale. Proprio per un giornale locale alcuni giorni fa aveva scritto un articolo che potrebbe anche essere stata la scintilla del gesto ignobile. La mia intervista ad Aldo Rolfi era finalizzata alla stesura di un capitolo sulla storia di Lidia Rolfi Beccaria inserito poi nel libro “Donne della Resistenza in Piemonte”.
Mi raccontò Aldo Rolfi. “Ogni tanto chiamava Primo Levi, parlava al telefono con mamma e le diceva: «Ho bisogno di aria grigia, vengo a trovarti». Arrivava qui da noi, a Mondovì, e si fermava tutta la giornata. Mamma e Primo, entrambi reduci dall’esperienza devastante del lager, parlavano lo stesso linguaggio e ogni tanto sentivano il bisogno, anche fisico, di condividere emozioni, ricordi, atmosfere, solitudini che certamente non erano percepite nello stesso modo da chi non le aveva vissute sulla propria pelle”.
Le note biografiche ricordano che Lidia Beccaria era nata a Mondovì l’8 aprile 1925, in una famiglia di origine contadina, ultima di cinque fratelli. Un’infanzia serena, accompagnata dalle consuete lusinghe del regime fascista. Un obiettivo importante: fare la maestra e dare un’impronta diversa al futuro della sua vita rispetto a quello della sua famiglia. Una grande capacità di studio, di lavoro.
Ma le lusinghe del fascismo cominciano a non fare più presa su di lei quando il fratello Beppe, spedito in Russia, ne ritornerà distrutto svelando il vero volto del nemico: “l’esercito tedesco che ha ucciso, torturato, fucilato donne, vecchi, bambini inermi e che durante la ritirata si è rivoltato anche contro gli italiani”. Eventi che modificano il modo di sentire di Lidia, ormai diplomata maestra. Quell’8 settembre 1943 avrà conseguenze molto importanti lì nel Cuneese. Ed è a ottobre che arriva la prima nomina di maestra a Torrette di Casteldelfino in Val Varaita. Il 16 novembre incontra all’albergo dell’Angelo di Sampeyre alcuni ebrei fuggiti da Saluzzo e lì sente per la prima volta parlare di un campo di concentramento per gli ebrei a Borgo San Dalmazzo.
Il suo avvicinamento ad esponenti della locale nascente Resistenza diventa naturale: il suo nome di battaglia? “Maestrina Rossana”. “Imparo a montare bombe a mano, che preparo alla sera al lume di un lanternino a petrolio, affronto il primo rastrellamento nel dicembre […]con una cassa di bombe sotto il letto. Affronto rischi, pericoli, posti di blocco e spie con la beata incoscienza dei diciotto anni”.
Tradita. Arrestata. Picchiata a sangue. Trasferita nelle mani della Gestapo a Saluzzo e poi alle Nuove di Torino. Tre mesi di fame, con altre detenute: qui ci sono anche Cesi Carletti, Pina Doleati, Anna Cherchi, Savina Palmiri… Un unico conforto: la presenza di suor Giuseppina De Muro, “l’angelo delle carcerate”. Poi, partenza da Porta Nuova, su un vagone bestiame, con altre tredici deportate.
Il viaggio, via Bolzano, verso Ravensbrück:80 chilometri a nord di Berlino, unico lager esclusivamente femminile, costruito all’inizio del 1939 da un Kommando di deportati, una delle città concentrazionarie più giovani della Germania nazista.
La descrizione che Lidia fa dell’ingresso a Ravensbrück, nel libro scritto molti anni dopo con Anna Maria Bruzzone, è straziante: “Ravensbrück ci appare davanti all’improvviso, sul tardo pomeriggio del 30 giugno, quando il sole è già sceso. Parlare di inferno dantesco è quasi ovvio. E’ uno spettacolo indescrivibile, allucinante, assurdo. Sembra di piombare su un altro pianeta. E’ il momento in cui le deportate rientrano al lavoro: una marea di donne incolonnate cinque per cinque e sorvegliate da donne e uomini in divisa da SS e da cani entra ciabattando dal portone d’ingresso, presso il quale sosta in piedi in silenzio perfetto e in posizione di attenti. Alcuni SS in attesa, taccuino alla mano, le contano e le ricontano, urlano, i cani ringhiano e annusano i talloni delle più vicine. Quando la fila riceve un ordine in tedesco si scioglie di corsa, si disperde, si allontana velocemente dal piazzale”.
Immatricolata con il n. 44140, Lidia rimase al campo principale fino al 26 aprile 1945. Un inferno. E poi i giorni di speranza, la marcia di evacuazione, la ritrovata libertà. Il ritorno a casa. Con la consapevolezza che gli altri non avrebbero capito.
La ripresa di una quasi normalità di vita, con quel macigno dentro e l’”aria grigia” che solo chi l’ha respirata può capire. Il lavoro da maestra, in mezzo a tante difficoltà, l’iscrizione all’Università. Poi l’incontro con l’uomo della sua vita, Aldo Rolfi, e la nascita del piccolo Aldo: scampoli di serenità ritrovata, ma con un grande vuoto ancora da colmare.
Nel 1955 uscì un libro intitolato “Il flagello della Svastica”, scritto da Lord Russel di Liverpool, consulente del Comando delle Forze Armate per i delitti di guerra giudicati dai tribunali britannici. Aveva potuto accedere a documentazioni di grande valore per testimoniare i delitti nazisti. Lidia divora il libro e per la prima volta, nel capitolo dedicati ai campi di sterminio e concentramento, trova anche Ravensbrück, non solo più la fossa dell’orrore nel suo cuore e nei suoi incubi, ma anche una precisa realtà geografica, conosciuta come “l’enfer des femmes”.
Da quel momento in poi, Lidia parla, racconta, capisce che è giunto il momento in cui non si può più tacere. Promuove iniziative. Torna con altre compagne di sventura a Ravensbrück nel 1959, in occasione dell’inaugurazione di un monumento in memoria delle vittime del nazismo. E’ il 17 settembre 1959.
Da allora un lungo percorso di testimonianza e di memoria che si realizzò anche in alcuni libri. Il primo, “Le donne di Ravensbrück”, scritto con l’amica e storica monregalese Anna Maria Bruzzone. Nacquero poi “L’esile filo della speranza” e, pubblicato postumo nel 1997, “Il futuro spezzato”, con la collaborazione dello storico Bruno Maida.
La sua scomparsa, a poco più di settant’anni, il 17 gennaio 1996, dopo una lunga malattia, dopo aver visto la pubblicazione delle sue testimonianze. Spesso aveva detto che dopo il lager “era stata tutta vita regalata”.
Un grande impegno anche per la sua Mondovì, che le ha dedicato una via e di cui fu anche vicesindaco. Ma anche una scuola elementare a Piazza: a lei, la maestra che non si era arresa, ad una ragazza “ardita e vulnerabile”, e come scrisse di lei Anna Bravo nel ritratto di “Italiane”, “un’antifascista esistenziale”.