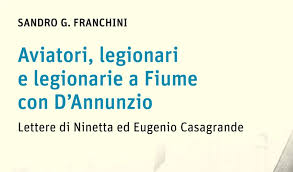Nizzardi a Fiume con D’Annunzio, di Achille Ragazzoni
Giuseppe Cesare Abba in Cose Garibaldine, un libro la cui prima edizione risale al 1907, riferendosi ai Nizzardi (lui lo scrive con la maiuscola) che partirono con i Mille, afferma che “…essi sapevano di mettersi a lavorare per una patria, cui erano stati fatti allora stranieri, ed essi passarono perciò i limiti della generosità umana…”.
Sia prima, come è ovvio, sia dopo il 1860, cosa questa meno ovvia, numerosi nizzardi contribuirono alle glorie militari d’Italia. Addirittura durante la seconda guerra mondiale: il Comandante Luigi Durand de la Penne (1914 – 1992), Medaglia d’Oro al Valor Militare per aver affondato la nave inglese Valiant nel porto di Alessandria d’Egitto era, infatti, di origine nizzarda.
Ho quindi letto, con grande piacere, il grosso libro (quasi 400 dense pagine!) di recente pubblicazione, dovuto alla penna di Sandro G. Franchini, Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio, Rubbettino Editore, ISBN 978-88-498-8288-9. In questo libro si può conoscere il contributo dato all’impresa di Fiume dalla famiglia nizzarda Cais di Pierlas.
La famiglia Cais di Pierlas, una famiglia nizzarda molto antica, resa nobile dai Savoia nel 1764, sostanzialmente per motivi di valore militare, valore che venne dimostrato anche in seguito nel corso del tempo, abbandonò la Contea di Nizza dopo l’annessione alla Francia per testimoniare così la propria italianità e la fedeltà a Casa Savoia.
Tra i nomi più famosi della famiglia ricorderò il pittore e botanico Ippolito (1788 – 1858), i cui quadri sono conservati in famosi musei e che decorò la facciata della chiesa del monastero di Cimella. Storico insigne, per ciò che riguarda la storia del medioevo nizzardo, fu Eugenio (Nizza 1842 – Torino 1900), la cui interessante corrispondenza con illustri esponenti dell’irredentismo nizzardo è stata resa nota da due suoi pronipoti, Nicolò e Andrea Jagher in due volumi per le fiorentine edizioni Phasar. Suo figlio Cesare (1871-1940) parteciperà alla prima guerra mondiale combattendo, tra il resto, sul fronte trentino. Un fratello di Eugenio, Ippolito (Nizza 1848 – ivi 1888), sarà ufficiale della Marina Militare combattendo sul mare nel 1866 ed in seguito parteciperà ad una spedizione navale italiana in America meridionale. La spedizione fu voluta per difendere i nostri emigrati potenzialmente (e, talvolta, non solo potenzialmente) danneggiati dalle numerose guerre, rivoluzioni tumulti e colpi di Stato che tormentavano quelle lontane terre. Un altro fratello, Giuseppe (Nizza 1845 – Venezia 1911), sarà ufficiale di Cavalleria e comandante, tra il resto, dei Lancieri di Firenze. Due suoi figli, Anna Maria nota come Ninetta (1896 – 1968) , e Alberto (Parma 1891 – Nizza 1973), musicista (fu compositore e pianista di un certo successo), sono due protagonisti dell’avventurosa vicenda svoltasi nella Fiume dannunziana. Il terzo protagonista è il marito di Ninetta, Eugenio Casagrande di Villaviera (Roma 1892 – Venezia 1957), pluridecorato pioniere dell’aviazione, audacissimo pilota, transitato nei ranghi dell’Aeronautica (diverrà generale di Brigata Aerea), provenendo dalla Marina.
Il libro di Sandro G. Franchini, pur essendo un saggio storico e ricchissimo di documentazione (vi sono anche 60 lettere dei protagonisti), si legge come un romanzo, perché romanzesche sono le vicende di quei personaggi.
Ninetta, una donna il cui fascino poteva stregare chi con lei veniva a contatto (del resto la parola latina fascinum significa malìa…), era una patriota a tutto tondo, focosa nel suo patriottismo come in tutto il resto (è sensibile ai temi dell’irredentismo, avendo ella stessa le proprie radici in una terra irredenta…) e non stupisce che un eroe come Eugenio Casagrande se ne innamori e la sposi. Come compare d’anello gli sposi avranno addirittura il Vate, Gabriele d’Annunzio. Erano in viaggio di nozze a Nizza, la città di cui la famiglia della sposa era originaria, quando vengono a sapere dell’entrata del Vate a Fiume e la coppia, assieme al di lei fratello Alberto, ufficiale dei Lancieri di Novara e conoscente di D’Annunzio, decide di recarsi senza indugio nella città del Quarnaro (Ninetta raggiungerà il marito e il fratello, partiti per primi, poco tempo dopo).
Eugenio viene subito nominato comandante dell’Aviazione legionaria, mentre Alberto entrerà nella segreteria particolare del Vate e verrà inoltre da lui incaricato di costituire, visto che si trattava di un musicista, un’orchestra ed un coro e di comporre un inno fiumano (D’Annunzio dava, e non aveva tutti i torti, una sorta di significato “politico” alla musica e ne riconosceva l’importanza per galvanizzare il popolo). Nella segreteria del Comandante entrerà anche Fulvio Balisti, alla cui memoria è stato intitolato un premio storico che un anno venne assegnato al sottoscritto per un saggio sul contributo dei nizzardi all’unità d’Italia. Proprio per le sue funzioni il Balisti si legherà di amicizia ai tre personaggi di cui il libro tratta (è davvero piccolo il mondo, quando ricevetti il premio alla sua memoria neppure sospettavo una cosa del genere!).
Ninetta, giunta poco dopo il marito e il fratello, si getta con grande entusiasmo nelle cerimonie patriottiche che esaltano i Legionari ed il popolo fiumano. Lo stesso Comandante le appuntò al petto una stella d’oro con lo stemma di Fiume ed il nastrino dei Legionari il cui motto era Fiume o morte.
Esaltazione patriottica, sogno di un avvenire migliore, speranza che Fiume potesse indicare all’Italia la maniera di rialzarsi, poesia di una rivoluzione mai vista prima, senza sangue e con il miraggio di un sistema sociale più giusto e più nobile (per me la Carta del Carnaro, intrisa di mazzinianesimo, firmata e un po’ aggiustata dal punto di vista letterario da D’Annunzio, ma in realtà scritta dal sindacalista rivoluzionario Alceste de Ambris, è davvero la costituzione più bella di tutte), terminano con il cosiddetto “Natale di sangue”, assieme ad Aspromonte uno degli episodi di cui meno andare orgogliosi della nostra storia militare. Si decise di agire a Natale perché per due giorni i giornali – allora unica fonte di informazione per le masse – non sarebbero usciti, e così si evitava che l’opinione pubblica italiana potesse reagire al sopruso.
La casa ove Ninetta vive, viene occupata dalle truppe regolari, due ufficiali dei Carabinieri le danno della puttana, la truppa provvede ad alleggerire gli abitanti di beni “superflui”. Ninetta si comporta con grande dignità e fierezza di donna italiana, ribattendo opportunamente ai cialtroni che la offendono, dimostrando di mettere troppo zelo nel compiere quello che dovrebbe essere un ingrato dovere, per loro invece, evidentemente, un sadico piacere. Arrestata e imprigionata per qualche giorno, è solo un brigadiere dell’Arma a mostrare gentilezza nei suoi confronti. Ninetta rimarrà sempre fedele agli ideali della gioventù e, leggendo il bel libro di Franchini, che ricostruisce assai bene l’ambiente in cui si sviluppò il movimento chiamato “Fiumanesimo”, viene un groppo alla gola pensando a quali personaggi potevano vivere ed operare in quella che lo storico Gioacchino Volpe definì, “l’Italia che fu”.
ACHILLE RAGAZZONI
Il libro verrà presentato a Bolzano presso lo Spazio WE, Piazza Domenicani 22, alle ore 18.00. Saranno presenti l’Autore e Andrea Jagher, nipote di Ninetta Cais di Pierlas.