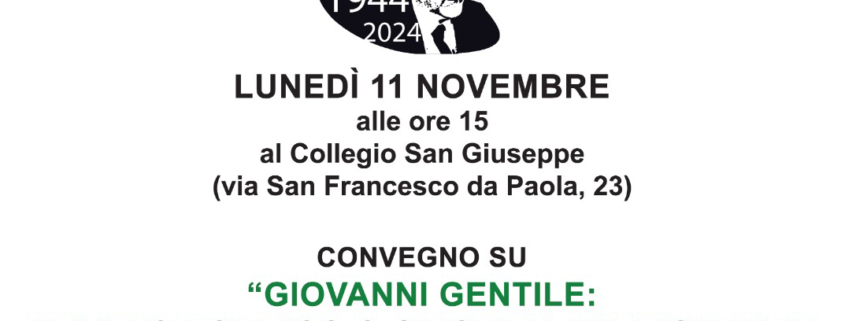La controversa eredità di Giovanni Gentile, di Giuseppe Parlato
Quando Gentile fu ucciso, i suoi allievi, diretti o indiretti, erano già diventati importanti e famosi nel mondo culturale italiano: Guido De Ruggiero, Adolfo Omodeo, Giuseppe Lombardo Radice, Giuseppe Maggiore, Ernesto Codignola, Ugo Spirito, Arnaldo e Luigi Volpicelli, Guido Calogero. Molti di questi erano schierati a sinistra, in particolare vicino al Pci o al Partito d’Azione e avevano recepito, insieme con l’attualismo, anche il concetto di intellettuale militante, che era stato uno degli elementi di forza del pensiero politico e civile di Giovanni Gentile.
L’idea di un intellettuale militante veniva a Gentile dal vocianesimo di Prezzolini e dalla polemica contro il positivismo, che privilegiava la figura dell’intellettuale neutrale e asettico. Per Gentile, invece, fin dalla prima guerra mondiale, si andò formando la convinzione che la nuova cultura dovesse basarsi su intellettuali che non si limitavano a osservare il reale “dalla finestra” ma contribuissero a modificarlo. “Scendere per strada…” era stato l’invito più volte rivolto alla cultura italiana, dal 1916 fino al 1925: “E quando tutti gli italiani saranno scesi in strada e penseranno e rifletteranno senza sentire più la tentazione di tornare alla finestra, l’italiano comincerà ad essere quel gran popolo che deve essere”, aveva scritto Gentile nel 1925.
Dopo la fine del fascismo, questo messaggio restava valido, sebbene mutato di campo politico. Fu la sinistra ad appropriarsene facendone un punto di forza culturale. Se Gentile aveva contribuito a organizzare diverse istituzioni culturali che avrebbero dovuto innervare la cultura fascista in termini di alta intellettualità, allo stesso modo fu sulle istituzioni culturali che il Partito comunista si indirizzò dopo la fine della guerra per preparare la sua egemonia culturale. Fu un lavoro complesso e articolato, che si giovò dell’inerzia culturale del mondo democristiano in quel periodo (mentre il mondo cattolico era tutt’altro che inattivo) e della confusione politica che regnava nel mondo laico , diviso tra liberalismo, azionismo e socialismo riformista.
L’attenzione posta da Togliatti alla organizzazione della cultura nacque non soltanto da una esigenza di carattere ideologico ma anche dal fatto che alla caduta del fascismo molti intellettuali, che erano stati fascisti, si ritrovarono con un forte complesso di colpa e non parve loro vero che il Pci tendesse loro le braccia. Da questo primo atto di intelligenza politica, il Pci trasse il vantaggio che sperava: si sostituì al partito fascista nell’assicurare la protezione al maggior numero possibile di intellettuali. La penetrazione attraverso la stampa, le università, le accademie, le scuole, il teatro, il cinema costituì un punto fondamentale nella organizzazione di una struttura culturale formalmente aperta e libera, in realtà saldamente legata al partito.
Non a caso, avvenne che uomini che erano stati in galera, come Vittorio Foa, già nel 1942 si imbattessero nell’“antifascismo gentiliano” di Guido Calogero. Si cercavano – lo notava sempre Foa – le radici del comunismo postbellico nell’idealismo gentiliano oppure nell’immaginario corporativismo di sinistra.
In questo contesto nacquero l’Alleanza della cultura, nel febbraio 1948, poco prima delle elezioni del 18 aprile, e l’Istituto Gramsci, costituito nel 1950 con l’obiettivo di raccogliere la documentazione relativa a Gramsci, trasformatosi in Istituto nel 1954, quando è diventato il principale organo culturale
e di ricerca del Partito comunista italiano con sezioni di lavoro dedicate a storia, filosofia, economia, pedagogia, diritto.
Vi è un altro aspetto di notevole interesse a proposito della continuità metodologica tra il gentilianesimo e l’attività culturale del Partito comunista, e riguarda il problema del Risorgimento.
Giovanni Gentile operò attivamente, in tutto il corso della sua vita, per rendere il Risorgimento “compatibile” con il fascismo. Oltre le diverse opere su temi risorgimentali (dalla tesi di laurea su Rosmini e Gioberti, fino ai saggi dedicati a Capponi, Gioberti, Manzoni, Leopardi, Mazzini, Alfieri, solo per citarne alcuni) Gentile si interessò al problema del Risorgimento in un arco ventennale della sua produzione scientifica: nel febbraio 1923 usciva la prima edizione dei Profeti del Risorgimento, mentre nel marzo del 1944, un mese prima della sua uccisione, ne usciva la terza, ampliata e rivista. Il concetto di fondo era quello di un collegamento stretto fra Risorgimento e fascismo, nel senso che il fascismo, nel pensiero di Gentile, altro non era che l’inveramento del Risorgimento in quanto quest’ultimo si poté realizzare pienamente solo grazie all’avvento del fascismo. Il motivo era il passaggio da un Risorgimento caratterizzato da un patriottismo di élite, al fascismo, caratterizzato non solo da un patriottismo di massa ma soprattutto da un progetto di Stato che il Risorgimento completasse e realizzasse.
Negli anni tra il 1922 e il 1929, prima del Concordato, la cultura gentiliana ha assicurato la continuità tra il fascismo e la tradizione hegeliana del liberalismo risorgimentale, continuità di cui il fascismo aveva bisogno per inserirsi nella classe dirigente dei primi del Novecento. Senza tale operazione il fascismo sarebbe rimasto un corpo a se stante, indipendente dalla tradizione liberale italiana.
Anche per Togliatti la questione risorgimentale era centrale, una volta caduto il fascismo. Fino a quel momento il Partito comunista aveva considerato il Risorgimento un fenomeno di élite, tendenzialmente conservatore, frutto di una mancata rivoluzione come era avvenuto nella Francia del 1789. Il problema centrale della mancata considerazione del Risorgimento era la tiepida valutazione da parte del Pci della questione nazionale. Così come per Gentile, anche per Togliatti era indispensabile che il Partito comunista “accettasse” la tradizione italiana del Risorgimento, mettendone in luce soprattutto gli aspetti della sinistra risorgimentale, senza però escludersi da questo filone di pensiero, pena la impossibilità di inserirsi nella classe dirigente del Paese.
Fu soltanto dopo la caduta del fascismo e con la Resistenza, quando il Pci riteneva di potere presentarsi con le carte in regola per la gestione del potere in Italia, e dopo i Quaderni dal carcere di Gramsci, un tomo dei quali era dedicato al Risorgimento e alla questione nazionale, che Togliatti iniziò a prendere in considerazione i temi risorgimentali.
Alle spalle vi era il lavoro di Gramsci, individuato da Augusto Del Noce come più vicino a Gentile che a Croce. E se Gentile aveva posto in Giuseppe Mazzini il punto di incontro fra Risorgimento e fascismo, allo stesso modo Gramsci considera Mazzini il passaggio più vero tra il Risorgimento e la prospettiva nazional-popolare che intende dare ai suoi Quaderni.
D’altra parte, come sappiamo, Togliatti riorganizza i Quaderni gramsciani affinché vi sia un filo conduttore proprio sul problema risorgimentale. Non è un caso che le brigate partigiane comuniste siano dedicate a Garibaldi e che l’effige dell’eroe dei due mondi compaia nella scheda elettorale del 1948 come simbolo del Fronte popolare democratico, l’alleanza elettorale tra comunisti e socialisti.
Ma, si è detto nel titolo di questo breve intervento, che si tratta, per quanto riguarda Gentile, di una eredità controversa.
Infatti vi è anche chi ha interpretato Gentile come l’ultimo esponente di quel liberalismo conservatore che apparve alla fine dell’Ottocento per risolvere i problemi non risolti del Risorgimento, in particolare il rapporto tra élite culturale e masse.
In effetti, chi sostiene questa tesi – in particolare lo storico Francesco Perfetti – sottolinea, giustamente, come il liberalismo italiano, a differenza di quello britannico o di quello francese, non aveva contestato lo Stato ma anzi lo aveva costituito. La Destra storica era stata fautrice di un forte intervento dello Stato nell’economia: essa era caduta nel 1876 in virtù del suo appoggio alla nazionalizzazione delle ferrovie, una logica che oggi ci può stupire ma che dipende dal fatto che la Destra storica intendeva portare a termine l’unificazione fisica del paese, proprio attraverso la costruzione delle strade ferrate.
Se poi pensiamo che il pensiero liberale italiano, nel corso dell’Ottocento, fu fortemente influenzato da un personaggio come Silvio Spaventa, a sua volta condizionato da una visione hegeliana dello Stato, si può comprendere come un teorico dello “Stato etico” come Gentile si definisse liberale e appartenesse, prima della sua nomina a ministro di Mussolini, al partito liberale.
Per completare questa complessa eredità, manca ancora la destra politica del dopoguerra, la quale ha considerato Gentile commendevole di rispetto e di magistero essenzialmente perché il filosofo siciliano era stato ucciso per mano partigiana. Ma non ci fu solo quello: il Movimento sociale prese come modello politico e ideologico quello Stato nazionale del lavoro che fu l’ultimo progetto di Gentile, contenuto nell’ultimo libro, Genesi e struttura della società, che aveva affascinato l’allievo Ugo Spirito, in procinto di aderire al Pci; lo Stato nazionale del Lavoro costituiva l’alternativa di un corporativismo di sinistra, quale era in quel momento quello di Gentile – che nel discorso agli Italiani al Campidoglio nel 1943 si era rivolto ai comunisti definendoli “corporativisti impazienti” – ed era inteso come superamento definitivo della democrazia liberale: il primo fondato sulla competenza e la seconda sul numero.
La complessa eredità gentiliana testimonia l’importanza del ruolo di Gentile quale modernizzatore della cultura, sebbene all’interno di un sistema politico negatore delle libertà, autore di un modello che ha avuto, consapevolmente o meno, eredi assai diversi fra loro.