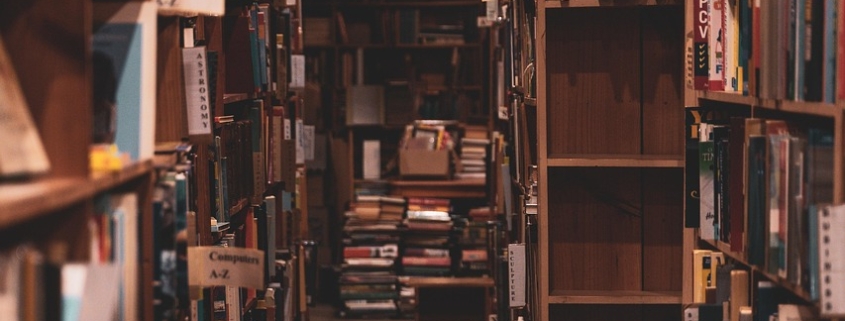Benedetto Croce: Filosofia dello Spirito e dinamica delle Forme, di Guido Gandolfi
Lo studio della storia, declinata in tutte le sue molteplici manifestazioni, politiche e culturali, pone Croce di fronte alla pluralità di forme nelle quali l’attività umana trova la sua espressione. Al fine di comprendere la specificità di ciascuna di queste forme e al fine di cogliere i nessi che le tengono collegate fra loro, egli si serve della tecnica della elaborazione e della delucidazione dei concetti che affondavano proprie radici nel pensiero del filosofo e pedagogo Johann Friedrich Herbart. L’obiettivo era quello di delineare nello specifico ogni forma dell’attività spirituale, determinandone precisamente i confini rispetto a ogni altra servendosi di una negazione della negazione; questo significa che per delineare l’estetica sarebbe stato necessario indicare tutto ciò per cui l’Estetica esistesse e non è Filosofia e non è Economia e non è Morale. Questo modo di procedere mette in campo la distinzione tra le forme dello Spirito. Un vero e proprio sistema filosofico denominato da Croce Filosofia dello Spirito viene costruito attraverso la tecnica della distinzione. La sistematizzazione di questo sistema è da collocare temporalmente a partire dal 1900. Il significato di Spirito deve essere interpretato come l’attività dell’uomo nella sua dimensione di universalità che è in grado di andare aldilà della sfera finita dei singoli individui; la teoria delle quattro forme dello Spirito viene elaborata già nel testo Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale; questa teoria è orientata a delineare secondo quali modalità lo Spirito operi nel tempo in modo universale. Il filosofo abruzzese propone una prima “distinzione” tra due tipologie di attività dello Spirito: l’attività teoretica e quella pratica.[1]
Croce, per elaborare la sua Filosofia dello Spirito, ha studiato in modo approfondito il pensiero di Hegel e con esso si è confrontato; da allora giunge alla convinzione di poter strutturare una sua filosofia dello Spirito. Il centro della filosofia elaborata dal filosofo italiano prevede la compresenza del rapporto dialettico fra gli opposti e la dialettica dei distinti; tuttavia non esistendo un rapporto dialettico fra i distinti, egli ritiene necessario ricorrere a una riforma della dialettica di Hegel.[2]
La riforma della filosofia hegeliana elaborata da Croce rappresenta un momento importante nel confronto fra i due filosofi: il filosofo italiano concorda con Hegel quando scrive che l’universo deve essere considerato come manifestazione dello Spirito che si sviluppa dialetticamente, teso alla coscienza di sé: la realtà, dunque è storia dello Spirito, manifestazione dell’assoluto, quindi totale razionalità. Razionalità non significa razionalità formale; significa la razionalità vivente nella scansione temporale del processo storico di riconoscimento di sé che lo spirito compie. La modalità di interpretazione della dialettica costituisce la novità più significativa introdotta in questa teorizzazione da Croce; il pensatore tedesco propone una dialettica degli opposti in base alla quale “la vita dello spirito si svilupperebbe per triadi (tesi, antitesi, sintesi) che si succedono una all’altra in un processo di continua negazione e di continuo superamento; il legame di opposizione fra un momento e l’altro di questo sviluppo costituiva, per lui, la radice stessa dell’unità dinamica dello spirito”. Croce sostiene una tesi diversa: lo Spirito si suddividerebbe in varie categorie basilari vincolate tra loro da un rapporto di distinzione, come si è detto prima; questa è la tesi filosofica di cui Hegel non tiene conto. “La dialettica degli opposti regolerebbe la vita interna di ogni categoria, mentre la dialettica dei distinti regolerebbe i rapporti tra una categoria e l’altra”.[3]
Lo Spirito, a parere di Croce, è un nesso di distinti e non può essere considerato alla stregua di una sintesi di opposti. Due aspetti filosofici caratterizzano lo Spirito e la sua attività: l’attività teoretica svolge una azione rivolta alla conoscenza e l’attività pratica è azione; lo Spirito, inoltre, può volgere la sua attenzione verso l’individuale o l’universale.
Alla luce di queste tesi, il filosofo abruzzese propone una distinzione fra quattro categorie o “distinte” e quattro opposti dello Spirito. La conoscenza dell’individuale o particolare trova la sua espressione nell’Arte; l’attività estetico-intuitiva utilizza la fantasia e trova i suoi fondamenti nella opposizione tra la categoria del bello e la categoria del brutto. La conoscenza dell’universale, che si realizza attraverso la Filosofia, è caratterizzata da una attività logico-intellettiva e si serve dell’intelletto; la volizione del particolare ha come oggetto l’economia e ha le basi fondanti nella opposizione fra le categorie dell’utile e dell’inutile; la volizione dell’universale, che si manifesta attraverso l’Etica, si realizza nell’attività morale; tale tipologia di volizione trova i suoi fondamenti nell’opposizione tra la categoria del bene la categoria del male.
Sia per Benedetto Croce, sia per Giovanni Gentile, al di fuori dello Spirito non c’è nulla.[4]
Una volta effettuata l’opera di distinzione fra le forme dell’attività spirituale, si rivela cosa utile approfondire la problematica della loro reciproca relazione.
Al fine di recepire pienamente la dialettica hegeliana, il filosofo abruzzese prende le distanze dall’impostazione “logico-psicologica” teorizzata da Herbart. La teorizzazione di Croce è fortemente influenzata dal pensiero di Bertrando Spaventa, la cui cultura risente degli insegnamenti hegeliani e kantiani. Affiora un rifiuto del pensiero panlogistico che interpreta l’intera realtà come fosse una espressione dell’Idea o del Logo divino; respinge la visione della natura come “opposto” dello Spirito; sopravvive, del sistema hegeliano, esclusivamente il momento dello Spirito, che opera in un moto dialettico ascendente verso la piena coscienza di sé; la storia è movimento dialettico che il filosofo italiano interpreta attraverso il pensiero di Giovan battista Vico. Questo pensatore interpreta la storia come un processo circolare di corsi e ricorsi storici di cui l’uomo è autore.
Croce sostiene che il pensiero è storia e che la storia è pensiero e che entrambi devono essere colte attraverso il concetto che è universale ed è concreto; il concetto è sintesi di opposti proprio perché esso lega insieme le diverse determinazioni concrete rivelandone la necessaria connessione nel tempo.[5]
Un argomento di grande interesse è la circolarità dello Spirito: il filosofo sostiene che il movimento dello Spirito non consiste in una frammentazione di momenti (Estetica, Logica, Economia, Morale), al contrario le quattro forme nelle quali il movimento dello Spirito si manifesta si concatenano l’una con l’altra; il filosofo fa un esempio: nell’organismo animale possiamo dire che esso rappresenta la lotta della vita contro la morte; però non si può affatto dire la stessa cosa delle singole membra perché non è che le mani lottino contro i piedi o i piedi contro le mani; in altri termini, lo Spirito è una unità organica di distinti e di opposti; quando lo Spirito distingue le varie forme di conoscenza che corrispondono al bello, al vero, all’utile, al buono, non spezza l’unità della realtà; anzi, queste singole componenti sono colte come momenti di un unico processo fondamentale che è il processo dell’autocoscienza umana.
Perotto A., Storia della filosofia 3, Società Editrice Internazionale, Torino Ristampa giugno 1969, p. 238
[1] Cambiano G., Mori M., Storia della filosofia contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 245
[2] Bontempelli M., Bentivoglio F., Il senso dell’essere nelle culture occidentali, Trevisini Editore, Milano, p. 333
[3] Geymonat L., Storia del pensiero filosofico, Vol. terzo. La filosofia nei secoli XIX e XX, Garzanti, Milano, 1971, p. 306
[4] Massarenti A., Di Marco, con la collaborazione di Maria Amelia Mannella, Penso dunque sono, Storia e testi della filosofia 3A. Dalle filosofie posthegeliane al neoidealismo, G. D’Anna, Messina-Firenze, Loesher editore, Torino, 2014, pp. 443-444
[5] Cioffi F., Gallo F., Luppi G., Vigorelli A., Zanette E., Filosofia autori e testi 3 il pensiero contemporaneo, Paravia Bruno Mondadori Editore, Milano, 2000, p. 263-264