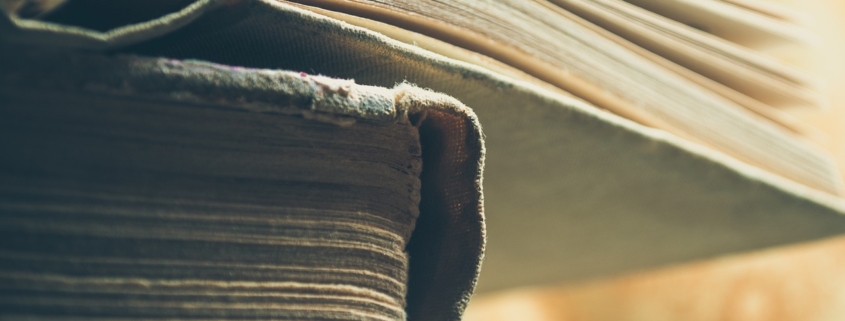Ultimo commiato a Francesco Bruni, di Loris Maria Marchetti
Ingente è il debito di riconoscenza che la cultura non solo italiana ha accumulato a favore di Francesco Bruni, spentosi il 24 giugno del 2025. Linguista e filologo, critico e storico della letteratura, italianista a tutto campo, Bruni, nato a Perugia il 19 marzo del 1943 e allievo a Napoli di Salvatore Battaglia, si laureò in Letteratura italiana (1965) con la tesi Problemi e discussioni di “Poetica” aristotelica: Sperone Speroni, Benedetto Varchi, Alessandro Piccolomini, argomento sucui ebbe a ritornare in séguito.In varie Università italiane (Napoli, Bari, Salerno, Verona) insegnò Filologia romanza, Storia della letteratura italiana, Storia della grammatica e della lingua italiana, Storia della lingua italiana, per approdare in fine (1989) all’Università Ca’ Foscari di Venezia, come professore ordinario di Storia della lingua italiana dal 1991. Fu visiting professor al Cairo, Girona, Los Angeles, Chicago, Toronto.
Accademico dei Lincei, Socio corrispondente dell’Accademia della Crusca, membro del Consiglio di Presidenza dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (2015 – 2021), Presidente dall’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), per l’editore Liguori diresse con Antonio Palermo la collana “Otto-Novecento ritrovato” e con Alberto Varvaro “Romanica napolitana”. Fece parte del Comitato editoriale della «Rivista italiana di dialettologia» e della serie «Italian Medieval and Renaissance Texts and Studies» diretta da Vincent Moleta dell’University of Western Australia. Fu condirettore del «Giornale storico della letteratura italiana» e della rivista «Lingua e stile».
Come studioso di linguistica pubblicò una nutrita serie di saggi e volumi tra cui emergono: L’Italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti (UTET, 1984); Testi e chierici del medioevo (Marietti, 1991); Storia della lingua italiana: la lingua del Manzoni (il Mulino, 1993) in collaborazione con Giovanni Nencioni; L’Italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali (UTET, 1992); Manuale dell’Italiano professionale: teoria e didattica (Zanichelli, 2002) in collaborazione con Tommaso Raso; L’Italiano letterario nella storia (il Mulino, 2007); L’Italiano fuori d’Italia (Cesati, 2013).
A vario titolo (autore di volumi, saggi, interventi, recensioni, curatele) si occupò tra i molti altri – dal Medioevo al Novecento – di Brunetto Latini, Rustico di Filippo, Gianni Alfani, Zucchero Bencivenni, Lapo Gianni, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Petrarca, Coluccio Salutati, Leopardi, Tommaseo, Verga, Serao, Ungaretti, Montale, Saba… Importante è il volume Sistemi critici e strutture narrative. Ricerche sulla cultura fiorentina del Rinascimento (Liguori, 1969). Ma le opere di maggior mole e impegno firmate da Bruni sono probabilmente i due monumentali tomi del volume Dalle origini al Trecento nella Storia della civiltà letteraria italiana diretta da Giorgio Bàrberi Squarotti (UTET, 1990), tomi interamente redatti dallo studioso perugino con l’eccezione dei capitoli su Dante e Petrarca; Boccaccio. L’invenzione della letteratura mezzana (il Mulino, 1990), ponderosa monografia che attesta l’autore forse più amato, sollecitato e sviscerato sotto il profilo storico, ideologico, stilistico, linguistico; La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini (il Mulino, 2003), dove brilla splendidamente lo storico della cultura e del costume che ricostruisce le lotte tra i partiti, a cominciare da Guelfi e Ghibellini, e rievoca le vane predicazioni dei Domenicani preoccupati del “bene comune”; Italia. Vita e avventure di un’idea (il Mulino, 2010); Idee d’Italia. Da Napoleone al Quarantotto (il Mulino, 2021).
Di eminente rilievo sono i contributi di Bruni nella collana editoriale “Presente storico” edita da Marsilio auspice la Fondazione “Giorgio Cini”: “Leggiadre donne…”: novella e racconto breve in Italia (vol. 14, 2000); “Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori”. Poema e romanzo: la narrativa lunga in Italia (vol. 18, 2001); La maschera e il volto: il teatro in Italia (vol. 22, 2002); In quella parte del libro de la mia memoria: verità e finzioni dell’ “io” autobiografico (vol. 26, 2003).
Intellettuale informatissimo e versatile, Bruni curò anche il volume Un filosofo e la città. Benedetto Croce e la cultura a Napoli nel secondo Ottocento: continuità e rotture, 1902-1915 (Gaetano Macchiaroli Editore, 1983) e dedicò pagine attente e partecipi al suo Maestro, Salvatore Battaglia (La preparazione del “Grande Dizionario della Lingua Italiana” nel carteggio tra Salvatore Battaglia e Carlo Verde, in «Medioevo Romanzo», XVII, poi nel volume Per Salvatore Battaglia (1904-1971), Atti del Convegno di Studi 8-9 novembre 1991, Liguori, 1993).
Io ebbi la ventura (vorrei dire la fortuna) di essere, presso la UTET, l’editor del citato volume in due tomi Dalle origini al Trecento, il che mi permise di entrare a stretto contatto con un italianista serio, alacre, preciso, rigoroso, puntuale (oltre che, si intende, di rara valentia e competenza: e scrittore stilisticamente ragguardevole): ma essendo, Francesco Bruni, soprattutto persona cordialissima, generosa, spiritosa, ironica, dal complementare lavoro comune nacque una bella sincera solidale amicizia – tra Torino, Napoli, Verona – che non posso non ricordare, ora che Francesco non è più fisicamente tra noi, con affetto e commozione.