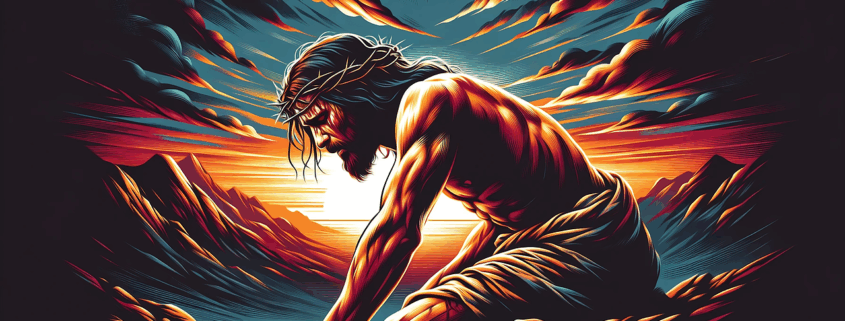Il sacrificio della divinità, di Marco Calzoli
Nelle religioni il sacrificio è la offerta tributata da un sacerdote a una divinità per ottenere dei favori. Nella religione più antica dell’umanità, l’induismo, il sacrificio vedico è l’asse portante del mondo. Infatti leggiamo nel Ṛg-Veda (I.164.35), il più antico dei Veda, i testi sacri dell’induismo, ove è scritto in sanscrito vedico:
iyaṃ vediḥ paro antaḥ pṛthivyā ayaṃ yajño bhuvanasya nābhiḥ | ayaṃ somo vṛṣṇo aśvasya reto brahmāyaṃ vācaḥ paramaṃ vyoma ||
“L’altare è l’ultimo limite della terra;
questo sacrificio compiuto da noi è il centro del mondo;
Soma è il seme prolifico, essenza di virilità;
la nostra preghiera è il cielo più alto dove abita la Parola”.
In Ṛg-Veda IV.23.10 si gioca sul valore del termine vedico ṛta, che oscilla tra “rito” e “ordine cosmico”, in uno splendido metro nicṛttriṣṭup:
ṛtaṃ yemāna ṛtam id vanoty ṛtasya śuṣmas turayā u gavyuḥ | ṛtāya pṛthvī bahule gabhīre ṛtāya dhenū parame duhāte ||
“L’(adoratore cerimoniale) che sottopone ṛta (alla sua volontà) gode veramente di ṛta; la forza ṛta è (sviluppata) con velocità ed è desiderosa di (possedere) acqua; a ṛta appartengono il cielo e la terra ampi e profondi; vacche sublimi, cedono il loro latte a ṛta”.
Il sacrificio vedico è l’atto cultuale più importante che ci sia in quanto permette la armonia dell’universo. Così si legge nel Śatapatha Brāhmaṇa XIV, 3, 2, 1:
sarveṣām vā eṣa bhūtānām sarveṣāṃ devānāmātmā yadyajñastasya
“Tutto ciò che è, compresi gli esseri celesti,
ha un solo principio di Vita, un solo Sé: il Sacrificio”.
L’atto sacrificale permette la sopravvivenza della comunità, garantita dalla benevolenza delle divinità cui è rivolto. Per questo Ṛg-Veda I.90.5 così invoca:
uta no dhiyo goagrāḥ pūṣan viṣṇav evayāvaḥ |
kartā naḥ svastimataḥ ||
“Pūṣan, Viṣṇu dal passo veloce, fate sì che i nostri riti siano di conservazione per il nostro bestiame; rendeteci prosperi”
Il mondo vedico si basava sull’agricoltura e sull’allevamento, per questo nel sacrificio si chiede alle divinità di essere benevole nei confronti del bestiame.
In questo passo ci sono due vocativi di nomi divini ravvicinati: si tratta di un fatto linguistico raro. Il poeta vuole conferire solennità al passo, perché vuole enfatizzare il fatto che le divinità sono propizie verso il bestiame.
C’è un’altra particolarità filologica degna di nota. Il termine sanscrito evayāvaḥ vuol dire “dal passo veloce”, preferibilmente detto di una camminata rapida, di una corsa: così del Marut (V.41. 5), qui del dio dalle grandi falcate Visnu. Il termine eva- vuole indicare anche il “comportamento” (cfr. X.73.2).
Ora Geldner osserva che il termine in questione si può riferire sia a Visnu sia ai Marut: il primo è conosciuto per i suoi famosi grandi passi, mentre la “corsa” (eva) dei Marut è spesso menzionata. Infatti si dice dei Marut in I.166.4:
ā ye rajāṃsi taviṣībhir avyata pra va evāsaḥ svayatāso adhrajan | bhayante viśvā bhuvanāni harmyā citro vo yāmaḥ prayatāsv ṛṣṭiṣu ||
“Quelli, i tuoi corsieri, che attraversano le regioni a velocità, procedono, guidati da soli; tutti i mondi, tutte le dimore, sono allarmati, perché meraviglioso è il tuo arrivo; (tale paura si prova) quando le lance vengono scagliate (in battaglia)”
Ragion per cui evayāvaḥ può essere inteso sia come attributo di Vishnu sia come indicante i Marut. In questa seconda interpretazione, il poeta invocherebbe tre divinità: Pusan, Vishnu e Marut. Allora avremmo a che fare con un ternario.
In tutte le religioni il numero tre è quello perfetto. Pitagora spiega la creazione come un triangolo di forze, che per altri può essere rappresentano dal triangolo con la punta in basso: Padre e Madre generano il Figlio (angolo inferiore). Secondo una interpretazione, con la quale concordano tra gli altri i Veda, il Corpus Hermeticum e lo gnosticismo giovanneo, insegna che l’Ineffabile, al momento della manifestazione, sembra agire in forma triplice: il Padre (Sat) come Creatore esistente al di là della manifestazione, il Figlio (Tat o Nous) come Intelligenza divina immanente nella manifestazione ed infine la Parola divina (Aum o Logos) quale vibrazione Divina che concretizza la manifestazione. L’induismo parla della Trimurti e il cristianesimo della Trinità. Al concetto del ternario nelle religioni Guénon ha dedicato un libro affascinante.
Allora la presenza del numero tre conferirebbe a questo inno una solennità ancor maggiore.
Il Ṛg-Veda è scritto in sanscrito vedico, la fase più antica di questa lingua dalla bellezza divina ma dalla difficoltà diabolica.
La parola saṃskṛta, attestata fin dal Rāmāyaṇa come termine linguistico, significa propriamente “compiuto, perfetto”: allude implicitamente a saṃskāra, vale a dire ai processi di “completamento” grammaticale (e più tardi anche stilistico) grazie ai quali la materia prima del linguaggio, prakṛti, viene portata alla perfezione formale; o, come dice poeticamente il più antico scrutatore della lingua, l’autore dell’inno X.71 del Ṛg-Veda, viene “chiarito” come “il grano viene chiarito utilizzando il setaccio” (saktum iva titaunā punantaḥ).
Probabilmente esisteva fin dall’inizio una connotazione spirituale: saṃskṛta evoca anche la serie di purificazioni religiose, i sacramenti (saṃskāra) attraverso i quali passa l’indù di alta casta, tra la nascita e la morte. L’idea della grammatica come strumento di purificazione è presente nel commento grammaticale più antico, il Paspaśā di Mahābhāṣya, così come in tutto il Mimāṃsā.
Già la parola, cioè il sanscrito vedico, è una purificazione, è un rito, è un sacrificio inteso in senso lato. Per il mondo indiano, infatti, il sanscrito è un dono degli dei e, secondo la dottrina del rasa, anche l’opera d’arte può portare alla liberazione (mokṣa).
Il Pūrvamīmāṃā Sūtra di Jaimini elabora infatti una dottrina che è una sorta di comprensione del linguaggio come realtà preesistente alle .strutture del mondo, ove il sacrificio viene a rappresentare la modalità costitutiva e fondamentale della realtà. L’organizzazione di quest’ultima converge e aderisce con le categorie concettuali del linguaggio sacrificale proprio nella direzione di una conoscenza attiva della cerimonia rituale. La esistenza della realtà strutturata su una primordiale interrelazione tra parola e azione sacrificate (karma) che sfugge alle comuni modalità conoscitive. In tal senso, gli ordinari mezzi di percezione (prāmaṇa) si rivelano insufficienti per la conoscenza del dovere ritualistico (dharma). Unicamente il suono-parola (sabda) dei Veda potrà rendere conto dell’azione sacrificate in conformità ai precetti strutturati nella parola vedica stessa. La logica di questa riflessione concepisce il sacrificio come uno schema espositivo dell’ordine del mondo e dell’attività umana, quindi il dharma ritualistico andrà considerato un’unità in relazione alla parola vedica. Non essendoci distinzione tra parola e realtà, ciò si fonda la posizione dei conoscitori del sacrificio (yajña) per cui il Veda è la verità assoluta. Essi risolvevano, identificando, il Brahman (Assoluto, Dio) nelle parole del Veda proprio perché recitare la parola vedica significa identificarsi col Brahman, che determina ogni realtà.
Il Brahman è quanto di più impersonale possa esserci, non avendo attributi (nirguna). Quindi nella iconografia induista viene spesso personificato. Lo si immagina come una divinità suprema, antropomorfa che è il Signore, reggitore onnipervasivo dei processi vitali del mondo. Il Signore è colui che fa accadere il carattere mayico della evoluzione, della conservazione e della dissoluzione dell’universo. Agni è il dio del fuoco, quindi troppo specializzato per indicare i quattro elementi alla base del cosmo. Brahma è visto troppo in maniera benevola come il solo creatore. Allora gli induisti hanno scelto la triade costituita da Vishnu (Conservatore), Shiva (Distruttore) e la Dea Madre del Mondo (Shakti), che sono le manifestazioni divine fortemente sentite allo stesso tempo terribili e benevole, creative e distruttrici, repellenti e attraenti. Tutti e tre questi dei quindi sono eminentemente qualificati a rappresentare la Suprema Pienezza. Ebbene, queste tre divinità sono caratterizzate anche da attributi che le qualificano quali creatori attraverso la Parola.
Il Mantra-Shastra afferma che Hamsa è il Purusha-Prakriti-Tattva. Ham è maschile o Shiva, Sah è femminile o Shakti. Shiva e Shakti sono quindi uniti in modo da simboleggiare l’Uccello Hamsa, la cui forma materiale somiglia a quella dell’oca. L’universo è composto e informato dalla coppia Hamsa, cioè Purusha (Shiva) e Prakriti (Shakti).
Esistono quattro Atma o anime del mondo:
- Atma: esso è Pranarupi, cioè Atma che si trova in tutte le cose come loro Prana. È Hamsa-Svarupi o Jivatma, manifestato dalla respirazione esterna e interna, viene paragonato all’etere in un vaso, che la ruota del vasaio separa da quello circostante, ma dal quale esso non si distingue più quando il vaso viene rotto.
- Jnanatma: è Saksakshirupaka, è ciò che è testimone del tutto e per mezzo del quale l’unità del tutto viene conosciuta. Si riflette nella buddhi (mente illuminata) e tuttavia se ne distingue per la sua propria forma.
- Antaratma: in questa parola “antar” designa l’Atma sottile che permea tutte le cose, la scintilla di Paramatma che dimora in tutte le forme (Antargata). È l’Hamsa noto solo agli yogi (asceti mistici). Il suo becco è Tara (Mantra OM), Shiva e Shakti sono i piedi.
- Paramatma: quando l’Hamsa noto solo agli yogi spiega le ali, vale a dire si manifesta, da esso nascono nel loro ordine tutte le forme della materia (bhuta), la radice delle quali è Citta, la Coscienza. Quando l’Hamsa diventa ultraterreno e assume la forma della dissoluzione, la sua natura di uccello scompare e di esso si può dire: Ecco il Paramatma.
In questa visione è significativo che la sacra sillaba OM corrisponda all’Atma sottile, cioè alla radice più profonda di tutti i fenomeni. È infatti la Parola (sillaba OM) a informare tutto l’universo, in quanto da OM tutto deriva, si tratta dell’unità di tutti i Veda.
I primi due sutra del Pūrvamīmāṃā così recitano:
aṭha aṭaḥ dharma jijñasa (1)
ora, quindi, (bisogna) indagare (sulla natura del) dovere
chodana lakṣanaḥ arthaḥ dharmaḥ (2)
il dharma o dovere è ciò che, essendo desiderabile, è indicato (o insegnato) tramite l’ingiunzione vedica.
Jaimini chiama dharma il dovere che deriva dalla ingiunzione vedica. Il termine sanscrito dharma indica di per sé l’ordine dell’universo, ciò su cui poggia tutto il cosmo. È significativo che il filosofo indiano lo faccia coincidere con quanto prescritto dai Veda.
Il dharma può essere definito come quella cosa desiderabile menzionata o stabilita dalle ingiunzioni vediche; vale a dire, ciò che l’ingiunzione vedica stabilisce come conducente a un fine desiderabile è il dharma; e da ciò consegue anche che l’ingiunzione vedica è l’unico mezzo per conoscere il dharma. Pertanto le tre idee trasmesse dal sutra 2 sono: (1) che il dharma è ciò che viene prescritto dai Veda; (2) che l’Ingiunzione vedica è l’unico mezzo per conoscere il dharma, e (3) che le ingiunzioni vediche sono assolutamente degne di fiducia. Pertanto, una volta definito il dharma, e trovato un mezzo valido e affidabile per conoscerlo, non può essere respinto come una non-entità.
Nel sutra 1, la parola aṭha, “ora”, è stata interpretata dagli esegeti come indicante la sequenza dello studio dell’intero Veda, e la parola aṭaḥ, “quindi”, come fornitrice della ragione per l’indagine proposta – perché l’intero Veda intende esprimere un significato; e sulla base di queste spiegazioni è stato proposto che la parola dharma, come contenuta in quel primo sutra, indichi l’intero Veda; ed è in vista di ciò che l‘indagine sul dharma è stata interpretata come “indagine sul significato dei Veda”.
Abbiamo un denso nucleo concettuale per il quale la Parola dei Veda, intesa come conforme al sacrificio, è allo stesso tempo e la ragione della creazione dell’universo e il suo ordine cosmoetico (dharma).
Uno dei vari termini vedici che si riferiscono alla “parola” è vip. Vip denota il meccanismo del pensiero vedico o, se si preferisce, le condizioni psicologiche della attività poetica. Si tratta, in senso stretto, del “tremore” oratorio, dell’ispirazione che “mette in moto” la poesia, senza che sia necessario ricercare sotto il termine, a tutti i costi, un valore mistico analogo allo spanda dei Kashmiri (cioè la “vibrazione” della Parola creatrice che mette in atto i mondi). Così la parola è detta vepi “tremante”, allo stesso tempo vakvari “impetuosa” quando cerca la sua strada verso Indra. Se questo è davvero il significato primario (piuttosto che l’idea di “evocazione magica”), in ogni caso vip e le parole del gruppo hanno valori indeboliti: vipra è l’oratore (sacro), l’officiante o il dio in quanto operatori della parola, vepas è il discorso. Il rsi (poeta vedico) è samavipra come il dio è gayatravepas, “che esprime la melodia” o “l’inno strofico”.
Quanto a vakvari, il termine si riferisce alla radice vac- (vacyate) che denota lo slancio, l’oscillazione della parola, matiḥ … vacyate Ṛg-Veda I.142.4 “la parola scaturisce”, matir hṛda vacyamana III.39.1 “la parola che scaturisce dal cuore”; oppure pensiamo ai sumati, le “poesie ben ordinate”: si dice che “acquistano il loro slancio attraverso il pensiero”, manasa vacydmanaḥ X.47,7. Questo è il significato figurato del significato di base, che è “galoppare”, e che abbiamo in vakvaḥ, X.148.5 applicato anche agli inni vedici.
Secondo noi la parola vedica ha questo carattere “vibrante”, “energico”, “impetuoso”, in quanto mette in moto l’essere della creazione. Ricordiamo che per la cosmogonia vedica la Parola è la prima manifestazione del Brahman: è pertanto dalla Parola che ogni cosa si squaderna.
Concetto simile a quello del Logos giovanneo, se vogliamo fare una incursione nel sistema semiotico giovanneo. Il Logos di Giovanni corrisponde alla emanazione sonora del Dio della Genesi (“Egli disse: Sia la luce, e la luce fu”). Veramente significativo è che il sacrificio di Cristo, detto Logos, si attua sulla croce per il perdono dei peccati, permettendo poi una nuova creazione mediante l’effusione dello Spirito.
Nel cristianesimo il vero sacerdote è Gesù Cristo, l’Uomo Dio sceso sulla terra per salvare l’umanità. Egli si offre a Dio Padre in sacrificio morendo sulla croce per il perdono dei peccati. Il sacrificio cruento è avvenuto duemila anni fa, ma in ogni Messa si compie il sacrificio non cruento.
Il sacerdote umano che spezza il pane e versa il vino consacrati offre in realtà il corpo e il sangue di Gesù Cristo a Dio Padre. Il sacerdote umano compie l’atto sacrificale “in Persona Christi”, vale a dire che il vero sacerdote è Cristo.
Gesù istituisce la Santa Messa durante la sua Ultima Cena in questo mondo, come ci tramandano i vangeli.
Gli studiosi hanno cercato di sviscerare quelle parole per carpirne il senso profondo. Secondo alcuni esegeti, il racconto di Luca della istituzione dell’Eucaristia si fa al modello-tipo del “testamento”. Secondo tali studiosi, nella letteratura antica ci sarebbe una struttura letteraria tipica, nella quale un personaggio importante si congeda dai suoi indicando le sue ultime volontà. Pensiamo ai patriarchi. Oppure pensiamo a Atti 20, 17-38: è il discorso di addio di Paolo a Mileto, nel quale gli anziani sono convocati ed egli annuncia la sua morte, si dilunga sulla sua vita esemplare, annuncia la venuta di falsi dottori, auspica la benedizione.
In questi modello-tipo del “testamento” vi è sempre una trasformazione: la persona importante se ne va da questo mondo e quelli che restano vengono trasformati.
Gli studiosi ravvisano nel racconto di Luca della istituzione dell’Eucaristia una corrispondenza forte con il modello del “testamento”. Leggiamo (Luca 22):
14 Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15 e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16 poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 17 E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, 18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio».
19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».
Gesù sta facendo un discorso di addio. È giunta la sua ora di dipartirsi da questo mondo e si congeda dai suoi. I vv. 14-18 rientrano nello schema del “testamento”: infatti non comprare la menzione del pane, Gesù quindi ancora non sta istituendo la Santa Messa ma si sta accomiatando dai suoi. Solo in seguito (vv. 19-20) Gesù presenta il pane e il calice come simboli del suo corpo.
Gli studiosi ravvisano enormi somiglianze nel racconto di Luca con il Testamento di Neftali, uno dei Testamenti dei XII Patriarchi, scritto apocrifo giudaico contemporaneo ai vangeli.
Corrobora questa interpretazione il fatto che in greco “nuova alleanza” si dice kainē diathēkē, dove il sostantivo diathēkē, “alleanza”, deriva da un verbo che vuol dire “fare testamento”.
Cosa sta effettivamente facendo Cristo? Diversamente da Marco, Luca utilizza non il futuro ma il presente: l’uso del verbo al presente (il corpo di Gesù è immolato, il suo sangue è versato) manifesta il carattere altamente simbolico dell’atto di Gesù. Inserendolo nel discorso di addio, QUESTO ATTO MIMA LA SUA MORTE.
Abbiamo a che fare con una grande trasformazione. Gesù sta facendo il suo testamento, pertanto Gesù nel dipartirsi vuole assicurare i suoi che egli sta ancora con loro e lo fa mediante la Eucaristia, che significa la morte di Cristo. L’Eucaristia è il suo corpo immolato ma vivo per i suoi. Quindi equivale a una presenza costante per la comunità dei credenti. Per questo Paolo dirà che la Eucaristia è “comunione” con il corpo di Cristo (1Corinzi 10, 16).
Infatti in Giovanni 6 Gesù pronuncia un discorso sul “pane vivo” che è il suo corpo. Egli poi parla del “pane della vita” (o artos tēs zōēs): l’articolo greco “della vita” (e non semplicemente “di vita”) indica che Cristo sta parlando della vita per eccellenza, quella eterna, pertanto il pane eucaristia opera una trasformazione mirabile, dà la vita eterna.
Gesù istituisce l’Eucaristia durante la celebrazione della Pasqua, in cui si immolava un agnello. I protestanti affermano che Gesù non sta istituendo un rito vero e proprio: infatti al tempo di Cristo i sacerdoti nel tempio si limitavano a macellare l’agnello, il quale era poi consumato nelle case con la benedizione del capofamiglia, pertanto, demandata a laici la cena pasquale, Cristo non avrebbe in mente un atto rituale vero e proprio.
In realtà Paolo getta una luce importante sul valore dell’atto sacrificale di Cristo. Leggiamo in 1Corinzi 11, 23-24:
23 Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso; cioè, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane 24 e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me».
Paolo sta parlando di una trasmissione: questa trasmissione si spiega solamente con un rito, formalizzato da Cristo e trasmesso ai suoi, arrivando fino a Paolo. E il rito, in quanto tale, è operato da funzionari del sacro.
Abbiamo un Dio talmente amorevole e misericordioso che decide di morire per la nostra salvezza e diventa ciba affinché noi, mangiandolo, abbiamo la vita eterna. Già il Salmo 103 proclamava un Dio così buono:
1 Di Davide.
Benedici, anima mia,
il SIGNORE;
e tutto quello ch’è in me, benedica il suo santo nome.
2 Benedici, anima mia, il SIGNORE
e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
3 Egli perdona tutte le tue colpe,
risana tutte le tue infermità;
4 salva la tua vita dalla fossa,
ti corona di bontà e compassioni;
5 egli sazia di beni la tua esistenza
e ti fa ringiovanire come l’aquila.
6 Il SIGNORE agisce con giustizia
e difende tutti gli oppressi.
7 Egli fece conoscere le sue vie a Mosè
e le sue opere ai figli d’Israele.
8 Il SIGNORE è pietoso e clemente,
lento all’ira e ricco di bontà.
9 Egli non contesta in eterno,
né serba la sua ira per sempre.
10 Egli non ci tratta secondo i nostri peccati,
e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe.
11 Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
12 Come è lontano l’oriente dall’occidente,
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
13 Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
così è pietoso il SIGNORE verso quelli che lo temono.
14 Poiché egli conosce la nostra natura;
egli si ricorda che siamo polvere.
15 I giorni dell’uomo sono come l’erba;
egli fiorisce come il fiore dei campi;
16 se lo raggiunge un colpo di vento esso non esiste più
e non si riconosce più il luogo dov’era.
17 Ma la bontà del SIGNORE è senza fine per quelli che lo temono,
e la sua misericordia per i figli dei loro figli,
18 per quelli che custodiscono il suo patto
e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti.
19 Il SIGNORE ha stabilito il suo trono nei cieli,
e il suo dominio si estende su tutto.
20 Benedite il SIGNORE, voi suoi angeli,
potenti e forti, che fate ciò che egli dice,
ubbidienti alla voce della sua parola!
21 Benedite il SIGNORE, voi tutti gli eserciti suoi,
che siete suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce!
22 Benedite il SIGNORE, voi tutte le opere sue,
in tutti i luoghi del suo dominio!
Anima mia, benedici il SIGNORE!
Cassirer considerava Niccolò Cusano come il filosofo rinascimentale più importante. Cusano scriveva che Dio non ha un nome proprio, ma in greco viene indicato con il termine theòs, che vuol dire vedo e corro. Questo termine greco è il nome di Dio solo per colui che lo ricerca in questo mondo. “Colui che ricerca deve quindi correre, mediante la vista, per potersi protendere” fino a Dio. Cioè dalle cose sensibili deve poi passare alla contemplazione di Dio.
Pensiamo perciò all’amore di una tenera madre: dalla vista di questa donna, passiamo all’amore che Dio ha verso tutti noi. Dio ci ama come una madre: infatti in ebraico rachamim indica la “misericordia” divina, ma vuol dire etimologicamente “viscere materne”.
Cristo è allo stesso tempo vittima e sacerdote per la salvezza dell’uomo!
Il sacrificio è l’atto di culto supremo, il più grande che l’uomo possa rendere a Dio. il sacrificio appartiene al senso religioso dell’uomo. Tutte le religioni contemplano il sacrifico. Il termine deriva dal latino sacrum + facere, dare a Dio ciò che di più caro abbiamo. In chiave cristiana, il sacrifico è offrire nientemeno che Dio, l’autore della vita.
Questo concetto è diventato estraneo al pensiero di oggi. Il concetto di sacrificio è connesso a quello di espiazione. Si sacrifica a Dio qualcosa per ottenere il perdono dei peccati.
Il peccato è una colpa che offende Dio, quindi il peccato abbisogna di una espiazione: la croce di Cristo è la espressione massima di espiazione.
In genere il sacrifico è inteso come distruzione di una realtà preziosa per l’uomo, distruzione mediante la quale egli intende trasferire tale realtà a Dio e riconoscere la sua sovranità. Ma tale distruzione non onora Dio. Salmo 50:
17 Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
18 poiché non gradisci il sacrificio
e, se offro olocausti, non li accetti.
19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi.
Il vero sacrificio quindi non consiste nella distruzione, ma nella trasformazione dell’uomo, cioè che egli stesso diventi conforme a Dio, se diventa amore. Agostino diceva (De Civitate Dei X.6):
Corrispondentemente è vero sacrificio ogni opera che fa sì che aderiamo a Dio in santa comunione.
In questa chiave Agostino interpreta i sacrifici dell’Antico Testamento come simboli di questo vero sacrificio. Tutte le molteplici prescrizioni sacrificali antiche devono dunque rimandare simbolicamente all’amore di Dio e del prossimo. L’amore è vero solo quando conduce l’uomo a Dio, solo così può essere autentico anche l’amore tra gli uomini. Così il concetto di sacrificio rinvia alla comunità. L’intera comunità umana redenta viene offerta a Dio come sacrificio mediante il sommo sacerdote (Cristo) che offrì sé stesso. L’intero sacrificio siamo noi stessi. È questo il sacrificio dei cristiani: i molti in un solo corpo, che è Cristo.
Il sacrifico è la assimilazione dell’uomo a Dio. Annullamento della differenza: Dio e uomo diventano una sola cosa.
Come si realizza l’unione con Dio nell’annullamento della differenza si realizza? Nelle religioni orientali si attua mediante l’annullamento della finitezza nell’oceano del totalmente Altro: liberazione che in definitiva si rivela come fine della illusione, la liberazione dell’io nella vera realtà, dove l’io è un illusione. Invece nella fede cristiana l’unità è vista come compartecipazione di amore in cui la diversità non è annullata ma trasformata nella unità superiore di coloro che si amano, così come viene prefigurata nella unicità trinitaria di Dio.
L’uomo non deve essere negato o sciolto, ma trasformato in una forma superiore di unione amorosa. Questa filosofia di libertà che sta alla base della fede cristiana include la possibilità del rifiuto: il male non è solo decadenza dell’essere, ma conseguenza di un uso indebito della libertà.
Bibliografia
- A. Avalon, La Ghirlanda delle Lettere. Studi sul Mantra-Shastra, Roma 2012;
- N. Cusano, La ricerca di Dio, I. 19;
- K. F. Geldner, Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt, vol. 1, Cambridge 1951;
- R. Guénon, La Grande Triade, Milano 1980;
- Jaimini, Pūrva Mīmāṃsā Sūtras, translated with an original commentary by Mahamahopadhyaya Pandit Ganganath Jha, Allahabad 1916;
- X. Léon-Dufour, Il pane della vita, Brescia 2006;
- G. Magi, “La filosofia del linguaggio eterno nel Pūrvamīmāṃā Sūtra di Jaimini”, in Studi Urbinati, Vo. 69 (1999), pp. 59-76;
- J. Ratzinger, Opera Omnia. Teologia della liturgia, vol. XI, Città del Vaticano 2010;
- L. Renou, Ètudes védiques et pāṇinéennes, vol. 1, Paris 1955;
- L. Renou, Ètudes védiques et pāṇinéennes, vol. 4, Paris 1958;
- L. Renou, Historie de la langue sanskrite, Lyon 1956;
- H. Zimmer, Miti e simboli dell’India, Milano 1993.