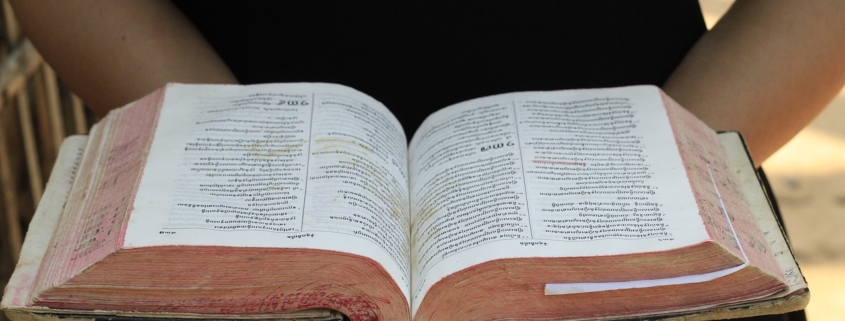Il fine dell’umanità, di Marco Calzoli
Leggiamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 22:
19Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».
Queste parole, pronunciate da Cristo nell’Ultima Cena, quando istituisce l’Eucaristia, sono cariche di significato. Occorre interpretarle secondo il contesto linguistico e culturale del tempo.
“Questo è il mio corpo”, nell’originale greco touto estin to sōma mou, è una espressione che non va intesa slegata dalle altre parole pronunciate. Gesù infatti, dicendo che il pane è il suo corpo, afferma anche che il corpo è “dato per voi”. Questo implica la natura relazionale dell’asserzione. Gesù vuole significare la comunione tra il suo corpo e i discepoli che ne mangiano, esattamente come dirà Paolo (1Corinzi 10, 16: “Il pane che noi spezziamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo?”). Quindi l’Eucaristia non è semplicemente un ricordo o un simbolo bensì la viva partecipazione a Cristo. Giovanni 6, 56: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui”.
Questa lettura viene corroborata dal fatto che per gli ebrei di allora il termine greco sōma, “corpo”, non indicava semplicemente l’involucro esterno ma la persona stessa. Quindi Cristo pone una relazione tra la sua Divinissima Persona e i discepoli che ne mangiano.
Inoltre abbiamo un’altra sfumatura. Il termine greco traduceva spesso l’ebraico basar, nel senso della fragilità creaturale. Per di più a volte il sostantivo sōma veicolava l’idea del cadavere. Pertanto Cristo si sta manifestando come una persona fragile, sul punto di morire. Ed è da questa fragilità che scaturisce il dono della vita ai suoi discepoli mediante il mangiare e il bere corpo e sangue. Giovanni 6, 53-55: “Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”.
Bisogna altresì collegare il gesto di Cristo del prendere il pane con il linguaggio profetico. I profeti dell’Antico Testamento compivano gesti “strani” per introdurre un evento futuro nel segno della efficacia. Mediante una azione simbolica il profeta non aveva in mente la semplice eventualità, bensì la piena efficacia: l’azione anticipa l’evento e in un certo senso lo produceva. Quando Geremia si pose sulle spalle un giogo per indicare che una dominazione straniera avrebbe pesato su Gerusalemme, i falsi profeti lo distrussero in fretta per impedire che ciò si realizzasse (Geremia 27-28).
Con queste chiavi quindi possiamo comprendere la portata della istituzione dell’Eucaristia di Cristo. Vi è piena identificazione tra quel pane e la persona di Cristo.
La chiesa da duemila anni afferma che Cristo è Dio, come annunciato anche da Tommaso in Giovanni 20: “Signore mio e Dio mio”. Egli per amore muore in croce come sacrificio di espiazione dei nostri peccati rivolto a Dio Padre. Questo sacrificio venne compiuto in modo cruento duemila anni fa, ma si rinnova in modo non cruento in ogni Santa Messa. Il sacerdote offre pane e vino, ma queste offerte diventano con la invocazione dello Spirito Santo (epiclesi) il vero e reale corpo di Cristo e il vero e reale sangue di Cristo. Pertanto la Messa è il sacrificio di Cristo a Dio Padre.
La chiesa tramanda che Dio è Uno e Trino: si tratta della Santissima Trinità. Non sono tre dei, ma un solo Dio in tre Persone (Padre, Figlio e Spirito Santo). Una sola sostanza divina ma in tre Persone divine. In ogni Persona divina vi è tutta la Divinità. Sono Persone uguali e distinte. Come è possibile? Si tratta di un mistero, quindi è incomprensibile alla mente umana. Una analogia, sempre imperfetta, può essere quella di un triangolo equilatero: abbiamo tre angoli e il triangolo è dato dalla somma di tutti e tre gli angoli, se ne togliamo uno il triangolo viene meno. Oppure pensiamo al sole e ai suoi raggi: sole e raggi sono la stessa cosa ma si tratta di elementi distinti. Si racconta che Agostino stava passeggiando sulla riva del mare cercando di capire il mistero della Santissima Trinità, all’improvviso gli apparve un angelo sotto le spoglie di un bambino che gli disse: E’ più facile mettere tutta l’acqua del mare in questa buca piuttosto che tu capisca cosa sia il Dio Uno e Trino.
Secondo una certa visione, il Padre è il Principium imprincipiatum, cioè Colui che genera eternamente il Figlio e non è generato. Il Figlio è il Principium principiatum, Colui che è eternamente generato dal Padre. Non abbiamo un prima e un dopo, ma una azione eterna svincolata dalle categorie del tempo e dello spazio. Lo Spirito Santo è il rapporto di amore tra il Padre e il Figlio. Lo Spirito Santo è la forza che rende possibile la comunicazione e l’unione tra le persone divine, permettendo loro di esistere in un’unica realtà divina. Etimologicamente il termine latino spiritus vuol dire “fiato”, allora lo Spirito Santo è come se fosse il sospiro di amore che si scambiano reciprocamente Padre e Figlio.
Le tre Persone della Santissima Trinità sono tra di loro relative, non possono essere separate nemmeno un istante. Il Figlio non c’è senza il Padre, il Padre non ha altra funzione che generare il Figlio e lo Spirito Santo è ciò che li lega con soave amore. I teologi quindi si riferiscono alle Persone indicandole anche come Relazioni.
I cristiani di Oriente fanno il segno della croce toccando il proprio corpo con le sole tre dita della mano destra, per esprimere il mistero del Dio Trino e Unico.
Ad un certo punto l’Unico Dio decide di estendere il suo amore a ciò che è fuori di sé e quindi crea il mondo. Il mondo si ribella con il peccato originale dei progenitori Adamo e Eva, quindi il Figlio si incarna nel mondo degli uomini diventando Gesù, il “Messia” atteso dagli ebrei, che in greco viene detto “Cristo”.
La Santa Messa è il rinnovamento fino alla fine del mondo della morte, risurrezione e ascensione al cielo di Gesù Cristo, il quale muore in croce per redimere il mondo dal peccato e dalle sue conseguenze (redenzione). E questo avviene esclusivamente per amore. Per questo Tommaso d’Aquino chiama la Eucaristia: Sacramento dell’Amore.
La rivelazione definitiva di Dio quale amore avviene nel Nuovo Testamento. 1Giovanni 4, 8: “Dio è amore”. Ma già nell’Antico Testamento vi era un preannuncio di questo grande mistero. Leggiamo nel Salmo 103:
1 Di Davide.
Benedici, anima mia,
il SIGNORE;
e tutto quello ch’è in me, benedica il suo santo nome.
2 Benedici, anima mia, il SIGNORE
e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
3 Egli perdona tutte le tue colpe,
risana tutte le tue infermità;
4 salva la tua vita dalla fossa,
ti corona di bontà e compassioni;
5 egli sazia di beni la tua esistenza
e ti fa ringiovanire come l’aquila.
6 Il SIGNORE agisce con giustizia
e difende tutti gli oppressi.
7 Egli fece conoscere le sue vie a Mosè
e le sue opere ai figli d’Israele.
8 Il SIGNORE è pietoso e clemente,
lento all’ira e ricco di bontà.
9 Egli non contesta in eterno,
né serba la sua ira per sempre.
10 Egli non ci tratta secondo i nostri peccati,
e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe.
11 Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
12 Come è lontano l’oriente dall’occidente,
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
13 Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
così è pietoso il SIGNORE verso quelli che lo temono.
14 Poiché egli conosce la nostra natura;
egli si ricorda che siamo polvere.
15 I giorni dell’uomo sono come l’erba;
egli fiorisce come il fiore dei campi;
16 se lo raggiunge un colpo di vento esso non esiste più
e non si riconosce più il luogo dov’era.
17 Ma la bontà del SIGNORE è senza fine per quelli che lo temono,
e la sua misericordia per i figli dei loro figli,
18 per quelli che custodiscono il suo patto
e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti.
19 Il SIGNORE ha stabilito il suo trono nei cieli,
e il suo dominio si estende su tutto.
20 Benedite il SIGNORE, voi suoi angeli,
potenti e forti, che fate ciò che egli dice,
ubbidienti alla voce della sua parola!
21 Benedite il SIGNORE, voi tutti gli eserciti suoi,
che siete suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce!
22 Benedite il SIGNORE, voi tutte le opere sue,
in tutti i luoghi del suo dominio!
Anima mia, benedici il SIGNORE!
Cristo è l’Uomo Dio sceso sulla terra per salvarci dalle opere del demonio, che ha fatto peccare i progenitori. Quindi Cristo è il Mediatore tra noi e Dio Padre. Per l’evangelista Giovanni Cristo è in greco il Logos, la Parola, che è all’inizio e è all’origine di tutto. In arabo il termine masdar, che indica un nome verbale paragonabile al nostro modo infinito, significa etimologicamente “fonte”, “origine”, come a dire che la parola è alla base di tutto. La prima lettera dell’alfabeto ebraico è la Aleph, che è scritta con quattro braccia come ad abbracciare tutto il mondo.
Ma la chiesa rivela che la Vergine Maria, la Madre di Cristo, che concepì il Salvatore per opera dello Spirito Santo, è la Mediatrice tra noi e Cristo.
Il matrimonio ebraico prevedeva due fasi: nella prima la sposa dava il consenso, sancendo l’efficacia del negozio; nella seconda fase avveniva la coabitazione con il marito. Durante la prima fase la sposa stava ancora sotto la tutela della famiglia di origine e dopo un anno avveniva la seconda fase. Secondo la prassi del tempo, Maria doveva essere alquanto giovane, infatti il Talmud dice che una fanciulla è pronta al matrimonio allo spuntare del primo pelo. Secondo i vangeli, Maria quando ricevette l’annuncio dell’angelo che sarebbe diventata madre per opera dello Spirito Santo, stava nella prima fase del matrimonio con Giuseppe, quindi era legalmente sposata ma non era ancora andata a convivere con il marito. Pertanto era vergine. La chiesa afferma che Maria è stata vergine prima, durante e dopo il parto (per questo in Oriente si raffigura Maria con un manto avente tre stelle). I Padri della Chiesa dicevano che il concepimento di Gesù operato dallo Spirito avvenne in un modo insolito, alcuni dicono “per aurem”, cioè attraverso l’orecchio. Il giusto Giuseppe è stato il padre putativo di Gesù, avente esclusivamente il compito di mantenerlo e di educarlo.
In Luca 1, 28 Maria viene definita in greco kecharitōmenē, che la CEI traduce “piena di grazia”. Il verbo greco contiene la parola charis, “grazia”. Questo attributo può spiegarsi in varie maniere. Stando al sostrato biblico, il sostantivo charis veniva impiegato per tradurre anche l’ebraico hesed, l’amore misericordioso di Dio verso le sue creature: allora Maria sarebbe una privilegiata da Dio, su di essa Dio riversa tutto il suo amore. Invece stando al contesto ellenistico charis potrebbe assumere anche un altro significato. Gli antichi greci, infatti, adoperavano la parola charis per indicare la preparazione della fanciulla al matrimonio. Allora l’evangelista Luca vuole allude al fatto che Maria, essendo salutata così dall’angelo, era adatta, pronta per il matrimonio? E quale matrimonio? Quello umano o quello divino?
Nel vangelo secondo Luca l’angelo non la saluta con lo Shalom ebraico, Pace, bensì con un termine greco, chaire, che etimologicamente vuol dire Rallegrati. Certamente al tempo dell’evangelista Luca il saluto chaire era stereotipato, corrispondeva il più delle volte a un semplice “salve”, ma se l’angelo avesse voluto intenderlo nel senso etimologico, allora avrebbe voluto indicare che Maria partecipa della gioia messianica, come quando i profeti annunciavano ad Israele una grande gioia per la venuta del Messia.
Il Concilio Vaticano II afferma che Maria è la Figura della chiesa. Molti teologi asseriscono che tutto quello che si può dire di Maria, si può dire anche della chiesa.
La chiesa è il corpo mistico di Cristo, mentre Egli ne è il capo: si tratta del mistero che Agostino chiamava Christus Totus, Cristo Totale, vale a dire caput et corpus. E Maria è il collo, che unisce il capo alle sue membra. L’immagine del “collo” di Maria è spesso associata alla invocazione di Torre d’avorio e alla frase “Collum tuum ut colonna” del Cantico dei Cantici 7, 5 (“il tuo collo come una colonna”, che nell’originale ebraico suona ṣawa’rek kemigddal). Questa simbologia sottolinea la purezza e l’eleganza di Maria, che è vista come un ponte tra il divino e la creazione. Ancora, Maria è l’acquedotto (Bernardo di Chiaravalle) dalla quale ci provengono tutte le grazie che Dio riversa quotidianamente su tutti gli esseri umani e il creato intero.
La chiesa insegna che tutte le grazie che Dio dà agli uomini provengono dalla Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, in cui si consuma quotidianamente il mistero della nostra salvezza. Ma le grazie hanno un canale per arrivarci: questo canale è Maria Santissima.
Per questo, come diceva Paolo VI, non si può essere cristiani se non mariani. La bolla papale Dominici Gregis venne emessa da papa Clemente VIII il 3 febbraio 1603 e considera la pietà mariana come la base per la chiesa.
La preghiera più importante del cristiano è la Santa Messa, al secondo posto si colloca il Rosario alla Beata Vergine.
Secondo lo storico francescano Padre Luke Wadding (1588-1657), l’origine della parola “rosario” per indicare la corona di preghiere rivolte a Maria, risale al XV secolo. Nel 1422, la Beata Vergine Maria apparve a un novizio francescano di nome Giacomo. Fin da bambino, Giacomo era solito offrire quotidianamente una corona di rose alla Vergine Maria. Tuttavia, quando entrò nei Frati Minori, dovette a malincuore abbandonare questa consuetudine per dedicare tutto il suo tempo alla comunità francescana. Per dargli conforto, la Madonna si rivelò al novizio confidandogli che avrebbe potuto continuare ad omaggiarla in un modo diverso: invece di tessere una ghirlanda di fiori, avrebbe potuto recitare ogni giorno un Rosario di sette decine che meditava sulle “sette gioie” della Madre di Dio. Il giovane novizio introdusse questa pratica tra gli altri frati. Fu così che si diffuse in tutto l’ordine francescano.
La santa Gertrude di Helfta ebbe una visione: Maria in trono e da lei dipartirsi una miriade sconfinata di angeli pronti a soccorrere quanti la invocano. Pio da Pietralcina affermava che il Rosario è l’Arma contro gli assalti del demonio. I santi dicono che il Rosario difende soprattutto la famiglia. La Madonna che appare a Medjugorje rivela che con la preghiera si possono sconfiggere anche le guerre e alterare persino le leggi della natura.
La battaglia di Lepanto (1571) fu vinta dai cristiani contro i musulmani, che intendevano venire a conquistare l’Europa per far finire la nostra civiltà, per mezzo del Santo Rosario e da lì Maria venne invocata come Auxilium Christianorum, Aiuto dei cristiani. Papa Leone XIII faceva iniziare la sua lettera enciclica Supremi Apostolatus del 1 settembre 1883 con queste parole:
“Dall’ufficio del Supremo Apostolato che esercitiamo, e dalla condizione durissima di questi tempi siamo ogni giorno più stimolati e quasi sospinti a provvedere con tanta maggiore sollecitudine alla tutela e all’incolumità della Chiesa quanto più essa è travagliata da gravi calamità. Perciò, mentre Ci sforziamo, per quanto Ci è possibile, di difendere in tutti i modi i diritti della Chiesa, e di prevenire e respingere i pericoli che sovrastano o ci circondano, non desistiamo dall’implorare i celesti soccorsi, dai quali unicamente Ci possiamo attendere che le Nostre cure e le Nostre fatiche raggiungano il desiderato scopo.
Per ottenere questo, nulla stimiamo più valido ed efficace che di renderci degni, con devozione e pietà, del favore della Gran Madre di Dio Maria Vergine, la quale, come mediatrice della nostra pace presso Dio e dispensatrice delle grazie celesti, è collocata in cielo nel più eccelso trono di potere e di gloria, perché conceda il suo patrocinio agli uomini, che fra tante pene e pericoli si sforzano di giungere alla patria sempiterna”.
La chiesa è guidata da Dio e per essa intercede la Santa Madre Maria, ma la chiesa è afflitta dal peccato. Perché? Ci rifacciamo al riguardo a una interessante riflessione del grande teologo Romano Guardini. Egli scriveva in una delle sue opere più celebri che la chiesa è Cristo stesso che si è fatto carne, cioè si è calato nella storia. Ora, la storia è il dominio del corpo ed è pervasa dalla imperfezione della creaturalità umana e del peccato. Tutti noi vorremmo una chiesa senza imperfezioni, ma la chiesa non è questo. È una eresia volere una chiesa di perfetti, la propugnavano i catari, ma l’uomo è limitato e peccatore. Duole sempre rinunciare alla chiesa delle ideali, alla chiesa estatica, alla chiesa dei puri, alla chiesa dei santi, ma fin quando l’uomo sta sulla terra è sempre in bilico tra bene e male. La chiesa è Santa in quanto assistita dallo Spirito di Dio, ma è formata da uomini, imperfetti e peccatori. Anche la chiesa delle origini era dilaniata da controversi interne e da falsi maestri e da cristiani oltremodo peccatori, pensiamo solo alla comunità di Corinto contro la quale scriveva Paolo. Ma è Cristo che ha scelto uomini per fare la propria volontà entro la storia. Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega tre volte, davanti alla croce scappano quasi tutti, Tommaso non crede nella risurrezione del Maestro. Prima ancora, durante il ministero pubblico, la famiglia di Gesù voleva venirlo a prendere per farlo desistere.
Guardini scriveva che i difetti degli uomini di chiesa sono i chiodi che crocifiggono Cristo. Ecco le sue parole:
“E chi vuole Cristo deve pretendere anche la sua Croce: non possiamo distaccarlo da essa. È stato detto che noi verremo a capo dei difetti della Chiesa solo quando ne intuiremo il senso. Forse il senso è questo: i suoi difetti devono crocifiggere la nostra fede, affinché cerchiamo Dio e la nostra salvezza, e non noi stessi”.
La chiesa insegna che Maria è lo specchio che riflette perfettamente Dio. Essa viene invocata come Speculum Iustitiae. Il latino è una lingua pregnante, la parola iustitia non ha a che fare solo con i tribunali, ma soprattutto con la perfezione, è “giusto” ciò che è compiuto, fatto alla maniera giusta, e la cosa più “giusta” di tutte è la santità in quanto rispecchia Dio.
Maria è la creatura più eccelsa che Dio ha creato e che Egli nella sua onnipotenza ha prescelto come “necessaria” alla redenzione. Infatti Maria ha collaborato in maniera singolare al mistero di Cristo in terra. Maria prefigura ciò che sarà l’umanità santa in paradiso, fino ad allora gli esseri umani scriveranno sempre storto, sebbene Dio vi riesca a scrivere dritto al medesimo tempo.
In definitiva è questo il mistero dell’umanità. Dio sceglie di espandere il suo amore intra-divino alle sue creature (soprattutto angeli e uomini) e innalza gli uomini a un rango divino, superiore a quello degli angeli. E ciò avviene nonostante i peccati dell’umanità. Ogni uomo è per natura meritevole di condanna, come scriveva Paolo, ma è Dio che sceglie di salvarci gratuitamente, anche se vuole che corrispondiamo con le buone opere al suo disegno di amore.
Il fine ultimo della creazione e della redenzione è quello di innalzare l’essere umano alla natura divina. È un mistero contemplato soprattutto dalle chiese orientali. Ogni uomo redento e salvato parteciperà alla natura divina nella visione beatifica finale di Dio in paradiso.
Questa esistenza terrena è un viaggio verso Dio, verso il paradiso. In arabo la parola qarib significa “barca”, ha dato origine al nostro termine “caravella”: qarib deriva da un verbo arabo che significa “avvicinarsi”, che si ritrova anche in ebraico nel sostantivo kerub, il Cherubino, il quale sta vicino a Dio. Anche noi siamo esseri spirituali, come gli angeli, abbiamo infatti un’anima, ma siamo incarnati in un corpo. Non possiamo esistere compiutamente senza il corpo, quindi il fine della vita è la risurrezione con un corpo glorioso, spirituale, alla fine dei tempi. Se la nostra anima è spirituale, il fine ultimo della nostra vita è accedere, avvicinarci alle realtà spirituali, come fossimo angeli, adorando Dio, anzi divenendo simili a Lui.
Ci sarà una identificazione finale tra Dio e l’uomo, che è già presente in questa dimensione terrena. Il paradiso, nel quale vanno le anime salvate, spesso dopo essere passate per la purificazione del purgatorio, non è la eterna gioia, ma solo una gioia imperfetta. Essa si concluderà alla fine dei tempi con la risurrezione dei corpi per godere eternamente anche con il corpo (o per soffrire eternamente anche con il corpo in una risurrezione di condanna all’inferno). In attesa della fine del mondo sono risorti con il corpo solo due persone: Gesù e Maria.
Quale grande dignità ci dona il nostro battesimo se ci inserisce nel gregge degli eletti! Non solo amare Dio per l’eternità ma diventare addirittura divini in paradiso. E già su questa terra i redenti sperimentano un assaggio di tanta grandezza. Infatti Agostino scriveva (Commento al vangelo di Giovanni, tr. 18, 10):
“Rientrate nel vostro cuore! Dove volete andare lontani da voi? Andando lontano vi perderete. Torna, torna al cuore… Rientra nel cuore: lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l’immagine di Dio; nell’interiorità dell’uomo abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo l’immagine di Dio: nella di lui immagine riconosci il tuo Creatore”.
Con quanto amore ci ha amati Dio! E noi quanto gli siamo ingrati! Dio non tollera la bestemmia in quanto Egli ci ama di amore eterno (Geremia 31). Cristo è Sedes Amicitiae, Sede dell’Amicizia. I santi affermano che Dio non tradisce mai i suoi, anche se sono provati. Infatti “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Romani 8, 28).
In arabo il sostantivo ṣadiq significa “amico” e deriva da un verbo arabo che significa “dire la verità”. Il vero amico è colui che non mente, che non tradisce. Questo si può dire eminentemente e perfettamente solo di Dio. L’amore umano è debole e scostante, c’è e in un attimo svanisce o si raffredda, invece Dio non tradisce mai chi gli è fedele.
Lungo la storia Dio non si manifesta direttamente se non a pochi prescelti, al resto del mondo si rivela mediante la sua chiesa. Il compito della chiesa è quello di annunciare a tutti un Dio di amore eterno! Dopo averlo conosciuto, l’uomo inizia ad amarlo e decide di vivere una vita di grazia con i sacramenti, fino alla eterna liturgia nel cielo.
Esiste una sola chiesa ma in due dimensioni: quella terrena e quella trionfante. Quest’ultima è costituita dalle anime sante che vedono Dio e cantano le sue lodi e intercedono per la chiesa ancora pellegrinante sulla terra. Anche la nostra preghiera può alleviare le pene delle anime sante del purgatorio. Questo mistero di unione tra cielo e terra si chiama “comunione dei santi”.
E’ la grazia di Dio che fa nascere i cristiani nell’acqua del battesimo, mediante la intercessione di Maria, Madre della Chiesa. La grazia viene prima di tutto. Solo dopo l’uomo deve corrispondere al dono della redenzione con una vita santa in una continua e ferma decisione verso il bene, nella pratica dei sacramenti e delle virtù.
La tradizione cristiana contempla la Pietà come un dono dello Spirito Santo: si estrinseca nella assidua preghiera e frequenza dei sacramenti. Collegato a quest’ultimo è il Santo Timore di Dio: che non è paura ma rispetto verso la grandezza dell’Onnipotente, atteggiamento che spinge a pregarlo e a fare la sua santa volontà. Questo mediante la Fortezza, che ci fa respingere quanto è contrario al divin volere e ci fa scegliere continuamente il bene.
Altri doni dello Spirito Santo non meno importanti, quindi necessari per adorare Dio nella religione, sono:
- Intelletto: ci permette uno sguardo contemplativo sulle realtà della fede, senza emettere un giudizio su di esse.
- Sapienza, Scienza e Consiglio ci fanno emettere giudizi sulle realtà divine. La prima ci abilita a dare un giudizio in via preliminare sulle cose divine, per quanto possibile a uno spirito incarnato come l’uomo (nella deliziosa opera spirituale medioevale intitolata La nube della non conoscenza, XLVII, è scritto che “ogni cosa del corpo è per natura più distante da Dio di qualunque cosa dello spirito”). La Scienza ci abilita a dare un giudizio sulle cose create, ma considerate dal punto di vista di Dio, in quanto ci conducono a Dio. Il Consiglio ci abilita a dare un giudizio sulla volontà di Dio da compiere su questa terra.
Se questi sono doni dello Spirito Santo, per riceverli bisogna essere in grazia di Dio. Pertanto se l’anima è sotto la potenza del male mediante il peccato mortale, non si può praticare la religione. Lo Spirito Santo non riversa sull’anima i suoi santi sette doni. Il peccato rende l’anima una immagine di Satana.
Questi sette doni dello Spirito Santo sono il completamento delle tre virtù teologali (fede, speranza, carità). Queste ci vengono donate mediante il battesimo e perfezionate mediante la cresima.
È un dono soprannaturale partecipare ai frutti della redenzione e andare alla Santa Messa. È sempre Dio che fa il primo passo donandoci la capacità di aprire il cuore a Lui. Solo in un secondo momento l’uomo deve corrispondere liberamente a tanto amore riversato nell’anima.
Bibliografia
- X. Léon-Dufour, Il pane della vita, Brescia 2006;
- G. Greshake, Il dio unitrino. Teologia trinitaria, Brescia 2018;
- L. M. Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione a Maria, Ancora 1995;
- R. Guardini, La realtà della Chiesa, Brescia 2021.