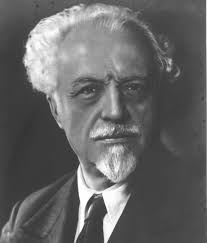Relazione conclusiva del professor Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, al convegno su Marcello Soleri
Pubblichiamo la sintesi della relazione conclusiva del professor Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, al Convegno su Marcello Soleri promosso dal Centro Pannunzio a Torino il 13 ottobre 2025 e a Roma il 23 ottobre.
Le relazioni e i contributi a distanza hanno offerto l’opportunità di focalizzare a pieno la figura di Marcello Soleri. Io mi limiterò ad alcuni ricordi. Voglio partire dal dire, per la prima volta, che insieme all’amico Piero Ostellino avevamo programmato una nuova biografia di Soleri che partisse da quella, in effetti un po’ datata, di Raimondo Collino Pansa, che resta anche oggi una miniera di notizie sullo statista cuneese. Iniziammo il lavoro che la morte di Ostellino interruppe e non ritenni di trovare qualcun altro perché l’autorevolezza di Ostellino — piemontese, liberale, saggista — non era rimpiazzabile. Resta il fatto che Soleri va fatto conoscere, come fece Antonio Patuelli con la pubblicazione delle Memorie, che diede un impulso agli studi soleriani. Entrando nel tema del ricordo di Soleri, voglio sottolineare che il suo liberalismo non fu mai dottrinario, ma pragmatico, con un richiamo etico che può giustificare l’idea secondo cui Soleri rappresentò un liberalismo che partiva da Giolitti, ma andava anche oltre Giolitti. Nel 1925, cent’anni fa, uscì la Storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggiero, che colse la profonda crisi del liberalismo italiano e la sua inadeguatezza rispetto a quello europeo.
Le riforme elettorali, in primis quella del suffragio universale maschile del 1912, seguita dall’introduzione del sistema proporzionale dopo la guerra, avevano posto le basi per la fine di un’egemonia liberale, facendo crescere socialisti e popolari in Parlamento. I comitati elettorali giolittiani non bastavano più e il Partito liberale venne fondato nel 1922, l’anno della Marcia su Roma. Sarebbe stato necessario un governo di coalizione democratica con liberali, socialisti e popolari, anche come risposta al fascismo trionfante favorito dal Biennio Rosso. Soleri era ben consapevole di questa situazione e la sua posizione netta contro l’attendismo inerte di Facta dimostra la sua realistica visione politica, unica nel variegato panorama liberale. Neppure Giovanni Amendola ebbe la lucidità politica di Soleri. La mancanza di coerenza nei confronti del fascismo, nell’illusione di costituzionalizzarlo, fu un grave errore nel quale Soleri non cadde. Anche l’avversione all’Aventino, da parte dello statista di Cuneo che riteneva che la battaglia dopo il delitto Matteotti dovesse essere condotta in Parlamento, è un altro aspetto della sua scelta politica realistica. Voglio inoltre ricordare un fatto finora quasi ignorato dagli storici: i due liberali piemontesi, Soleri e Gobetti, non ebbero mai rapporti. Come mi disse Manlio Brosio, ex gobettiano, Gobetti considerava Soleri un giolittiano e come tale da criticare, secondo la visione salveminiana ed einaudiana del giolittismo inteso come trasformismo corruttore.
Soleri vedeva in Gobetti un giovane di eccezionale intelligenza, ma privo di senso politico. Nelle Memorie Gobetti è totalmente ignorato. Gobetti era fortemente critico nei confronti del Risorgimento; Soleri viveva nel culto del Risorgimento. Guardava a Sella, a Lanza, al rigore dei conti, alla probità personale della Destra storica. In questo si sentiva profondamente piemontese, pur rifiutando il gretto piemontesismo di Cajumi. Parlava spesso in dialetto piemontese; nel 1944 fondò a Roma liberata la Famija Piemonteisa di cui fu primo presidente. Alla sua morte, nel 1945, divenne presidente Luigi Einaudi. Soleri amava Cuneo e il Piemonte, ma sarebbe un grave errore accomunarlo con certo piemontesismo che lo ha ignorato perché non ascrivibile a una cultura provinciale molto limitata. Quando nel 1944 tornò ad essere ministro del Lavoro, si dedicò con assoluta responsabilità a salvare l’economia italiana distrutta dalla guerra, dalla sconfitta e dalla guerra civile. Non si lasciò distrarre dalle polemiche istituzionali presenti nel CLN, pur avendo denunciato le responsabilità della Monarchia per i cedimenti al fascismo e per la connivenza col regime nella guerra che aveva portato al disastro.
Soleri, seguendo il magistero di Croce, fu contro il settarismo del Partito d’Azione, anche quando fu nel governo Parri. Una inedita testimonianza di Leone Cattani lo documenta in modo ineccepibile. Fu Cattani a far cadere Parri, nello stesso 1945. Il più forte legame politico Soleri lo ebbe con Manlio Brosio, ministro della Guerra come lo era stato lui nel 1922. Brosio mi parlò spesso con ammirazione di Soleri. Fu inoltre molto distante da Franco Antonicelli, da poco presidente del CLN piemontese, che pure parlò ai suoi funerali. Soleri poteva essere il nuovo leader liberale, anello di congiunzione tra passato e presente, ma la morte impedì questa ipotesi. La classe dirigente liberale, dopo la Liberazione, si rivelò inadeguata, divisa tra Nord e Sud e dalla questione istituzionale. Pannunzio raccontava la sua grande stima per Marcello Soleri. Salvemini definì Giolitti “il ministro della malavita”, anche se poi prese atto del clamoroso abbaglio, specie da parte di uno storico come lui. Io concluderei questo mio intervento dicendo che Soleri fu il ministro della buona vita. Mario Soldati girò un suo film nei locali del ministero occupato da Soleri, che il regista incontrò più volte. Soldati lo descrisse in un suo articolo, parlando di uno straordinario personaggio che sembrava venuto dal Risorgimento.