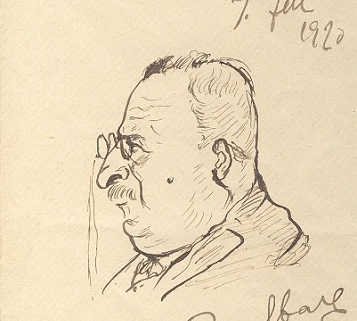La storia nel pensiero di Benedetto Croce, di Guido Gandolfi
La storia è storia della libertà: il filosofo abruzzese afferma che la libertà è “l’eterna formatrice per la storia, soggetto stesso di una storia”.[1]
Il problema della storia è stato approfondito nei testi Teoria e storia della storiografia risalente al 1917, La storia come pensiero e come azione scritto nel 1938, Storiografia e idealità morale del 1950; nel testo Primi Saggi,risalente al 1951, egli sostiene che siamo noi stessi i protagonisti della storia, una volta che abbiamo preso atto delle condizioni obiettive nelle quali ci troviamo; con il bagaglio dei nostri ideali, delle nostre azioni, delle sofferenze, costruiamo la storia, senza addossare a Dio o all’Idea le responsabilità.[2]
Dagli studi di Hegel, Croce accetta la lezione immanentistico-storicistica che si esprime attraverso “il rifiuto di ogni metafisica trascendistica, e l’identificazione della realtà con il processo dinamico e razionale dello Spirito” a cui si aggiunge il principio in base al quale la caratteristica peculiare del “pensiero filosofico consiste nell’essere concetto, universale e concreto”.[3]
Croce è in sintonia con Hegel nell’istante in cui afferma che “la Storia è storia della libertà”; la libertà svolge una funzione di eterna formatrice dello Spirito il quale si configura come “soggetto stesso di ogni storia”. La libertà si identifica con la vita dello Spirito che si sviluppa attraverso contrasti e opposizioni. “La libertà non può vivere diversamente da come vissuta e vivrà sempre nella storia”.[4]
Il filosofo tedesco scrive che lo Spirito è storia e questo risponde a criteri di razionalità per cui risulta valida l’equazione storia = realtà = Spirito = razionalità. È fondamentale valorizzare il presente per orientare all’azione pratica tenendo conto dell’importanza del passato. Alla luce della riflessione hegeliana Croce sottolinea il fatto che “tutto è spirito e che il farsi dello spirito è storia”: questa tesi si coniuga pienamente con una metafisica immanente cioè una teoria della totalità del reale denominata Storicismo assoluto; esso presenta in sé un chiaro immanentismo: “la vita e la realtà sono storia e nient’altro che storia”; è uno scenario, questo, nel quale lo Spirito si coniuga con la dinamica storica, mentre la filosofia si identifica con la metodologia dello studio della storia.[5]
La caratteristica essenziale dello Storicismo assoluto è l’identificazione fra la realtà, intesa come Spirito assoluto e la storia intesa come l’Assoluto nel suo divenire; non si può parlare di relativismo nel momento in cui si parla di carattere assoluto dello Spirito che si realizza nella storia” e nel momento in cui si rifiuta l’idea che sia presente un mondo di valori che sta al di sopra del mondo storico. Tutto deve essere interpretato come storia.[6]
Nel testo Teoria e storia della storiografia, il filosofo, in riferimento allo storicismo, afferma che la storia, che è l’insieme delle res gestae, deve essere interpretata come“l’infinito sviluppo dello spirito” mentre la storiografia cioè l’historia rerum gestarum che rappresenta la storiografia, deve essere valutata in termini di manifestazione dello sviluppo dello Spirito stesso. La storia è da considerarsi storia dell’Universale che è lo Spirito e non come semplice storia universale.
La storiografia ha come obiettivo l’indagine su problemi concreti e particolari, problemi che nascono nella mente dello storico che risponde ai suoi interessi e ai problemi che egli si pone.[7]
Un problema nodale della teorizzazione di Croce è quello della “vera conoscenza”: emerge una identificazione tra vera conoscenza e conoscenza storica mentre c’è una identificazione tra filosofia e la storia. Le cause affondano le loro radici nel fatto che lo Spirito si caratterizza per essere un insieme di conoscenza e di volontà, e quindi lo Spirito è un insieme di pensiero e azione. La storia è, pertanto, “vera conoscenza dell’universale concreto e del concetto puro”. Qualsiasi cosa a cui facciamo riferimento risulta essere una attività dello Spirito ed è da considerarsi un divenire. “La storia è quindi uno sviluppo logico e necessario, perché lo spirito è razionalità e lo spirito è storia”. Tutto ciò che accade deve necessariamente avvenire.
Croce crede nel “progresso” inteso come spirito che rivive continuamente gli stessi momenti; concorda con Hegel sul fatto che lo Spirito, nell’istante in cui agisce, porta con sé il peso di tutto il percorso che ha fino ad allora compiuto.[8]
Il significato della storiografia è rappresentato dalla conoscenza dell’universale concreto, dalla conoscenza della vita dello Spirito; esso si esprime attraverso forme teoretiche e pratiche tanto sul piano del pensiero quanto sul piano delle pratiche economiche e nell’azione morale.[9]
La storia non deve subire il giudizio della storia; quello che è importante è la conoscenza e l’approfondimento del significato della dinamica dei fatti storici: “la storia non è giustiziera, ma è sempre giustificatrice di ciò che è avvenuto”. Affiora la tesi della positività della storia intesa come conseguenza della razionalità che la contraddistingue; è la razionalità che consente di capire il movimento storico nella sua dinamica evolutiva e di individuare la funzione significativa senza farsi condizionare da un giudizio di natura etica.[10]
Un’altra caratteristica peculiare che caratterizza la storia è la “contemporaneità della storia”; ogni storia, infatti, deve essere analizzata come storia contemporanea in quanto, anche se gli eventi storici analizzati sono molto lontani sotto il profilo cronologico, la storia riflette sempre le necessità del presente. Le fonti della storia, documenti o resti, hanno la funzione di stimolare nello storico stati d’animo che sono già connaturati a lui.[11]
Ciascuno storico studia sempre partendo da interessi che costituiscono il suo presente; non si interroga per caso una epoca storica piuttosto che un’altra se non si è convinti che in qualche modo quel passato abbia a che fare con questo presente.
Se la vera conoscenza viene condizionata dalla storia, allora, anche la filosofia è storia. La storia, nell’istante in cui si approfondisce la conoscenza dei fatti, rivela all’uomo le modalità in cui l’uomo stesso deve realizzare quegli eventi; l’uomo, se è in sintonia con questa modalità di azione, è in grado di produrre un’azione morale.[12]
Croce si oppone alla cultura positivistica che sosteneva la tesi che la storia rappresentasse una scienza del passato; al contrario è l’interesse per la vita presente che spinge l’uomo attuale ad approfondire un evento storico che appartiene al passato. Emerge, inoltre, una critica nei confronti della storia universale interpretata come raccolta del maggior numero possibile di eventi storici senza porsi il problema del collegamento che ciascuno evento possa avere con l’attuale vita dello Spirito. C’è, nella concezione crociana della storia, il riferimento alla vita dello Spirito nella sua concretezza, intesa come base della storiografia.[13]
Un problema di grande interesse è la identificazione della storia con la filosofia; la filosofia o logica è la “scienza del concetto puro”, è “conoscenza intellettuale, conoscenza dell’universale, produttrice di concetti”. La filosofia, quindi, ha la dignità di vera scienza e il suo oggetto è il concetto puro.[14]
Nella teorizzazione crociana è centrale il concetto di identità tra filosofia e storia. La filosofia si caratterizza, come si è visto, per essere la “conoscenza dell’universale concreto” che presenta una dinamica evolutiva nel tempo; la filosofia è la conoscenza dei vari concettiinterpretabili come categorie dello Spirito, viste nella loro forma concreta. “La filosofia è conoscenza della modalità di espressione dello Spirito in forme diversificate; essa, in quanto studio dei problemi che la storia quotidiana propone all’uomo, è storiografia”. La filosofia che si identifica con la storiografia rivela uno dei punti più qualificanti della teorizzazione crociana che ha consentito di approfondire la discussione sulle problematiche reali che quotidianamente interessano l’uomo.[15]
Nella identità di storia e filosofia si deve “ricercare, infine, la incongruenza teorica di ogni “filosofia della storia”, che pretenda di conferire ai fatti un valore da essi diverso e trascendente, di presentare cioè i fatti come il necessario manifestarsi di un’idea o di un valore: determinismo, finalismo, irrazionalismo sono pertanto tutte pseudo-categorie storiche, che la vera storiografia respinge da sé. In questo contesto la filosofia non è altro che “metodologia della storia”, delucidazione delle categorie del comprendere storico”.[16]
Il rapporto fra vita dello Spirito e azione morale è un argomento di indubbio fascino: la vita dello Spirito è l’atto di affermazione della libertà, la quale deve essere viene analizzata alla stregua di una realtà che prende origine dall’azione morale; il bene deve essere interpretato come volontà libera dello Spirito orientato alla realizzazione del bene universale. Il significato del sostantivo “male” si riduce ad una mancanza dello Spirito.[17]
Il filosofo, nel testo La Storia come pensiero e come azione, si sofferma sul rapporto intercorrente tra la storiografia e l’azione etica e politica nella storia. La conoscenza storica ha la finalità di andare oltre la vita vissuta la quale viene interpretata come una forma di conoscenza. La visione della storiografia riassume in sé una finalità catartica per cui gli avvenimenti avvenuti nel passato si trasformano in oggetto di conoscenza; assolvere o condannare i fatti del passato non è la finalità della conoscenza storica che, grazie ad una opera di mediazione, diventa un momento di chiarificazione indispensabile per svolgere un’azione efficace nella storia.[18]
La storia è libertà in grado di costruire sé stessa, e questo fatto dovrebbe garantire sempre e comunque un progresso, un perenne progresso dello Spirito su sé stesso; tuttavia l’esperienza ci insegna che, nel divenire degli eventi storici, si realizzano numerosi fatti negativi come catastrofi, guerre, pestilenze, che contrastano con la visione crociana della storia da lui intesa come un continuo e inarrestabile “progresso”. Questo accade nell’istante in cui soffermiamo la nostra attenzione su un tipo di storia abituata a descrivere i fatti anatomizzati nella loro particolarità e non nel caso che vogliamo veramente comprenderli come fatti capaci a determinare qualche novità per cui una superiore libertà possa trovare la sua piena realizzazione nel mondo. Di fronte a coloro che si erano piegati alla dittatura fascista e lamentavano la “perduta libertà” Croce ricorda che “la libertà non può disertare il mondo, ragion per cui anche il fascismo va vissuto come momento dal quale si genererà una nuova e più alta libertà […]”. Gli uomini amanti della libertà, a parere del filosofo, troveranno in sé la capacità di costruire uno stabile e duraturo regime di ispirazione liberale in opposizione al regime fascista.[19]
La vita dello Spirito si attua tra contrasti e opposizioni; è per questo motivo che la vita dello Spirito è libera e per questo essa rappresenta una continuità tra passato, presente e futuro. La vera conoscenza del reale si contraddistingue per essere una sintesi a priori fra intuizione e categoria; al contrario la cronaca, l’arte, la retorica non possono essere inquadrate nell’ambito di questa particolare forma di conoscenza. Il sapere storico stimola l’azione ed è, allo stesso tempo, stimolato, dall’azione. Questo scenario è l’espressione della circolarità del movimento dello Spirito, della connessione tra pensiero ed azione.
La vita individuale è condizionata necessariamente dal movimento dello Spirito; tutto quello che accade per il solo fatto di accadere è necessario per lo sviluppo storico dello Spirito; ma questo non significa che l’azione morale non sia oggetto di scelta e sia soggetta a una necessità meccanica. Tutt’altro: il bene universale è oggetto di scelta e non si impone meccanicamente alla volontà umana.[20]
La storia e la cronaca rappresentano momenti distinti in cui la storia è un momento di ricerca originante da un interesse orientato al presente il quale vivifica i documenti del passato mentre la cronaca tende a circoscrivere i documenti a svariate testimonianze: la storia si caratterizza per essere “storia viva”, storia contemporanea, mentre la cronaca assume il significato di “storia morta”, storia passata. “La conoscenza storica non è riproduzione passiva, ma supera la vita vissuta per rappresentarla in forma di conoscenza”.
La storia si libera delle passioni per trasformarsi in una visione che esprime una necessità logica della realtà. Gli eventi storici sono sempre valutati alla luce di criteri di bontà e di concretezza lasciando da parte la possibilità che essi possano essere interpretati negativamente.[21]
Nel saggio Teoria e storia della storiografia (1917)Croce si soffermasulla natura del giudizio storico: esso deve possedere i caratteri di neutralità in quanto l’essere neutrale consente di privilegiare la tesi della giustificazione nei riguardi della storia rifiutando il fatto che esso possa avere la funzione di giustiziere. In quello scenario l’individuo ha funzione trascurabile mentre grande importanza riveste il giudizio dello Spirito nella sua universalità e realtà; tutto ciò che si concretizza ha la propria ragion d’essere alla luce della dinamica dello Spirito.
Anche la metafisica, la scienza dei valori eterni, è un sapere storico che fa parte dell’insieme dei momenti di sviluppo dello Spirito.
Ne La storia come pensiero e come azione (1938)Croce propone di non sovrapporre al giudizio storico le espressioni affettive, perché è necessario cogliere gli eventi storici e le figure storiche del passato nella loro oggettiva dimensione spirituale.
In questo saggio, la difesa del diritto alla libertà esprime una condanna, nei confronti della dittatura fascista e nei confronti di un Regime intriso di una mitologia ispirata alla antica romanità e all’impero. Croce critica in queste pagine anche quanti erano stati colti da un sentimento di paura e delusione che aveva generato scetticismo storico e morale nei confronti del fortunato momento di popolarità attraversato dalla dittatura fascista.[22]
La storia, alla luce di quanto affermato, non può essere considerata né come cronaca, né né come arte, né come retorica, ma come la vera conoscenza del reale; essa appare come una sintesi a priori fra intuizione e categoria. “La storia è la vera conoscenza dell’universale concreto. E non solo ogni giudizio storico è conoscenza, ma la conoscenza storica è tutta la conoscenza. È, questo, lo storicismo assoluto”.[23]
[1] Croce B., La storia come pensiero e azione, Introduzione di Luciano Canfora, Editori Laterza, Bari-Roma, 2008, p. 39-40
[2] Primi saggi, Bari, Laterza, 1951, pp. 67-68; si veda la bibliografia riportata da Sacchetto M., Desideri F., Petterlini A., L’esperienza del pensiero. La filosofia: storia, temi, abilità 5 Il Novecento, Loescher Editore, Milano, 2006, p. 604
[3] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3A. Da Schopenhauer a Freud, Paravia Paravia Pearson Bruno Mondadori Editore, Milano, 2009, pp. 317-318
[4] Reale G., Antiseri D., La filosofia nel suo sviluppo storico. 3 Dal Romanticismo ai giorni nostri, Editrice La Scuola, Brescia, p. 325
[5] Sacchetto M., Desideri F., Petterlini A., L’esperienza del pensiero. La filosofia: storia, temi, abilità. 5 Il Novecento, Loescher Editore, 2006, pp. 36-37
[6] De Bartolomeo M., Magni V., Storia della Filosofia 4. Filosofie contemporanee, Diretta da Fausto Presutti, Editrice Atlas, Bergamo, 2011, p. 343
[7] Giannantoni G., Le filosofie e le scienze contemporanee 3, Loescher Editore, Torino, I edizione 1968, p. 447
[8] Massarenti A., Di Marco con la collaborazione di Maria Amelia Mannella, Penso dunque sono, Storia e testi della filosofia 3A. Dalle filosofie posthegeliane al neoidealismo, G. D’Anna, Messina-Firenze, Loesher editore, Torino, 2014, pp. 449-450
[9] Occhipinti F., Uomini e idee 3. Dal Romanticismo ai dibattiti attuali, Einaudi Scuola, Mondadori Education S.p.A, Prima edizione: gennaio 2010, Milano, p. 597
[10] Occhipinti F., Uomini e idee 3. Dal Romanticismo ai dibattiti attuali, Einaudi Scuola, Mondadori Education S.p.A, Prima edizione: gennaio 2010, Milano, p. 597
[11] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3A. Da Schopenhauer a Freud, op. cit., pp. 330-331
[12] Perotto A., Storia della filosofia 3, Società Editrice Internazionale, Torino, 1969, p. 239
[13] Dal Pra M., Sommario di storia della filosofia. Volume terzo. La filosofia contemporanea, La Nuova Italia, Firenze, 1980, pp. 333-334
[14] De Bartolomeo M., Magni V., Storia della Filosofia 4. Filosofie contemporanee, Collana diretta da Fausto Presutti, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2012, p. 347
[15] Geymonat L., Storia del pensiero filosofico, Vol. terzo. La filosofia nei secoli XIX e XX, Garzanti, Milano, 1971, p. 310
[16] Giannantoni G., Le filosofie e le scienze contemporanee 3, op. cit., p. 448
[17] De Bartolomeo M., Magni V., Storia della Filosofia 4. Filosofie contemporanee, op. cit., pp. 347 e 350
[18] Cambiano G., Mori M., Storia della filosofia contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 254
[19] Bontempelli M., Bentivoglio F., Il senso dell’essere nelle culture occidentali, Trevisini Editore, Milano, p. 348
[20] Sacchetto M., Desideri F., Petterlini A., L’esperienza del pensiero. La filosofia: storia, temi, abilità. 5 Il Novecento, Loescher Editore, 2006, pp. 604-605
[21] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3A. Da Schopenhauer a Freud, Paravia Paravia Pearson Bruno Mondadori Editore, Milano, 2009, p. 331
[22] Sini C., Mocchi M., Leggere i filosofi. Storia della filosofia e testi 3B La filosofia del Novecento, Casa Editrice G. Principato, Milano, 2003, p. 47
[23] Reale G., Antiseri D., La filosofia nel suo sviluppo storico. 3 Dal Romanticismo ai giorni nostri, op. cit., p. 324