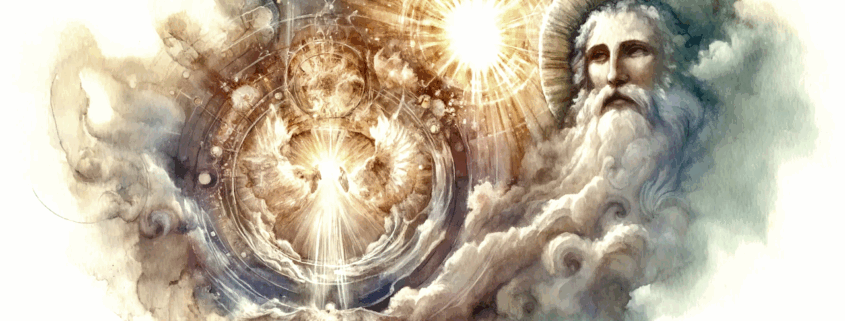La Verità divina, di Marco Calzoli
Leggiamo nel vangelo (Matteo 4, 13ss):
“ … 13 e, lasciata Nazaret, (Gesù) venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia (8,23-9,1):
15 Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali,
sulla via del mare, al di là del Giordano,
Galilea delle genti;
16 il popolo immerso nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte
una luce si è levata.
17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
18 Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori.
19 E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 20 Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 22 Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono.
23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 24 La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. 25 E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano”.
Quindi Gesù si recò a Cafarnao ad abitare nella casa di Pietro, che ancora oggi possiamo vedere, nel territorio della tribù di Neftali, proprio sulla Via Maris, che in Isaia 8, 23 è detta in ebraico derek hayam, il Vangelo di Matteo rende con odon thalassēs.
La Via del Mare collegava la Galilea a Damasco e da lì fino in Egitto. Percorreva la costa del Mediterraneo e aveva una deformazione a Oriente, quindi passava vicino a Cafarnao. Poco tempo fa è stata trovata una pietra miliare di questa via strategica. È significativo che Cristo decise di iniziare la sua missione pubblica proprio lungo questo importante snodo di collegamenti e di informazioni.
Gesù era un maestro itinerante, la sua base era Cafarnao ma da quel momento in poi, cioè da quando abbandonò Nazaret, la sua casa divenne il cammino stesso. Nei vangeli viene tratteggiato come colui che cammina incessantemente per proclamare a tutti i misteri del Regno. Egli è il Viandante celeste. Per questo in Luca 9,58 Gesù rispose a una domanda:
“Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.
Ogni uomo è come Cristo: siamo tutti pellegrini in questo mondo per ritornare alla Casa del Padre, esattamente come fece Cristo nella sua vita terrena, che si concluse con la Ascensione al Cielo.
La prima opera fatta da Cristo è l’invito alla conversione. Egli iniziò a predicare, in greco abbiamo il verbo kērussein. Il sostantivo corradicale kērugma indica l’annuncio cristiano, l’evangelizzazione. Dopo la vita nascosta Gesù uscì dal segreto di Nazaret e la sua voce cominciò a risuonare in Galilea. Per trenta anni si preparò nel segreto studiando le Scritture ed ora non poté più resistere alla missione affidatagli dal Padre.
Egli annunciò che il Regno di Dio si è fatto prossimo. Origene disse in greco che Cristo è l’Auto-Basileia, cioè Lui stesso (auto) è il Regno (basileia) di Dio.
In tutta la Bibbia Dio si è rivelato al mondo affinché tutti gli uomini lo possano amare con tutto il cuore e con tutte le forze. Il pellegrinaggio della vita è pericoloso perché l’uomo di tutti i tempi viene attaccato da mille insidie. Per questo Dio dona agli uomini la sia Torah, i primi cinque libri della Bibbia ebraica, i più importanti per gli ebrei. Il sostantivo ebraico Torah non significa etimologicamente “legge”: essa contiene anche precetti legali, quindi gli autori neotestamentari hanno tradotto Torah con nomos, che in greco vuol dire “legge”. Ma di per sé Torah deriva dal verbo ebraico yarah, che veicola l’idea del lanciare una freccia, quindi del colpire il bersaglio. In un’altra forma (Hifil) il verbo ebraico significa anche “insegnare”. Pertanto la Torah è quell’insegnamento fondamentale dato da Dio agli uomini per raggiungere la meta della propria vita, per non sbagliare. È significativo che in ebraico il “peccato” è detto khattà, che indica il fallire il bersaglio, un po’ come il sostantivo greco neotestamentario amartia.
Con la rivelazione definitiva, quella cristiana, sappiamo che l’insegnamento più importante è quello annunciato da Cristo e esteso nei secoli dalla sua chiesa. Di più, Cristo non solo è l’estensore di un messaggio che ci porta al Regno ma è anche il Regno stesso. Egli è la nostra pace, lo scopo della nostra vita, il ripristino nel nostro cuore dell’Eden originario.
Dato che il regno di Dio è vicino, in quanto è giunto in Cristo, Egli può dire “convertitevi”. Il verbo greco adoperato da Matteo è metanoeite, e la metanoia è il sostantivo greco che significa “conversione”. Etimologicamente la conversione è un “cambiar (meta) mente (noia)”. In ebraico il convertirsi si dice shub, che etimologicamente vuol dire “ritornare”. L’uomo può ritornare al regno perché il Regno è venuto a Lui. Lamentazioni 5, 21 fa anche uno stupendo gioco di parole nell’originale ebraico:
hashibenw YHWH ‘elek wenashwbah
“facci ritornare e noi ritorneremo”.
La conversione deriva da Dio, che dà la sua grazia. Egli fa il primo passo e solo dopo l’uomo può “cambiare la mente”, cioè mutare il progetto di vita e far proprio quello di Dio.
Quindi Gesù concretizzò il suo messaggio chiamando gli apostoli alla missione cristiana. Gesù letteralmente “passeggia”, infatti nell’originale greco Matteo usa il verbo peripatein. La prima cosa che fa Dio dopo il peccato di Adamo e Eva è passeggiare, mettendosi alla ricerca dell’uomo. Genesi 3, 8 dice letteralmente “… la voce di Dio che passeggia”. Il termine ebraico qol, “voce”, viene richiamato dal fatto che Cristo è nel Nuovo Testamento il Logos, cioè il Verbo di Dio, la sua Parola (verbum in latino). Anche in Matteo quindi di nuovo la Parola di Dio passeggia sulla terra dei peccatori. Dio ci cerca, sta vicino a noi.
Ai tempi di Cristo vi erano filosofi pagani che passeggiavano mentre formavano i discepoli. Aristotele insegnava solo passeggiando, quindi pose le basi della Scuola Peripatetica, termine che deriva dal verbo greco che abbiamo testé richiamato. È significativo che in Giovanni (10, 23) Cristo passeggiava nel tempio, sotto la stoà di Salomone. Il termine greco stoà significa “portico” e i filosofi pagani ammaestravano camminando sotto i portici, il termine greco in questione ha dato origine al nome di una famosa scuola di filosofi ellenistici, gli stoici.
Cristo è la stessa sapienza di Dio fatta carne. In quanto il suo Logos non è solo un “discorso” umano ma addirittura il “discorso” di Dio. Gesù disse di sé stesso: “Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Giovanni 14, 6).
Pertanto la Verità non è il disvelamento dell’essere, come volevano i filosofi pagani: in greco è detta a-lētheia, sostantivo formato da alfa privativo + la radice del verbo lanthanein, “nascondere”, quindi la verità è un “non nascondimento”. Invece il vangelo ci dice che la Verità è addirittura una Persona divina che si è fatta uomo, come noi, e che adesso è risorta e vive con il suo corpo glorioso.
È tanto importante la venuta di Cristo che il profeta Isaia già nel VIII secolo a.C. lo ha annunciato. In Isaia 7, 14 leggiamo:
“Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emmanuele”.
Si è molto discusso sull’esatto significato da dare a questa profezia di Isaia. Bisogna fare un po’ di chiarezza:
- Il testo ebraico recita: Una giovane donna (‘almah) è incinta, e genererà un figlio. In ebraico vi è un termine che significa “vergine” (betulah), ma Isaia non lo impiega. Il segno che egli offre al re Acaz consiste nel nome del bambino (cfr. 7, 3; 8, 1.16) e non in qualcosa riguardo la nascita;
- La versione greca ricorre a parthenos, e questa è stata definita spesso a torto una traduzione errata. Infatti il sostantivo greco parthenos può significare “vergine”, ma non necessariamente. Il suo primo significato è “ragazza”, “giovane donna”, e non vi è la minima ragione di supporre che il traduttore greco intendesse qualcosa di diverso dal senso che trovava nell’originale ebraico;
- Era tuttavia possibile per qualsiasi lettore della versione greca interpretare il vocabolo nel senso ristretto e ritenere che la profezia riguardasse la nascita da una vergine, esattamente come ha fatto Matteo in 1, 23;
- I vangeli canonici sono quattro e nascono in ambienti diversi con materiali diversi utilizzati per finalità diverse. L’ambiente di Matteo ha interpretato in senso ristretto la parola greca parthenos, invece nell’ambiente di Luca non si pose atto a questa traduzione, infatti Luca, che credeva anche lui al pari di Matteo alla nascita miracolosa di Cristo, non si appellò alla profezia di Isaia e la sua credenza non è espressa nell’uso della parola parthenos (1, 27), che è correttamente tradotta “ragazza”.
In questo pellegrinaggio terreno siamo tutti condannati a morte. Heidegger diceva che solo l’essere per la morte è autentico. Per questo l’uomo ha angoscia della morte e cerca di esorcizzarla con le occupazioni più varie. E proprio per questo la nascita di Cristo è così importante e Isaia la ha profetizzata da secoli prima dell’Avvento divino nella storia umana.
Ricordiamo che la profezia di Isaia era considerata la più autorevole sia dagli ebrei sia dai cristiani dei primi secoli. A Qumran Isaia ci è giunto in un rotolo intero. I resti di sei manoscritti di Qumran con differenti pesher (interpretazioni bibliche giudaiche) sono di epoca erodiana. Stiamo grossomodo negli anni dell’avvento di Cristo nella carne. In quel lasso di tempo l’interpretazione del corso della storia alla luce del tempo della fine, che avrebbe avuto inizio nel 98-97 a.C. (490 anni dopo la distruzione del primo Tempio) si faceva sempre più acuta. A questa situazione si deve probabilmente il fatto che, a partire da un periodo congruamente contestuale, i manoscritti di Isaia vennero copiati con speciale diligenza. E che anche in seguito furono oggetto di una interpretazione attualizzante.
Per i vangeli solo Gesù è il Salvatore del mondo, Egli ha vinto la morte e ha aperto le porte del Paradiso a tutti i battezzati. L’attesa messianica dei primi secoli, cui Dio ha risposto con l’invio di Gesù nella carne, era collegata agli ultimi tempi. Ragion per cui il rotolo di Isaia era allora assai attuale.
Cristo è Via, Verità e Vita. La Verità che Egli è venuto a proclamare sulla terra e che è Lui medesimo, è la via aurea che ci conduce in Paradiso, cioè alla vita eterna. Sono questi gli ultimi tempi di cui parla il Nuovo Testamento: non la fine del mondo come conflagrazione cosmica bensì la fine di un’era, quella del peccato, sanata dalla medicina della Redenzione di Cristo. Cristo inaugura i tempi nuovi, siglati dalle fiammelle di Spirito Santo discese su Maria e gli apostoli, che danno inizio al tempo della chiesa, strumento di salvezza per il mondo intero, in quanto essa è Cristo comunicato e diffuso (De Lubac).
Non per nulla la Bibbia è il libro più letto del mondo. Il cristianesimo nel mondo è la religione più diffusa per numero di credenti, avendo circa 2,4 miliardi di aderenti, su 8,02 miliardi di abitanti del pianeta Terra.
L’incarnazione di Dio sulla terra in Cristo è il miracolo più grande che Dio avrebbe mai potuto fare. La creatività di Dio supera ogni immaginazione. Quella Verità che cercavano i filosofi greci con vani ragionamenti si è fatta carne. Giovanni 1, 14:
“E il Verbo (logos) si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Il termine greco logos, che deriva dal verbo leghein, “raccogliere”, è una parola chiave della filosofia greca antica. Indica l’atto del pensare, quello del dire e quello del creare. Eraclito parlava del Logos come principio ordinatore di tutta la realtà. In siffatto senso la parola greca compare nella produzione filosofica ellenistica, anche giudaica (Filone di Alessandria). Gli stoici parlavano di logoi spermatikoi, “ragioni seminali”, che sono alla base del mondo. Logos designa anche il prodotto del pensiero e della parola, cioè un’opera, uno scritto filosofico.
Si tratta di una comune eredità indoeuropea. In sanscrito vāc significa sia “parola” sia “voce” sia “pensiero” (soprattutto nell’atto della descrizione) e sta alla base della creazione.
In Ṛg-Veda (10.71.5), il più antico dei Veda, i testi sacri dell’induismo, si fa riferimento a questa Parola capitale, senza la quale non si può avere potere né conoscenza, diversa dalla parola degli uomini comuni:
uta tvaṃ sakhye sthirapītam āhur nainaṃ hinvanty api vājineṣu | adhenvā carati māyayaiṣa vācaṃ śuśruvām̐ aphalām apuṣpām ||
“Chiamano un uomo fermamente stabilito nell’amicizia (della Parola), non lo escludono dalla (società dei) potenti (della conoscenza); un altro vaga con un’illusione sterile, portando una parola senza frutto, senza fiori”.
È talmente potente la Parola degli inni sacrificali da estendersi dal mondo degli umani ai cieli più alti, sfiorando le divinità supreme. Infatti in 8.76.12 è scritto:
vācam aṣṭāpadīm ahaṃ navasraktim ṛtaspṛśam | indrāt pari tanvam mame ||
“Faccio questo inno sacrificale, raggiungendo gli otto punti (del cielo) e salendo al nono (il sole allo zenit), sebbene sia inferiore (alle dimensioni di) Indra”.
Il Ṛg-Veda contiene svariati riferimenti riguardo la speculazione sulla Parola. Le parole usate per l’azione del “pensare” sono generalmente adatte a designare il prodotto di questo pensiero, la poesia, la parola detta: così, tra gli altri, mati e dhī. “Dire” e “pensare” si uniscono in vāco matim 1.143, 1.8.59 e in vācaḥ masīha 10.53.4, “vorrei pensare alla parola (“grazie a cui…”). La parola aramati (spesso personificata come divinità, come altri sostantivi dello stesso gruppo semantico) è un equivalente di mati; l’elemento iniziale aram è quello che comparirebbe nell’espressione completa *araṃkṛtā matiḥ (cfr. aram … manase 1.108.2), vale a dire “pensiero messo in forma corretta, pensiero pronto (per giochi poetici)”.
Giovanni aveva già annunciato il Logos nei primi versetti del suo vangelo, confinandolo nella sfera spirituale (“In principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio”). Adesso però dice riguardo al Logos qualcosa di diverso, introdotto in greco dal kai, “e”: il kai indica un progresso storico, irripetibile e unico, si tratta di un vero e proprio kai prosecutivo. Il Logos diviene nientemeno che “carne”. Si tratta di un semitismo per indicare “essere umano”. Di più, il sostantivo greco sarx, “carne”, nel greco biblico era utilizzato per tradurre l’ebraico basar, il “corpo” inteso nella sua fragilità creaturale. Dio spoglia sé stesso divenendo un bambino fragile, bisognoso di tutto, per insegnare al mondo che Egli ama ogni creatura e manda suo Figlio unigenito su questa terra per salvarla.
In Giovanni il Logos era dapprima espresso mediante il verbo greco ēn, “era”, che in questo caso non vale come un passato, essendo la probabile traduzione di un perfetto aramaico, che veicola l’idea della pienezza atemporale dell’essere, entro la sfera spirituale. Ma questo imperfetto greco potrebbe avere anche un altro valore. In una argomentazione filosofica antica possiamo incontrare un imperfetto, che va tradotto come un presente: esso si riferisce al momento in cui una verità fu riconosciuta, quindi esprime quello che una cosa è conforme alla propria essenza. Per esempio, in Platone (Critone 47D) è scritto: “Che se noi non daremo retta a costui, verremo a distruggere e a contaminare quella parte di noi che col giusto, come dicevamo, diventa (egigneto) migliore e con l’ingiusto perisce (apōlluto)”.
Invece adesso il Logos non sta più nei Cieli: infatti l’incarnazione del Logos è un vero e proprio evento storico, denotato dal verbo egeneto, “divenne”, che come aoristo esprime una azione puntuativa, un fatto inserito in un ben preciso contesto storico-sociale-culturale. Il Logos dapprima era nella Gloria divina, adesso scende nei bassifondi dell’esistenza umana.
Il Logos però continua ad essere Dio anche dopo aver assunto la natura umana. Infatti Egli “venne ad abitare in mezzo a noi”: Giovanni usa il verbo greco eskēnōsen, un altro aoristo, che significa letteralmente “pose la tenda (skēnē)”. Probabilmente vi è una allusione alla Tenda dell’Incontro, il santuario mobile degli ebrei nel deserto, nel quale Dio scendeva e incontrava gli uomini. Potrebbe essere anche un’allusione alla tenda del Tempio, dietro la quale vi era il Santo dei Santi, ove dimorava Dio. Potrebbe addirittura essere una allusione all’Arca dell’Alleanza (che custodiva le Tavole della Legge) che era considerata il trono di Dio (in Numeri 35, 34 è scritto: “Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale io dimorerò; perché io sono il Signore che dimoro in mezzo agli Israeliti”, dove il verbo “dimorare” è nell’originale ebraico skn, radice che somiglia al termine greco skēnē, “tenda” e che la versione greca della Septuaginta rende con una variante del verbo eskēnōsen, che è kataskēnōsō, “abiterò”).
Il filosofo greco Protagora diceva che “l’uomo è la misura di tutte le cose”. Il termine greco to métron, “la misura”, indica che per i pagani l’unico punto di vista degno di fiducia è quello dei sapienti umani. Invece la Verità costituita da Cristo, l’Uomo Dio nato e morto qui per la nostra salvezza, si fa “paradosso” (Kierkegaard) relativamente ai criteri di giudizio umano. La profezia di Isaia 7, 14 aveva per contenuto la nascita dell’Emmanuele, definita un “segno” (‘ot), la cui natura doveva essere prodigiosa, come se alterasse le consuete leggi del creato: infatti il profeta propone di chiederlo “nel profondo degli inferi o lassù nelle altezze” (v.11).
Lo dice chiaramente san Paolo (1Corinzi 1, 22-24):
“Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio”.
Ma senza la fede, in verità, nulla è comprensibile. È razionale che l’uomo nasca senza ragione, soffra senza ragione e stramazzi al suolo ricadendo nel nulla dal quale proviene? Una vita così è degna di essere vissuta?
Quando entriamo in chiesa diciamo la parola Amen. Essa deriva dal verbo ebraico ‘aman. Il verbo significa “avere fondamento su qualcosa”, quindi esprime il “credere” come affidarsi totalmente a Dio. La parola Amen vuol dire “credente”. Pertanto si tratta di una professione di fede che si basa sulla Verità espressa da Dio nella Bibbia. Per questo in aramaico il termine “amen” vuol dire nientemeno che “verità”.
Senza il fondamento assicurato dalla fede la vita dell’uomo è una esperienza allucinante e angosciante. Solo Dio può dare all’uomo il senso della sua vita.
Dio non è introvabile: ci viene a cercare Lui per primo nella nostra condizione di peccatori, caratterizzata dal fallimento continuo. Come duemila anni fa, quando Cristo proclamava il Regno di Dio. Adesso vi è la sua chiesa, che sparge in tutto il mondo il seme del vangelo.
La parola “vangelo” deriva dal termine greco euanghelion, che risuona nel Nuovo Testamento 76 volte. Il termine greco è antico e lo usava già Omero, ma l’uso prevalente era “ricompensa per la buona notizia” (Odissea 14, 152: Odisseo, che ancora non si è rivelato a Eumeo, dice che verrà a casa e così riceverà il “premio per la buona notizia”). Più significativa è la iscrizione di Priene (Asia Minore) del 9 a.C., una specie di calendario ove si legge che il giorno della nascita di Augusto fu l’inizio dei “buoni annunzi”. Ma era usato – nel verbo “evangelizzare” (euangheliein) – anche dall’Antico Testamento, nella versione della Septuaginta, che traduceva il verbo ebraico dell’ “annunciare un lieto messaggio”, basser (per esempio Isaia 61, 1-2).
Per questo è più probabile che il Nuovo Testamento si sia ispirato alla Bibbia greca. Comunque il senso è nuovo: la lieta (eu-) notizia (anghelia) ha al centro la figura di Cristo e la salvezza da Lui offerta. Non per nulla san Paolo utilizza per 8 volte la locuzione euanghelion tou Christou, “vangelo di Cristo”. Da questo senso si passò poi a quello di un genere letterario, che, pur avendo contatti con il genere della biografia greco-romana, allora diffusa (Vite parallele di Plutarco, De viris illustribus di Svetonio), è nuovo. Nel vangelo cristiano, infatti, storia e messaggio sono fusi in un impasto omogeneo.
Nel Libro della Genesi, Dio rivolge ad Abramo questo comando: “Esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò!”. L’esperienza di esodo del popolo di Israele è il prototipo per ogni fedele. Il pellegrinare di Abramo lo porta costantemente a toccare il suo limite, il suo peccato; allo stesso tempo lo sprona a non arrendersi, a guardare in alto, a fare esperienza della presenza costante di Dio, che lo accompagna sempre nella sua vita, nel suo cammino, nelle sue necessità.
Ancora oggi noi fedeli, come Abramo, sentiamo la necessità di ritrovare le ragioni della speranza, per affrontare le difficoltà che incontriamo. E come lui, possiamo metterci in un cammino che tende verso la Croce, come un’àncora di salvezza.
La Croce di Cristo è lo stesso Paradiso. La liturgia cattolica chiama la croce “talamo, trono e altare”. La sofferenza è lo stacco dal nostro egoismo per andare incontro a Dio, che si avvicina per primo nella nostra vita. Il Paradiso sarà una sofferenza perfetta, come perfetto esodo da noi stessi e dai nostri affetti mondani verso Dio, in un abbraccio festoso che si aprirà alla pura beatitudine.
L’uomo lontano da Dio ha paura della sofferenza, ma essa non è altro che un passo in più verso il Creatore. È il colombre di un racconto di Buzzati: quel mostro marino che perseguita una persona, la quale quindi fa di tutto per sfuggirgli, ma non sa che questo squalo la segue di continuo perché intende donarle un tesoro inestimabile.
È un messaggio rivoluzionario! Il vangelo è la Verità di Dio scesa tra di noi! Per questo i cristiani sono tanto perseguitati, soprattutto oggi, più di ieri, ma Dio è con loro. Nella Lettera a Diogneto (7) è scritto:
“Non vedi, i cristiani sono gettati alle fiere perché rinneghino il Signore, e tuttavia non si lasciano vincere? Non vedi, quanto più sono perseguitati, tanto più si moltiplicano? Questa non pare opera dell’uomo, ma è potenza di Dio; questa è una prova della Sua presenza”.
Bibliografia
- G. B. Caird, Lingua e linguaggio figurato nella Bibbia, Brescia 2009;
- F. De Carlo (a cura di), Vangelo di Matteo. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2016;
- J. Maier, Le Scritture prima della Bibbia, Brescia 2003;
- G. Ravasi, La Buona Novella, Milano 1998;
- L. Renou, Ètudes védiques et pāṇinéennes, vol. 1, Paris 1955;
- R. Schnackenburg (a cura di), Il vangelo di Giovanni, vol. 1, Brescia 1973;
- A. Tomasetto (a cura di), Alle origini del cristianesimo. Didaché, Lettera a Diogneto, Tradizione Apostolica, Torino 2013;
- M. Untersteiner, Problemi di filologia filosofica, Milano 1980.