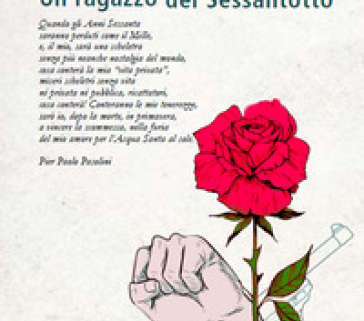“Noi siamo la nostra memoria” afferma Jorge Luis Borges e Bruno Pezzella nel saggio autobiografico “Un ragazzo del Sessantotto”, edito da Kairòs, raccoglie un mucchio di specchi rotti e prova a ricostruire attraverso le proprie esperienze le forme incostanti di un periodo elettrizzante e inquieto.
Il Sessantotto fu ricco di contraddizioni, passeggero e duraturo, verboso, conquistò gli animi e li deluse, fu un movimento popolare e culturale -…forse l’unico nella storia condiviso da una intera generazione di studenti, operai, intellettuali, artisti che si erano messi in testa di cambiare il mondo. – scrive l’autore e ogni pagina è un susseguirsi di memorie in cui ad accenti più personali e interpretativi si accompagna l’osservazione dei fatti.
Bruno Pezzella è un ragazzo del Sessantotto e le sue reminiscenze rimandano immediatamente agli archivi di sensazioni, immagini e nozioni che ci accompagnano e si accumulano nell’anima, che a volte si perdono, a volte ritornano. Il suo racconto è una “rete” di collegamenti e di rimandi che s’intersecano e producono altri punti di riferimento: i cortei, le occupazioni, la musica, il cinema, il teatro, soprattutto parole, parole di protesta civile e denunzia, di supporto alla lotta per il cambiamento. Almeno quattro generazioni hanno nutrito il proprio immaginario di personaggi e fenomeni di quegli anni: Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Gianni Morandi e Lucio Battisti, i film neorealisti, Sofia Loren e Totò, De Sica, Fellini, Tornatore e Dario Fò.
L’emotività, la nostalgia della giovinezza, la consapevolezza di aver partecipato ad un momento epocale, aumentano la persistenza delle informazioni e migliorano il ricordo degli eventi. Si tratta di un ricordo soggettivo affidabile, utile alla formazione di una memoria collettiva veritiera.
Il saggio di Pezzella non è un ripiegamento dell’autore su di sé, una fuga dal collettivo, dal sociale, e neppure un’esigenza di risarcimento psicologico, affettivo e morale che il ricordare e, soprattutto, il ricordare insieme, spesso porta con sé, bensì una scoperta di pezzi di storia in comune con altri che costituiscono un momento di riflessione, di riscoperta e di realizzazione, di un sé “inseparabilmente legato all’ambiente, all’altro, agli eventi, alla storia individuale e collettiva”.
Pagine che sono racconto, cronaca e filosofia dentro un registro moderno che ha come riferimento prestigiosi autori: da Philip Roth a Luciano Bianciardi, a Michele Serra, a Edoardo Nesi. Il patrimonio emozionale e razionale è trasfuso in una scrittura sapiente e accurata che sa ricreare atmosfere. “Il ricordo è un modo d’incontrarsi” e la scrittura è il luogo privilegiato. Individui e generazioni s’incrociano tra le righe e i capoversi, la memoria, come un filo sottile e misterioso, finisce con il collegare avvenimenti personali e collettivi, lontani e dispersi, dentro la dimensione del tempo.
Oggi assistiamo al fenomeno della frantumazione della memoria collettiva e al suo rapporto, spesso contradditorio, con quella individuale che preme per avere il suo riconoscimento, la sua storicizzazione, mentre la storiografia, “per sua natura, richiede lentezza di rielaborazione, ricerca, documentazione”. La memoria narrata nel libro di Pezzella non va a scapito di una ricerca storica e memoriale. Entrambe, sedimentate ed elaborate metodologicamente, si arricchiscono reciprocamente sia del valore soggettivo e individuale, sia di quello culturale. Il taglio narrativo permette di recuperare il passato perché lo si riconosce e riattualizza come rappresentazione comune attraverso il senso della storia personale. Il racconto consente di comprendere, realizzare, ricomporre a ritroso, storicamente, la propria identità e farla coincidere con la memoria stessa.
L’autore descrive e interpreta le esperienze da lui vissute incastonandole nella realtà dell’epoca: l’occupazione del Liceo Vico e il viaggio a Parigi si sovrappongono al Maggio Francese e alla Young culture. In tal modo autobiografia e storiografia trovano il loro punto di convergenza. La prima conserva la ricchezza psicologica e la prospettiva di poter conferire un significato preciso a un’esistenza, la seconda analizza i fatti. La cronaca privata presuppone un nesso con la vita interiore dell’autore, con le convinzioni ideologiche e le condizioni sociali di quel determinato momento storico, la prospettiva storica fornisce la rete di moventi, modi, scelte, ragioni che sottintendono alle azioni reali.
Il senso della storia è proprio nella percezione della concretezza della vita di un periodo. Non è dato solo dai grandi eventi o dai grandi fenomeni economici e sociali, ma dal concreto vivere quotidiano, dall’eskimo e dalla barba incolta, dal treno dei pendolari, dall’ostentazione della non ricchezza. I sentimenti, l’amore, l’amicizia, la paura di un ragazzo del Sessantotto entrano a pieno titolo nella ricostruzione storica.
Ne viene fuori una immagine diversa e complessa di quell’epoca che può essere ancora un utile riferimento per analizzare il presente. Una “scrittura della realtà” che svolge sempre compiti di natura sociale e quindi appartiene alla storia della cultura umana. Un materiale che può diventare un terreno fertile di ricerche e interpretazioni sui protagonisti degli eventi e dei luoghi, utile strumento per lo storico e per la comunità, un valore aggiunto contro la massificazione e l’uniformazione delle coscienze.