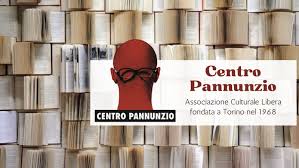martedì 25 marzo, ore 18-19
Bruno Quaranta, a colloquio con Pier Franco Quaglieni, parlerà del libro da lui curato, I miei libertini di Arrigo Cajumi, Roma, Torino, Nino Aragno 2024.
«I miei libertini è un suo libro involontario, un’antologia di pagine, apparse soprattutto su La Stampa, dedicate alle intelligenze o di nascita o di scuola o di frequentazione piemontese, tra cultura e politica, dall’ottocentesco Angelo Brofferio a Piero Gobetti, da Guido Gozzano a Antonio Gramsci, da Giovanni Giolitti a Benedetto Croce, da Leone Ginzburg a Augusto Monti, da Luigi Einaudi a Cesare Pavese. Libertini – come spiegò Ferdinando Neri, un maggiore di Cajumi, presentando il journal dell’allievo Pensieri di un libertino – “nel significato che la parola acquistò particolarmente nel francese del Seicento e che si connette con la libertà di pensiero: libertà che, accusata di licenza, venne confusa con quella del costume”. Via via a comporsi (a ricomporsi) è un ideale mondo di ieri, venerato tanto profondamente quanto sobriamente, nella consapevolezza, e nella fierezza, della sua irripetibilità».
Bruno Quaranta è nato a Torino nel 1953, dove ha seguito gli studi di Giurisprudenza. Formatosi al «Giornale» di Indro Montanelli, è redattore e critico letterario del settimanale culturale de «La Stampa». È tra i curatori dell’opera omnia di Giovanni Arpino edita da Rusconi. Ha pubblicato un libro intervista con Arpino; è autore di Stile e stiletto. La Juventus di Giovanni Arpino (Limina), Piemonte. Il cuore nobile dell’Italia (White Star) e Parole di legno. Xilografie, la rivista Smens, opere di Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (Ass. Culturale Marcovaldo).
giovedì 3 aprile, ore 18-19
Danilo Breschi, autore dell’introduzione e curatore di una nuova edizione di Socialismo liberale di Carlo Rosselli (Roma, Historica 2024) dialogherà con Carla Sodini su questa suo nuovo impegno.
«Carlo Rosselli scrive Socialismo liberale tra il 1928 e il 1929, mentre è al confino di Lipari dopo essere stato arrestato per aver organizzato la fuga all’estero di Filippo Turati nel dicembre del 1926. Aveva tenuto nascosto il manoscritto dentro un vecchio pianoforte, prima di riuscire anch’egli a fuggire dal confino fascista, nel luglio del ’29. La prima edizione del libro uscì pertanto a Parigi, nel 1930, nella traduzione in francese curata da Stefan Priacel, presso la Librairie Valois. La prima edizione italiana sarebbe uscita soltanto nel 1945. Socialismo liberale resta un’opera unica nel suo genere. Determinante nell’alimentare gli ideali dell’antifascismo socialista e liberale, repubblicano e federalista, pochi testi come Socialismo liberale hanno saputo mettere a nudo anche le contraddizioni e le debolezze intrinseche della teoria marxiana».
Danilo Breschi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma. Direttore scientifico de «Il Pensiero storico. Rivista internazionale di storia delle idee», è membro del comitato di direzione della «Rivista di politica» e consigliere di amministrazione della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Nei suoi studi si è occupato della tradizione liberale francese tra XIX e XX secolo e dei rapporti tra politica, filosofia e cultura nell’Italia contemporanea, dedicando attenzione sia al passaggio dall’età liberale al fascismo sia ai movimenti di contestazione degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Ha indagato inoltre il ruolo degli intellettuali nella critica della società e i processi di formazione delle classi dirigenti in Europa. Tra le sue pubblicazioni recenti: Quale democrazia per la Repubblica? Culture politiche nell’Italia della transizione, 1943-1946 (Milano 2020); La globalizzazione imprevidente. Mappe del nuovo (dis)ordine mondiale (et al., Arcidosso 2020).
martedì 8 aprile, ore 18-19
Alessandro Volpi, a colloquio con Carla Sodini, parlerà del suo libro L’America secondo Trump. Prospettive economiche e scenari globali, Lucca, La Vela, 2024
«Donald Trump e James David Vance sono stati interpretati come una possibile soluzione alla visione economica dei dem, decisamente troppo elitaria e troppo vicina ai grandi monopoli, a cominciare da quello delle Big Three (i fondi di investimento internazionali Vanguard, BlackRock e State Street). Su un piano più specifico, Trump ha dato voce ai sindacati arrabbiati contro le case automobilistiche, ormai più attente alla finanza che alla produzione, ai sostenitori dell’economia dei bitcoin e al vasto mondo degli hedge fund aggressivi: in sostanza, a pezzi della vecchia America e della nuova. Dai dipendenti dei casinò, ai farmer, ai sempre più sparuti operai, alle microimprese. Il nuovo presidente ha poi interpretato l’insofferenza popolare verso il modello “illuministico” dell’America sostenitrice dei diritti civili e dell’esportazione dei conflitti in nome di una democrazia sempre più incomprensibile: in fondo l’opinione pubblica Usa non apprezza certo l’ostilità maturata verso il paese dai quattro quinti del mondo».
Alessandro Volpi è professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Si occupa di questioni finanziarie, con particolare attenzione ai mercati internazionali. Collabora con «Altreconomia» e «Left». Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo, Storia del debito pubblico in Italia. Dall’Unità a oggi (assieme a Leonida Tedoldi), Bari, Laterza, 2021; Prezzi alle stelle. Non è inflazione ma speculazione (Bari Laterza, 2023); I padroni del mondo. Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia (Bari, Laterza, 2024).
giovedì 17 aprile, ore 18-19
Eugenio Capozzi, Libertà o potere. Ascesa e declino della costituzione, Macerata, Liberlibri, 2025
«Nell’Occidente contemporaneo la costituzione viene considerata spesso, superficialmente, come una sorta di “supermarket” dei diritti, come il “manifesto” ideologico di una ipotetica società perfetta, o come un generico rimando retorico, regolarmente contraddetto dalla compressione delle libertà in nome di qualsiasi vera o presunta emergenza. Contro questi travisamenti è necessario riportare alla luce le radici del costituzionalismo come tradizione culturale, politica, giuridica in cui si è sedimentata l’idea della priorità del diritto sul potere, e dei limiti invalicabili che la dignità umana gli pone. Una tradizione originata nella cultura greca, romana ed ebraica, sintetizzata dall’umanesimo cristiano, concretizzata innanzitutto nel pluralismo istituzionale dell’Europa medievale. Lo Stato moderno, con le ideologie in esso sorte, ha rappresentato per la limitazione del potere una minaccia mortale, faticosamente contenuta dall’universalismo dei diritti naturali e dalla persistenza di pratiche comunitarie di autogoverno».
Eugenio Capozzi è professore ordinario di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (Dipartmento di Scienze Umanistiche) È condirettore della rivista «Ventunesimo Secolo» e redattore della rivista «Ricerche di Storia politica». Fa parte del consiglio scientifico della casa editrice Studium. Tra le sue pubblicazioni: Il sogno di una costituzione. Giuseppe Maranini e l’Italia del Novecento (Il Mulino 2008), Partitocrazia. Il “regime” italiano e i suoi critici (Guida 2009), Le mura della libertà. Dal costituzionalismo all’universalismo liberaldemocratico (Editoriale Scientifica 2011), Storia dell’Italia moderata. Destre, centro, antipolitica, anti-ideologia nel secondo dopoguerra (Rubbettino 2016), Politicamente corretto. Storia di un’ideologia (Marsilio 2018), L’autodistruzione dell’Occidente. Dall’umanesimo cristiano alla dittatura del relativismo (Historica Giubilei Regnani, 2021), Storia del mondo post-occidentale. Cosa resta dell’età globale? (Rubbettino, 2023).