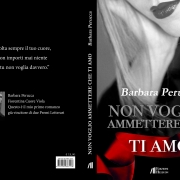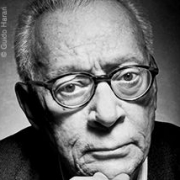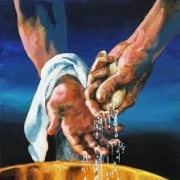Per un Vinitaly che non ci sarà, viaggio tra i vitigni rari, di Maria Luisa Alberico
Per la prima volta nella sua storia la 54esima edizione di Vinitaly non si svolgerà e sarà aggiornata dal 18 al 21 aprile 2021. Verranno cosi a mancare incontri e business internazionali, degustazioni prestigiose e presentazioni da parte delle aziende delle loro ultime produzioni. Per supplire idealmente a questa mesta ma indifferibile decisione, propongo un viaggio enologico in tutte le regioni italiane, scegliendo alcune tipologie di vini da vitigni autoctoni assai rari e poco noti, ma degni di attenzione per qualità e originalità: in altri termini, non sono figli di un Dioniso minore! Cosa intendiamo per vitigni autoctoni? Possono definirsi tali le varietà ottenute localmente da incroci naturali adattati nel tempo. In Italia, caso pressoché unico nel mondo, si produce vino in tutte le regioni – ed in ognuna sono coltivati vitigni con una storia secolare e banalmente definiti “minori” poiché per una serie di ragioni non si sono mai posizionati al centro dell’attenzione rispetto alle varietà più note. Si tratta solitamente di vitigni locali con una storia antica o importati da lungo tempo ed adattatisi ai nostri climi e suoli, sovente recuperati dopo un lungo oblio perché difficili da coltivare e da vinificare o di scarsa resa rispetto alle esigenze produttive massive o particolarmente esigenti nell’esposizione ed espiantati a favore di vitigni meno sensibili. Hanno nomi delicati, dialettali, che ricordano gesti arcaici, animali, colori e sensazioni gustative. Un vero patrimonio da riscoprire.
Ed in effetti negli ultimi due decenni la riscoperta ha portato ad una valorizzazione dell’autoctono tanto da divenire, come spesso accade, una moda che ha sovvertito la tendenza nelle scelte dei consumatori: non più Sauvignon o Cabernet in enoteca o al wine bar, ma Pecorino abruzzese, Passerina molisana , Coda di volpe campana…
Non è oggi, data la situazione che stiamo vivendo, motivo d’allegrezza questo excursus, ma ritengo confortante conoscere le infinite potenzialità del nostro mondo enologico sin nelle sue più rare espressioni, rendendoci ancor più consapevoli della dovizia di doni che la nostra Penisola può vantare in ogni ambito della produzione agroalimentare, con l’intima promessa che quando questo surreale e drammatico momento sarà trascorso avremo scelte maggiori e uniche per brindare alla vita ritrovata.
Per oggi ai lettori il mio brindisi virtuale!
Partiamo dalla nostra Regione e concentriamoci su una varietà tipica della zona di Calosso in provincia di Asti: il Gamba di pernice. Tra i vigneti delle splendide colline tra Monferrato e Langhe ecco questo raro vitigno sopravvissuto alla fillossera e per molti anni a rischio di estinzione. Il Gamba di pernice è vitigno a bacca rossa che deve il suo nome all’arrossamento del raspo prima dell’invaiatura, ossia nel momento in cui le uve “virano” verso la colorazione della maturazione e il raspo assume il colore delle zampette delle pernici. Un buon sorso con gli antipasti primi delicati e carni bianche.
Al termine di una gita ad Aymaville, in Valle d’Aosta, propongo il Fumin. Origini antiche, sino a pochi anni fa non era vinificato in purezza ma in assemblaggio con altre uve cui conferiva colore e acidità. Il nome deriva dal fatto che gli acini nella maturazione si ricoprono di una “pruina”, sostanza cerosa azzurrognola che li fa apparire come “affumicati”. Oggi è vino rosso da invecchiamento, glorioso al palato con quella nota “selvatica” all’olfatto e al palato che tanto conquista e lo rende perfetto con le carni rosse e alla brace.
In Lombardia, su una terrazza sul lago, assaporiamo il Groppello. Conosciuto nella zona del lago di Garda già in epoca romana tanto da essere descritto sia da Virgilio che da Plinio il Vecchio. Vino fruttato da uve a bacca rossa, di pronta beva, adatto a consumarsi giovane con una varietà di cibi: antipasti, carni bianche, verdure. Il nome deriva dal dialettale “grop” inteso come nodo, poiché i grappoli si presentano molto serrati con gli acini a stretto contatto tra loro.
Alla base della produzione del Recioto e dell’Amarone compare il Corvina, questa antica varietà veneta coltivata sin dalla notte dei tempi sulla sponda veronese del Garda e in Valpolicella. E’ citato in documenti ufficiali a partire dal 1627 e successivamente menzionato grazie agli studi ampelografici per catalogarne il biotipo raffrontato con altre varietà simili. Il suo nome deriva probabilmente dalla somiglianza tra il colore dell’acino maturo e le piume del corvo. Trova ottimo abbinamento con carni rosse elaborate, ricche di sapori e intingoli succulenti.
In Friuli il Tazzelenghe è vitigno a bacca nera coltivato nella zona tra Buttrio e Cividale. Da giovane presenta un’asprezza e una durezza considerevoli, una intensa colorazione violacea e pertanto richiede un lungo periodo di affinamento in botte o barrique. Il nome deriva proprio dal dialetto friulano dove significa “taglia lingua” proprio a causa della spiccata acidità e tannicità. Ottimo però con intingoli a base di carni rosse con notevole grassezza, con selvaggina e formaggi stagionati.
Nei dintorni di Ala, in Trentino Alto Adige, assaggiamo l’Enanzio, antica espressione vitivinicola che presenta forti legami filogenetici con le viti selvatiche trovate nella Valle dell’’Adige. Si coltiva in Vallagarina dove si riscontrano ceppi centenari. Il nome è di origine latina: nel I sec d.c. lo storico Plinio il Vecchio lo citava tra le uve Labrusche ossia selvatiche “Labrusca hoc est vitis silvestris quod vocatur oenantium”. Varietà robusta, resistente alla fillossera che distrusse quasi tutto il patrimonio vitato della nostra Penisola, ci regala un vino con dolci note speziate, ottimo accompagnamento di carni rosse e selvaggina.
Con lo sguardo rivolto al mare, nella terra ligure, degustiamo il Lumassina, vino a bacca bianca diffuso nella provincia di Savona, tra l’entroterra di Noli e quello di Finale e Varigotti. Dà il meglio di sé nel primo anno, dove sprigiona leggerezza e notevole sapidità; ottimo per esaltare i piatti tipici: le verdure in pastella e ripiene , le frittelle, la panissa e la farinata, le alici al vapore, impanate e fritte e naturalmente ottimo con le troffie nella versione con fagiolini e patate bollite. L’origine del nome? in ligure significa “lumachina” poiché tipico era l’abbinamento con un piatto di lumache.
Una sosta conviviale in Val Trebbia, una delle zone vitivinicole piacentine in cui si coltiva l’Ortrugo. E’ il vitigno autoctono dei colli piacentini, uno dei bianchi più apprezzati e non solo nella regione. Per molto tempo dimenticato o vinificato in altre uve del territorio anche se presente da sempre nell’area, fu selezionato per le sue caratteristiche di sorbevolezza da una famiglia piacentina la cui storia risale al XVI secolo che ne promosse la vinificazione in purezza. Ottimo mariage con antipasti assortiti, salumi o pesci affumicati, i classici tortelli di magro, le minestre di verdure, piatti a base di uova e formaggi freschi.
La Romagna ci presenta il Fortana, vitigno a bacca nera di cui abbiamo notizie a partire dalla metà del XVI secolo era chiamato allora Uva d’oro, “..regina delle uve negre per fare buon vino, sano durabile e generoso..” La sua zona di produzione sono le province di Ferrara e Ravenna dove si coltiva su terreno sabbioso, un vero vino delle sabbie, caratteristica che gli ha consentito di superare il flagello della fillossera e di proporsi su piede franco, originale. Non viene vinificato in purezza per la notevole acidità ma in unione con altre varietà. La versione frizzante è considerata l’abbinamento tradizionale con l’anguilla.
Assaporiamo al fresco di una pergola che si affaccia sui castelli romani il Bellone, fragrante e profumato , vino bianco da bersi giovane in abbinamento con i piatti della classica cucina romana: minestre con le fave, risotti alle erbe, carciofi alla giudìa, asparagi e legumi. Delizioso poi con la frittura di pesce di lago e immancabile l’accostamento con il pecorino romano giovane. Si coltiva a sud di Roma a partire dai Castelli inclusa l’area litoranea di Anzio. Ha origini antichissime, citato da Plinio come uva “ tutto sugo e mosto”, compare oggi nelle Doc Nettuno e Marino.
Una bella riscoperta in Toscana è l’antico vitigno Foglia tonda, citato da alcuni dei massimistudiosi della vite nell’Ottocento, ma certamente presente da tempo immemorabile nelle splendide colline toscane. Ha maturazione tardiva, è resistente agli attacchi dei parassiti e si rivela molto produttivo. La sua foglia tonda lo caratterizza mentre i suoi componenti – tannini, sostanze coloranti, acidi lo rendono un grande rosso da vinificare anche in purezza o in assemblaggio con il Sangiovese. Grazie ad un mirato affinamento in botte, esalta salumi e formaggi, preparazioni a base di carni rosse speziate.
Nella mistica terra umbra, in un passato riscoperto e recentemente documentato era coltivato il Greco Nero di Todi, riconosciuto ormai come vitigno autoctono di Todi con il nome di Grero che va ad affiancare le varietà regionali più note: Il Grechetto, il Sagrantino, il Trebbiano Spoletino. E’ vino dal sapore unico, ricchissimo di polifenoli che gli conferiscono il bel colore viola intenso, con sensazioni di frutti rossi e spezie. Una produzione limitata e rese basse lo rendono un prodotto per palati curiosi e per veri intenditori. Con quali piatti lo accompagniamo? Con i salumi della prelibata norcineria umbra, con le pappardelle alla lepre e l’agnello scottadito….
In Molise sorseggiamo Lacrima di Morro. Conosciuto da tempi remoti, la prima citazione compare nel 1167 a proposito dell’assedio di Ancona da parte di Federico Barbarossa; vitigno di difficile coltivazione, è diffuso nell’area di Morro d’Alba il cui etimo può significare “morro” come moro (saraceno) viste le numerose incursioni dei Mori che assaltarono le coste marchigiane o come “murro” ossia castello, mentre d’Alba significherebbe “a oriente” ossia esposizioni collinari verso est . Ottimo con i maccheroncini di Campofilone al ragù, ma anche con il brodetto di pesce all’Anconetana.
Un’autentica riscoperta in Abruzzo, ed in particolare in provincia di
Chieti, è il vitigno Cococciola che sin dal nome si fa coccolare, anche se l’etimologia non è definita ed è forse di probabile derivazione onomatopeica.
Mentre nel nostro Paese era sottovalutato e vinificato in assemblaggio con
altre varietà, in Francia, oltre cento anni fa, era catalogato come vitigno di
origine abruzzese dalle buone potenzialità. Oggi questa varietà produttiva e
vigorosa è vinificata in purezza ed origina un vino fresco, fragrante, polposo
ed appagante al palato con spiccate note di pesca e albicocca.
Siamo a pochi chilometri dalla reggia di Caserta e ad attenderci è il Pallagrello (o Pallarello), una delle poche varietà presenti sia nella versione a bacca bianca che rossa. Il nome significa “rotondetto” con riferimento agli acini che hanno forma piccola e tonda, una piccola palla dunque. Il Pallagrello bianco proviene quasi sicuramente dall’antica Grecia, molto apprezzato dai nobili, era presente nella famosa “Vigna del ventaglio” del Real Sito di San Leucio , fattoria –industria sperimentale voluta da Ferdinando IV alla fine del Settecento. Nella storica vigna ogni raggio del ventaglio era coltivato con le varietà più pregiate, sia bianche che a bacca rossa. Per tutto l’Ottocento rimase uno dei vini favoriti alla corte dei Borbone, prima di conoscere un lungo periodo di oblio.
Dopo un concerto estivo a Martinafranca sorseggiamo un biondo calice di Minutolo, vitigno autoctono raro coltivato in Puglia sin dal 1200 e da sempre identificato con il Fiano di Avellino da cui si discosta per caratteri propri spiccati. Si tratta di una varietà aromatica che intorno al 2000 era quasi estinto, quindi recuperato da pochi solerti vignaioli nelle vigne della Valle d’Itria, sua terre d’elezione. Vinificato in purezza produce vini secchi e aromatici, apprezzabile nella versione spumante e passito. Nella versione secca si sposa con i latticini, con le burrate accompagnate dal pomodoro, con i crostacei e i primi piatti serviti con le classiche gustose verdure pugliesi.
E’ vino dionisiaco quello che deriva da uno dei più antichi vitigni della Calabria: il Mantonico, importato agli inizi del VII secolo a. C. dai coloni greci sbarcati sul promontorio di Capo Zeffirio, nella bassa Locride. La parola deriva dal greco “mantonikos”, a sua volta derivante dal sostantivo “mantiseos” che significa indovino, profeta. Era infatti in grado di generare un glorioso stato di ebbrezza in coloro che avevano il compito di essere “ispirati” nelle divinazioni. Da gustare con una tartare di pesce spada o paccheri di Gragnano con ragù a base di frutti di mare.
Il Carricante è un antico vitigno siciliano a bacca bianca da sempre coltivato sulle pendici dell’Etna nelle altitudini più elevate anche a 900 o 1000 metri sul versante meridionale del massiccio vulcanico. Oggi è la base della doc Etna bianco. Il termine starebbe a significare “u carricanti” che sottolinea l’abbondante produzione delle sue piante, capaci di riempire i carri d’uva. Con profumi di fiori di zagara, ottima sapidità e persistenza trova ottimo abbinamento con antipasti di mare, capesante e aperitivi sfiziosi.
Non lontano da Alghero, nell’area del Sassarese, Il Cagnulari è uva diffusa; questo antico vitigno a bacca nera viene tuttora coltivato secondo il metodo tradizionale ad alberello e solitamente vinificato con altri uvaggi per ottenere vini di grande corpo e struttura. Si pensa sia stato importato in Sardegna all’epoca della dominazione aragonese, nel Seicento . A salvare dall’estinzione questo interessante vitigno provvede, oltre alla cura dei viticoltori, la Confraternita del Cagnulari che lo propone con primi piatti conditi con sughi di carne, carni rosse, arrosti e soprattutto agnello e selvaggina.