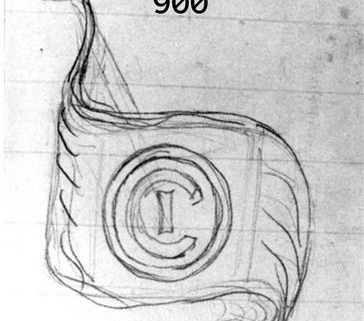Tito Giraudo ha scritto un nuovo libro. Tito potrebbe benissimo essere un personaggio del mio, in uscita in questo amaro autunno, “Orgoglio e sentimento”. E vorrei che sentiste anche voi con quale orgoglio e quale sentimento racconta in prima persona la storia, che in realtà è la Storia. Tito, come molti italiani, è il fratello maggiore della Repubblica italiana. A noi sembra sia stato sempre così, e che sia normale così. Ma se vi soffermate a pensarci un secondo sentirete addosso il sapore di qualcosa che tende a restare unica, a divenire speciale, a crearci quasi un sobbalzo dalla sedia in cui comodamente leggiamo le sue pagine e con sforzo di fantasia estremo tentiamo di vedere man mano i paesi che ci descrive, la povertà che spinge un bambino in età da scuola elementare a scappare e a trovare di che campare. Altro che apprendistato. Disagio giovanile. Dispersione scolastica, quella invece c’era e come. Il fascismo, come si poteva vivere al margine della società, avere un lavoro e non sapere nemmeno leggere un giornale, intendo neppure il nome della testata giornalistica. La normalità ha in ogni epoca i suoi metri di misura. E rileggerli nel confort delle nostre case, durante il coprifuoco delle nostre città, ha un gusto impareggiabile. Sapere che Tito è lo stesso amico che incontri nei centri culturali, alle presentazioni dei libri, in particolare quelli che parlano di futuro, di industria, e persino sui social network ti fa sentire che straordinario Paese siamo. A un certo punto l’ascensore sociale si è messo in moto. I nostri cittadini hanno fatto, hanno visto, hanno subito, sono sopravvissuti alla Storia. Coetanei della Costituzione, hanno partecipato a tutti i referendum più importanti della nostra vita democratica, hanno sentito i discorsi di tutti i Presidenti della Repubblica italiana, a me, sinceramente, fa sempre molto effetto rifletterci. Non è una cosa così scontata. E se pensiamo a Paesi vicini, capiamo di che cosa stiamo parlando. Si pensi alla Francia. Con cui ci confrontiamo spesso. La nostra è una Repubblica giovane, con una popolazione che ha la sua età. Leggiamo insieme in che mondo è nato Tito, in che modo viveva suo padre. La fiducia per il domani era tipica di chi non aveva molto da rimpiangere del giorno prima. La grande differenza con la nostra epoca nella quale è sembrato che a un certo punto ci fosse solo da rinunciare e che il meglio fosse già passato. “Il Novecento” di Tito Giraudo si legge talmente bene che sembra sia stata scritta per essere una sceneggiatura. Leggiamo insieme un estratto del libro. “Il tempo crea strani legami. Nel caso specifico, mio padre e mia madre che hanno avuto in me un figlio distante e deludente e forse queste pagine sono un inconscio esame di riparazione. Sono nato nel 1941 in pieno conflitto mondiale; allora abitavamo in affitto in una villetta condominiale al 54 di via Giacomo Medici. Le prime immagini impresse nella mia mente di bambino riguardano i bombardamenti: io e la mia famiglia in quel rifugio nella cantina di casa a filo strada, quindi del tutto inutile. Papà non aveva la minima fiducia nel potenziale bellico alleato, era convinto che bastasse. Quando però gli Alleati mostrarono di fare sul serio, corremmo nei rifugi pubblici, gallerie scavate sotto corso Lecce e piazza Risorgimento. Gli aerei arrivavano sempre di notte. Vestiti alla bell’e meglio, io piccolissimo avvolto in una coperta, attendevamo la sirena che avvisasse lo scampato pericolo. Quei pellegrinaggi notturni furono la causa probabile di una broncopolmonite che, accompagnata dalla carenza di cibo, mi fece crescere gracile. Ricordo ancora quando attraversammo a piedi piazza Statuto il 25 aprile del 1945. Mia madre, normalmente svagata, aveva capito perfettamente che eravamo la famiglia di un gerarca fascista e quindi, in assenza di mio padre, prese me e mia sorella e ci portò a piedi dalle zie, presenze importanti negli anni della giovinezza. In quella piazza sparavano: erano i partigiani che facevano giustizia e, talora, vendetta sommaria; forse alcuni meritavano il trattamento loro riservato, altri sicuramente morivano senza colpa: come avrei imparato anni dopo, le masse sono imprevedibili! Seguono logiche schizofreniche, talvolta danno il meglio, ma spesso il peggio, i repressi trovano così modo di esprimersi, l’avrei capito più tardi da sindacalista. Quel giorno, però, il bambino che ero registrava solo spari, urla e la paura di mia madre e di mia sorella Edda. Mio padre, Sempre critico nei confronti dei fascisti era per contro totalmente acritico e adorante nei riguardi di Mussolini. Pino (come Pino Torinese) era il nome che la mamma aveva dato alle Nuove, le carceri torinesi, quando andava a trovare Papà per non dire a noi bambini che era in carcere. Mio padre, tornato dalla “mattanza canavesana”, fu incarcerato insieme ai fascisti che l’avevano messo in galera negli anni del consenso, in qualità di “sovversivo pericoloso per lo Stato”. Papà tornò da Pino Torinese magro e macilento, magro per la dieta a pane e sòma d’aj (oggi si chiama bruschetta). Non so dire dove Pietro nacque, né tanto meno l’orfanotrofio torinese dove la mamma Teresa lo scaricò. È certo che Teresa, una montanara cuneese calata in città per fare la serva nella famiglia di un avvocato, rimase incinta, venne cacciata, partorì e di lei si persero le tracce. Non erano tempi felici per i figli di ignoti. Oggi si fa la coda per adottare un bambino, spesso in quell’epoca i trovatelli venivano adottati per aumentare la forza lavoro famigliare. Marx: «I proletari sono quelli che hanno come unica ricchezza la prole». Quindi aumentarla artificialmente poteva essere un affare. Prima di finire a Corio Canavese, Pietro fu adottato (si fa per dire) da alcune famiglie che cercavano prole. Certo non si sapeva cosa ne facessero, tanto che anche una giustizia approssimativa verso i poveri come quella dell’epoca, ogni volta rimandava Pietro in orfanotrofio. Ci fu anche una famiglia “per bene” che cercò di adottarlo. Nel frattempo, Pietro si era affezionato a una suora identificandola con la madre. Quando capì che quei signori lo volevano portare via, piantò un caos tale da indurre gli aspiranti genitori a scegliere un altro bambino, segno prematuro dello scarso affarismo paterno. Quando lo chiesero in adozione dei contadini di Corio, tentò nuovamente la manfrina, ma questa volta nessuno si commosse. Case Macario era ed è una frazione di Corio Canavese. La famiglia che lo allevò aveva già dei figli; l’adozione non aveva certo scopi umanitari. Non gli furono risparmiate botte e lavoro duro nei campi; unica eccezione la “nonna”, la sola che gli darà un po’ di affetto e che lui non dimenticherà mai, inducendolo, adulto e benestante, a non recidere i rapporti con la famiglia di adozione. Pietro in ogni caso non ha un carattere facile, è pieno di slanci ma è un ribelle. Lavorare va bene, ma essere picchiato e, soprattutto, non amato, per lui è insopportabile. A dieci anni scappa, offrendosi come bocia (apprendista) al panettiere di Corio; da schiavo contadino si trasforma in schiavo panettiere. Infine, i contadini prenderanno il sopravvento sui panettieri e lo riporteranno a Case Macario. Quell’assaggio di libertà convince Pietro a ritentare la fuga. Questa volta raggiunge Ciriè, un centro più importante, soprattutto più lontano da Corio dove farà nuovamente il garzone. Forse la famiglia di Corio lo cercò, ma l’epoca consentiva probabilmente una maggiore possibilità di far perdere le proprie tracce e così Pietro diventa un libero cittadino di dodici anni che si alza alle tre del mattino per impastare e cuocere il pane. A diciott’anni Pietro è un operaio della Fiat. La Torino dei primi anni del secolo vive la sua rivoluzione industriale. Oggi qualcuno pensa che la città sia noiosa e un po’ banale, e per certi versi questo potrebbe anche essere vero. Certo che, per la storia d’Italia, Torino ha giocato un ruolo fondamentale, non solo perché la sua provincialissima monarchia regnerà sull’intero Paese, ma perché in quegli anni darà vita a fenomeni socioeconomici che la compenseranno ampiamente del suo distacco da capitale. I torinesi vengono chiamati bogia nen (non muoverti); tuttavia se muovono si fanno notare. Saputo che la capitale del Regno si spostava a Firenze, piantarono una tale caciara che a paragone i moti del ‘48 furono una scaramuccia. Ancora oggi certi meridionali sono convinti di essere stati colonizzati dai piemontesi e che tutte le loro sfortune derivino da Garibaldi, Nino Bixio e company. In verità il nostro spirito colonizzatore lascia alquanto a desiderare. Avremmo di gran lunga preferito che Torino restasse il Regno dei Savoia, piuttosto che veder sloggiare la nostra corte che parlava piemontese prima, poi francese e buon ultimo un pessimo italiano. Furono anni di crisi, anche perché i torinesi sono un po’ lenti a carburare; come un motore diesel che più è caldo, e più rende. Se non si poteva più fare i cortigiani, i burocrati e i travet si poteva fare come i transalpini: gli industriali. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo a Torino nasce l’Automobile, nasce il Cinema. A Torino c’è una prestigiosa università che sforna una classe intellettuale e politica di primo ordine. A Torino il socialismo originario degli avvocati e dei maestri di scuola diventa anche il socialismo degli operai. Sempre a Torino negli anni 20 nascerà l’“Ordine Nuovo”, i cui fondatori saranno la spina dorsale del comunismo italiano. Questi, gli anni e il contesto che un trovatello analfabeta ex panettiere trova in una città caratterizzata da uno sviluppo industriale che la sta velocemente trasformando. “La Fabbrica Italiana Automobili Torino” nasce verso la fine dell’Ottocento dall’iniziativa di un gruppo di appassionati amatori di quel nuovo mezzo. Molte cose importanti spesso nascono banalmente. La Fiat lo fa in un bar vicino alla stazione centrale di Torino, Porta Nuova. Tra un vermut, un bicerin e le discussioni da bar, un gruppetto di nobili e borghesi deciderà nel 1898 di dare vita a una fabbrica comprando uno stabilimento in corso Dante, ai margini del parco del Valentino. Come Giovanni Agnelli sia diventato in pochi anni il padrone quasi assoluto della Fiat non è chiaro. Tra i detrattori che lo dipingono come un bieco approfittatore e gli elogiatori che lo considerano un genio dell’industria, c’è probabilmente la solita e banale “via di mezzo”. Sono propenso a pensare che quei nobiluomini fondatori non fossero animati dalla stessa ambizione, e forse dall’intelligenza e determinazione, di quel borghese ex ufficiale di cavalleria. Giovanni Agnelli viene nominato segretario del consiglio di amministrazione, ruolo che gli permetterà probabilmente di attuare quel “divide et impera” che gli darà il predominio sugli altri. Certamente ogni fondatore di imperi industriali (e la Fiat lo diventerà) alla spregiudicatezza aggiunge carisma, intelligenza, conoscenza degli uomini e scaltrezza nel muoversi nel contesto politico della sua epoca. Giovanni Agnelli dispone anche di una visione moderna dello sviluppo industriale che guarda agli americani e che privilegia una politica dell’immagine, antesignana di un fenomeno che sarà capito fino in fondo solo dopo il secondo conflitto mondiale. Quando Pietro è assunto in Fiat, siamo nel 1909, questa è già una realtà industriale di prim’ordine con 2500 dipendenti. Fare l’operaio, sia pure nelle condizioni del tempo, è nulla in confronto alle fatiche del passato. Egli fa soprattutto nuove amicizie, scoprendo quell’aristocrazia operaia protagonista, con la piccola borghesia intellettuale, del Movimento socialista. Pietro abita in una delle tante case di via Genova costruite per ospitare i baròt, i contadini poveri attratti dalla città e dal lavoro in fabbrica, meno massacrante e avaro di quello delle campagne. Arriveranno poi i veneti e i meridionali che non sono ancora i taron (terroni) degli anni Sessanta. Il Piemonte contadino nonostante alcune importanti riforme liberali è nella stragrande maggioranza povero. Le terre ricche sono ancora feudi nelle mani delle famiglie nobiliari alto borghesi e delle rendite finanziarie. Nelle campagne la posizione più privilegiata è quella del mezzadro, ma il Piemonte più che terra di pianura è terra di montagna e di collina. L’economia agricola è talmente povera da garantire a malapena la sopravvivenza, a parte pochi grandi fondi ancora di proprietà della nobiltà e della ricca borghesia. Non c’è molta differenza tra i contadini del Nord e quelli del Sud, poveri e analfabeti tutti quanti, con la differenza che almeno al Sud c’è il sole. Il clima delle Prealpi piemontesi è certamente meno clemente, diversi quindi i caratteri e la lotta per la sopravvivenza. Pietro ne sa qualche cosa. Lui e tanti altri, sono gli uomini che servono agli industriali. Arrivano a gruppi a Torino, per loro vengono costruite case ai margini della città, come si farà mezzo secolo dopo con l’immigrazione meridionale. I cason. Così si chiamavano le case di ringhiera. La differenza da quelle del centro storico non era soltanto data dallo stile architettonico. I cason erano grandi un intero isolato, abitate da strati sociali omogenei. Le case del quadrilatero romano, di stile barocco, erano interclassiste. Al primo piano si trovavano i nobili e i ricchi borghesi, poi man mano che si saliva, scendeva il censo. Al secondo c’erano i piccoli borghesi, gli impiegati e poi via via fino alle mansarde occupate dai servi che allora erano numerosi e a buon mercato. Le case di via Genova, dove andrà ad abitare Pietro, sono costruite per i nuovi operai di un’industria che cresce a ritmi vertiginosi. Un cortile, dei ballatoi, due o tre piani, tutte di un giallo sporco. È architettura semi contadina ma funzionale. Gli alloggi non hanno mai più di due stanze. L’ingresso è dal ballatoio con le ringhiere in ferro battuto che si affacciano su un grande cortile dove hanno sede le botteghe artigiane: il fabbro, il maniscalco, il falegname, il panettiere. Le periferie sono il nuovo che avanza. Per Pietro, queste case in confronto a quelle di Corio e la vita a Torino risultano piene di sorprese e possibilità. Il bagno finalmente sul ballatoio e non nel cortile, anche se lo deve dividere con le famiglie del pogeul (balcone). Pietro parlava in dialetto. Lo parlavano i nobili e i plebei, i ricchi e i poveri, gli industriali e gli operai. Parlavano in dialetto i Savoia, alternandolo al francese. Si dice si esprimessero malissimo in italiano, lo hanno poi imparato a Roma. Il piemontese, più di altri dialetti, è una lingua con una precisa grammatica e grosse reminiscenze francofone. Il torinese, diversamente dalle altre parlate piemontesi, è dolcemente lento. Il canavesano della famiglia di mia mamma è sguaiato, con parole di derivazione probabilmente barbarica. Tra gli abitanti della barriera di Nizza c’era molta solidarietà. Le case si erano sviluppate dal borgo San Salvario, alla sinistra di Porta Nuova verso Millefonti, e i terreni del Lingotto dove c’erano, campi, un mulino, alcune fabbriche, qualche villa padronale e una piòla (osteria). Pietro è arrivato a Torino con il treno Ciriè-Lanzo: una vaporiera che assomigliava ai treni del Far West. Torino gli sembra meravigliosa, le strade enormi, le case altissime. Diventerà a pieno titolo un’abitante della barriera. All’angolo, un caffè con un’orchestra che suona. La gente seduta ai tavolini, uomini e donne elegantissimi bevono bibite sconosciute o con un cucchiaino mangiano il gelato, lo stesso che Pietro aveva assaggiato alla fiera del paese, ma che qui è pieno di colori e servito in coppe argentate. Si ferma sotto i portici ad ascoltare e a guardare: «ampaja ij tond, pivel !» (Scappa, ragazzino!). Si sposta allora nel giardino, dove vede un capannello di uomini, alcuni ben vestiti, altri semplici come lui e più vecchi, che parlano un po’ in piemontese e un po’ in italiano. Incomprensibile, ma ne rimane estremamente affascinato. Le parole che sente ripetere, un po’ da tutti, sono socialismo e socialista. Vicino a lui c’è un giovanotto di qualche anno più anziano, si guardano negli occhi con quella strana sensazione che nasce nelle persone quando tra loro c’è, o sta per nascere, simpatia. Pietro prende il coraggio a due mani e gli chiede: «ma di cosa parlano?». «Di politica» – risponde l’altro. – «Una discussione tra socialisti e popolari.» «Ma chi sono?». «I socialisti difendono noi operai, anche i popolari dicono di farlo ma sono dei baciapile che prendono gli ordini dai preti. E tu come ti chiami?» «Pietro Giraudo.» «Piasì (Piacere!), Mario Gioda. Sono un operaio tipografo.» «Che mestiere è?» Mario tira fuori un giornale dicendogli: «a l’é sòn» (è questo). Pietro non sa leggere, ne fosse stato capace, avrebbe letto il titolo: l’Avanti!, il quotidiano del Partito Socialista Italiano (PSI). Inizia così un’amicizia che per Pietro segnerà tutta la vita e condizionerà le sue scelte future. È ancora completamente analfabeta e non riesce a capire molte cose. Mario invece, pur di famiglia modestissima, è andato a scuola. Sa leggere, scrivere e, soprattutto, fa un mestiere qualificato, in un ambiente dove anche un ragazzo di tipografia vive a contatto con chi sa scrivere bene: i giornalisti. Pietro capisce che l’amicizia con Mario, per lui, sarà importantissima, e che gli consentirà di conoscere più da vicino quello strano mondo. Mario, che prova una sincera simpatia per quel “bastardo” venuto dalla campagna, se lo porterà dietro ovunque. Una domenica mattina, alla Camera del Lavoro. Ma questo è un altro capitolo”.
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Luglio 2025
- Giugno 2025
- Maggio 2025
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it