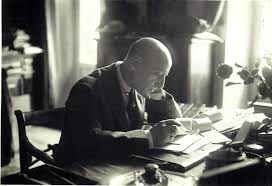Quando, il 14 febbraio del 1921, dopo aver lasciato Fiume in automobile il 18 gennaio, Gabriele d’Annunzio, «come smemorato e trasognato, col suo passo timido e quasi incerto», giusta la testimonianza del segretario Tom Antongini, a Gardone prendeva possesso della nuova dimora, Villa Cargnacco – già proprietà del famoso storico dell’arte tedesco Henry Thode, che aveva sposato in prime nozze Daniela von Bülow, figlia di Cosima Liszt e del primo marito di costei, il celebre direttore d’orchestra Hans von Bülow, – era «quasi consapevole di far ingresso in quello che sarebbe stato il suo mausoleo» (Piero Chiara). Certo il Comandante, pur conscio di aver irrimediabilmente perso la partita con Mussolini circa la leadership politica italiana, era più che mai intenzionato a occuparsi comunque ancora di politica, a esercitare la sua influenza nella vita sociale e culturale della nazione, a proseguire l’infaticabile carriera letteraria, nonché l’altrettanto prodigiosa attività di tombeur de femmes. Parte delle sue ore, specie nei primi anni ma spesso anche in séguito, doveva dedicarle all’ampliamento della nuova residenza (da lui ribattezzata “Il Vittoriale” e donata «al popolo italiano tutto» con atto notarile del 22 dicembre 1923), all’edificazione e all’inglobamento di nuove strutture, alla costituzione di quell’arredo, peculiarmente simbolico e strabiliante, finalizzato a caratterizzarne gli ambienti più personali e privati. Ma non doveva trascorrere troppo tempo perché fosse costretto a prendere coscienza che la sua era una lussuosa reclusione, dorata fin che si vuole, ma reclusione. Il 24 settembre del 1923 iniziava il suo cómpito di sorveglianza (ufficialmente di protezione) il Commissario di Pubblica Sicurezza Giovanni Rizzo, messinese, l’ “occhio di Roma”, con il quale d’Annunzio intrattenne un affabile quanto inevitabile rapporto di cordiale convivenza, servendosi anzi sottilmente di lui al fine di far conoscere per via mediata al Duce quanto non riteneva opportuno comunicargli di persona, che era invece un irrefrenabile e incontenibile fiume di richieste di finanziamenti, di agevolazioni per parenti amici conoscenti protégés, di soddisfazione dei capricci più svariati: una delle modalità, questa, della vendetta dannunziana. E fu il Vate medesimo a sollecitare per Rizzo la nomina a vice-questore prima e a prefetto poi! Si intende che non era vietato al Principe di Monte Nevoso lasciare il Vittoriale, tanto più che sarebbe stato sempre “scortato” (il Duce stesso, che più volte lo visitò a Gardone e più volte lo invitò a Roma, nel 1924 gli propose, anche per… distanziarlo un poco, di recarsi in Giappone a rappresentare al massimo livello la nazione in occasione di una rassegna di arte italiana), ma la parsimonia con cui egli si allontanava da casa si spiega come replica ironica e beffarda alla condizione di confinato di lusso. Milano (dove si tratteneva anche per soggiorni relativamente prolungati) era la mèta preferita, per impegni culturali (ad esempio, il 4 marzo del 1926, indossando la divisa di generale dell’aviazione di fresca nomina, da un palco della Scala assistette alla “prima” italiana del Martyre de Saint Sébastien – musica di Claude Debussy – interpretato da Ida Rubinstein e diretto da Arturo Toscanini; nell’ottobre del 1928 presenziò a un ciclo di concerti beethoveniani) o per curare i propri interessi presso il vecchio editore Treves e il nuovo Mondadori o per ragioni mondane e personali. Rare sortite lo condussero a Verona, Brescia, Desenzano e ancora nel 1937 si spinse fino a Parma. Tuttavia il grosso degli ultimi diciassette anni della sua esistenza lo trascorse annidato nel seno dello straordinario complesso architettonico in perpetua crescita e conformazione, dove ricevette migliaia di persone di ogni ceto e categoria, in parte ospiti invitati in parte visitatori spontanei e curiosi; promosse festeggiamenti, concerti, rappresentazioni teatrali; e si intrattenne in giochi erotici vieppiù esasperati rabbiosi inappaganti con un numero di donne (in specie femmes de passe) tale da annichilire quello registrato nel Catalogo del mozartiano Don Giovanni Tenorio («Di quanta lussuria belluina, di quanto piacere perverso, di quanta imaginazione impura io mi son nutrito in questi ultimi tempi», Libro segreto). E l’arte? La creatività? La poesia? La scrittura? Silenzio, sotto questo aspetto, quasi assoluto: paradossalmente, ma nemmeno troppo, come vedremo. Nel 1921 d’Annunzio pubblica in edizione definitiva Notturno, affascinante capolavoro («sono appunti, ricordi, notazioni, meditazioni, scatti lirici di estrema nettezza ed essenzialità, secondo la struttura di un discorso in prosa che […] tende a farsi ritmo e musica» Giorgio Bàrberi Squarotti) scritto nel 1916 a Venezia senza vedere nel periodo di cecità conseguente all’incidente aviatorio. Nel 1922 dà alle stampe Per l’Italia degli Italiani, contenente scritti politici dal 1895 al 1922, che sarà ristampato, accresciuto, nel 1926 con il titolo Il libro ascetico della giovane Italia. Nel 1924 escono Le faville del maglio, tomo I, Il venturiero senza ventura e altri studii del vivere inimitabile, raccolta di splendide prose d’arte e pagine autobiografiche apparse nel «Corriere della Sera» dal 1911 al 1914; il tomo II, Il compagno dagli occhi senza cigli e altri studii del vivere inimitabile, di contenuto origine datazione analoghi, uscirà nel 1928. Nel 1930 compare Il sudore di sangue, comprendente scritti politici del gennaio-settembre 1919, raccolta che insieme a L’urna inesausta, scritti del settembre-dicembre 1919, costituirà il volume La penultima ventura (1931). Nel 1933 vedono la luce i Canti della guerra latina, versi composti negli anni della Grande Guerra, che nell’edizione Mondadori di Tutte le opere (iniziata nel 1939) avranno il titolo di Asterope, come libro V delle Laudi. Ne L’Allegoria dell’Autunno (1934) lo scrittore raccoglie Orazioni, Elogi, Commenti, Messaggi (1895-1934), mentre Le Chèvrefeuille (1935) è la versione francese, curata dallo stesso d’Annunzio, della «tragedia moderna» in prosa Il ferro, andata in scena nel 1913 e pubblicata del ’14. E nuove creazione? Sotto questo profilo – oltre a un cospicuo numero di abbozzi, poesie e prose varie, appunti, pagine sparse, ecc. – gli anni del Vittoriale salutano la nascita di pochissime opere compiute, una sola delle quali di alto livello. Il 1936 vede la pubblicazione di due libri: Le Dit du Sourd et Muet qui fut miraculé en l’an de grace 1266, una sorta di leggenda sacra medievale o exemplum o “fioretto” nella tradizione francescana, steso in un francese di tono lirico e stile arcaicizante; e Teneo te Africa, contenente poesie, prose, messaggi (in italiano e in francese) inneggianti alla «seconda gesta d’oltremare», cioè alla conquista dell’Etiopia, con una finale «lode eroica delle tue conquiste» per il «fratello d’armi cruente e di vittorie senza strage, compagno d’ala temeraria e di spazio senza misura» Benito Mussolini. Ma altro è l’estremo capolavoro (a nostro giudizio) lasciato dal genio dell’ “Imaginifico”, vale a dire Angelo Cocles, Cento e cento e cento e cento pagine del Libro Segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, iniziato nel 1934 (anche utilizzando pagine precedenti), finito il 5 maggio del ’35 e sollecitamente pubblicato. L’opera, una sorta di “mondo di ieri” dannunziano (niente a che vedere quindi con il celebre Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers di Stefan Zweig, 1944, post.), si configura come definitiva autobiografia, ripensamento finale, bilancio della propria vita e della propria opera, riaffermazione della propria poetica, congedo da un mondo d’arte e bellezza che non fu solo quello della propria giovinezza ma quello della tradizione di cultura e poesia italiane rispetto alle quali egli si considerò «il supremo degli umanisti», convinto che «tutta la bellezza recondita del mondo converge nell’arte della parola» e che «la scrittura, l’arte del verbo, è veramente fra tutti i giochi mentali il compiuto: di là dalla pittura, di là dalla scultura, continua l’opera di creazione e dà forma al mistero estraendolo dalla tenebra per esporlo alla luce piena. Non è un caso che gli anni del Vittoriale abbiano visto la nascita di un solo libro veramente capitale e memorabile dello scrittore, un libro di saluto, però, di commiato. Perché la grande e migliore letteratura dannunziana (ma anche la più debole e retorica) nacque nel clima della libertà e dell’avventura: il “vivere inimitabile”, ormai è accertato, non era fine a sé stesso, al Poeta non importava più che tanto della vita decadentisticamente concepita e realizzata come opera d’arte, bensì la vita doveva essere concepita e vissuta per essere scritta, in funzione della scrittura che sola, o presumibilmente più a lungo, sopravvive come opera d’arte a ricordo consacrazione trasmutazione della vita mortale. Il clima del Vittoriale non era più quello dell’Abruzzo, di Roma, di Napoli, della Capponcina, di Arcachon, di Parigi, e neppure quello a suo modo esaltante della guerra, del combattimento: era un clima di confino e di prigionia, entro il quale, non vivendo, non si poteva più scrivere: non si poteva più scrivere la vita.
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Luglio 2025
- Giugno 2025
- Maggio 2025
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it