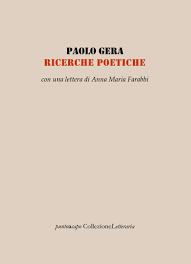Una poesia d’ispirazione civile e morale che rinunci in tutto o in parte al registro lirico e a quello satirico, cui subentra il grottesco, va incontro al pericolo di ragguardevoli cadute. È dunque doppiamente bello, dopo aver letto gli ultimi due libri di Paolo Gera (In luogo pubblico, Puntoacapo 2019; Ricerche poetiche, ivi 2021), prendere atto di come lo scrittore novese abbia scongiurato tale rischio, evitando le secche di tanta poesia contemporanea, inespressiva al di là degli intenti, greve e minaccioso cilicio per ogni lettore privo di vocazione ascetica. Entrambe le raccolte appaiono caratterizzate da un costante, rigoroso autocontrollo formale, dalla politezza di immagini ed accenti, da una sottile vena ironica – che non esclude il suo opposto – e da un amore non dissimulato per la gran macchina dell’universo verbale e le sue alchimie poetiche, capaci di piegarlo a simbolo eloquente della confusione dei nostri giorni. Vediamo sfilare in controluce le paure, le illusioni e le stoltezze che hanno funestato la società umana e i singoli individui nei tempi passati così come oggi. Ma è il presente, che lo intristisce e lo offende, a innescare la scrittura del nostro autore. Rispetto all’esistenza fisica, quella letteraria ha il cospicuo vantaggio di consentirci più di un padre, cosicché di solito non si diventa orfani… Sembra comunque ipotizzabile, a parere del sottoscritto, che lo stile di Gera abbia alle spalle, messa a frutto con umile coscienza della propria originalità, la lezione di due poeti in particolare: Giovanni Giudici (penso ad Autobiologia, 1969) e Edoardo Sanguineti (Stracciafoglio, 1980). Sia o meno corretto questo abbozzo “genealogico”, qui manca purtroppo lo spazio necessario a svilupparlo. Riprendiamo dunque il filo del discorso principale notando che i testi in prosa, variamente alternati a quelli in versi, si rivelano un ulteriore marchio di fabbrica del nostro poeta. Alla compostezza ondivaga, talvolta da bozzetto realista, delle prose, subentra l’imprevisto, il disdicevole, il colpo di reni della fantasia che si libera come una molla nel susseguirsi dei versi. È un contrasto, nella scrittura di Gera, di per sé poetico, tant’è vero che le pagine e i frammenti in prosa isolati si dimostrano talvolta inferiori rispetto a quelli accoppiati ai versi. L’opposto tuttavia non vale, poiché le composizioni esclusivamente in versi tendono perlopiù a stare in piedi da sole, soprattutto in quel gioiello d’arguzia che è la terza sezione delle Ricerche poetiche. Essa andrebbe citata per intero, impregnata com’è da una verve combinatoria alla Georges Perec, ufficialmente prosatore ma poeta inctus et in cute. Passiamo dunque ad alcuni esempi della sinergia fra il testo in prosa, che funge da pacata, solida rampa di lancio, e quello in versi, destinato a sua volta a ribaltare la prospettiva spargendo una pioggia di aculei nella mente di chi legge. Anche questa ibridazione è poesia: anzi, nell’officina di Gera, la poesia. Basterebbe, per convincersene, analizzare un paio di componimenti della raccolta In luogo pubblico: La chiesa e Lo stadio. Nel primo, un prete interrompe l’omelia e si pone teatralmente la domanda: «cosa intendiamo noi, cosa intende Gesù» per paradiso? È una pausa goffamente retorica in cui il sacerdote ha esitato «un istante di troppo», permettendo di dar voce a uno sconosciuto che si alza in piedi e «tira su la mano». I versi iniziano a fioccare e l’uomo, pur dichiarandosi ateo, snocciola le sue opinioni sul paradiso. Sono versi di manifesta intensità: «penso che saremo stretti gli uni agli altri / una cucciolata di lupi / una tenerezza di pelo che fa caldo / tutti abbracciati / senza la voglia di staccarci nemmeno per un attimo». Quanto a Dio… «e se c’è Dio è una cagna paziente / con infinite piccole mammelle». Il se, dato il contesto, suona come una larvata ritrattazione. Ma non è questo il punto, poiché nel frattempo si è sprigionata la magia dell’arte: noi lettori siamo entrati a far parte di quella scena, fino al compiersi del climax. E quale illustre predecessore s’intravede da lontano! Niente meno che Gioachino Belli e il suo sonetto Er giorno der Giudizzio, nel quale tutti i risorti saranno «come purcini attorno de la biocca. / E sta biocca sarà Dio benedetto». Anche Lo stadio ha le carte in regola per finire nel catalogo degli esiti migliori. Qui il rito, non più sacro ma profano, incatena gli sguardi mentre la folla urla compatta la propria incondizionata adorazione all’idolo calcistico. Si rende palpabile un’estasi collettiva. Il Vitello d’oro è tornato in mezzo al popolo. Quando inizia la parte in versi, chi prende la parola è un autentico relitto, un eretico, un blasfemo che non partecipa intimamente alla benedizione del trionfo. Sa di essere ormai senza scampo: «Mi sono afflosciato come una bandiera perdente / sebbene tutti dicano che abbiamo vinto / […] La pelle rabbrividisce e ho vergogna / come se nudo attraversassi il campo sotto gli occhi della folla». La chiesa e Lo stadio formano un dittico invidiabile, ma bisognerà almeno aggiungere, a questo avaro elenco, il virtuosistico tour-de-force intitolato Coro delle mimose recise. La fonte indiretta, che l’autore stesso cita in calce, è l’ultima strofa del carducciano Canto di Marzo, dalle Odi barbare. L’otto di Marzo, «festa della femmina», diventa occasione per una raffica di endecasillabi sdruccioli che appioppano schioccanti staffilate a luoghi comuni stantii, ammantati d’ipocrisia o forse solo d’inconsapevolezza: «Se la donna rivendica che è libera, / rifiuti la mimosa con il cellophan», giacché, mentre «La gialla polvere cade e sfuliggina, / un rosso sangue cola e non evapora». Senza dimenticare, con lo stesso principio dello svelamento “a posteriori”, il Coro dei bicchieri vuoti («C’è un errore di fondo / se il vino è così buono e finisce in un sorso»), componimento in versi liberi sigillato da una quartina di Omar Khayyam. Come accennavo all’inizio, la riflessione di Gera su cosa significhi scrivere poesia è uno dei temi fondamentali di entrambi i libri, tema che diviene però onnipresente (e sfaccettato in vario modo) soltanto nel secondo. La sezione eponima delle Ricerche poetiche, in particolare, vede il nostro autore impegnato in un gioco serissimo e decisivo, laddove egli evoca, con ironia e larghe sorsate di terzine simil-dantesche, il problema dei problemi: «come trasformare la prosa della spiegazione nella poesia della descrizione? […] Mi rigiro insonne da una parte all’altra del foglio bianco. Il concetto mi è chiaro, ma le parole con cui dirlo mi sfuggono» (N. 6). Come rispose Mallarmé a Edgar Degas, che si doleva con lui per aver messo a fuoco alcune splendide idee senza poi riuscire a ricavarne dei versi (cito a memoria), «La poesia non si fa con le idee ma con le parole». Infatti, se fossero sufficienti i pensieri, profondi o banali non importa, saremmo tutti, dal primo all’ultimo, poeti.
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Luglio 2025
- Giugno 2025
- Maggio 2025
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it