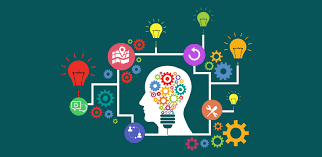Leggo con malinconia l’amaro intervento del 15 giugno di Pier Franco Quaglieni sulla crisi della scuola e credo che il problema (non a caso egli accenna a tanti ministri del passato) non sia solo attribuibile alla inconsistenza di chi al momento regge il dicastero della Pubblica Istruzione. La questione deve risalire almeno alle riforme sessantottine che cominciarono a facilitare il cursus scolastico (a partire dalla liberalizzazione degli accessi alle università) non in base a logiche pedagogiche di alto livello, ma semplicemente per le pressioni sociali che hanno trasformato le scuole e le università in enormi titolifici.
È chiaro che ogni generalizzazione è ingenerosa, poiché son sempre esistiti e tuttora esistono docenti di alto livello e alunni più che meritevoli, ma qualcosa di non insignificante è veramente accaduto.
Sia la scuola sia l’università hanno avuto infatti, nel secondo Ottocento e nel primo Novecento (per caratterizzare a grandi linee), rispettivamente un duplice obiettivo: la scuola quello della formazione della persona e dell’istruzione e l’università quello della ricerca e dell’avviamento alla professione. A rigore, il concetto di formazione implica necessariamente quello di istruzione come quello della ricerca implica quello dell’esercizio della professione. Il successo della riforma Gentile del 1923 si basava sostanzialmente su tali principî. Il che richiedeva il riconoscimento della realtà sociale come un organismo in cui ognuno dovesse svolgere il compito che gli era più congeniale, nella garanzia, come avrebbe poi affermato l’art. 34 della Costituzione repubblicana, che i capaci e meritevoli, quando privi di mezzi, sarebbero stati aiutati nel loro percorso formativo.
In tale ottica pedagogicamente sostenuta, in una società – quella attuale – legata agli slogan, il concetto potrebbe esprimersi così: l’uomo giusto al posto giusto. L’affermazione della scuola di massa dagli anni ‘60 in poi ha invece favorito il perseguimento indiscriminato di un titolo che assicurasse, a prescindere da ogni effettiva competenza, un posto di lavoro e uno stipendio, soprattutto un posto di lavoro più che dignitoso ed un congruo stipendio. Aspettative in verità legittime, solo che la scuola e l’università avevano non solo il compito di formare, ma anche il fine di valutare e orientare.
Chi ha vissuto quegli anni ormai lontani sa bene che non sempre le valutazioni erano effettivamente oggettive. Chi scrive queste righe ha conseguito grazie ai professori esterni del suo esame di maturità (quando si portavano tutte le materie e i riferimenti degli anni precedenti) i 10 nelle discipline a lui care, che non avrebbe mai ricevuto se la valutazione fosse spettata solo ai docenti interni, che prediligevano altri. Poi all’università i voti furono sempre alti. Ho voluto inserire un ricordo personale per far capire che il compito valutativo ed orientativo non è mai stato un affare di poco conto, anche per le umane simpatie che ci possono essere. Così nei primissimi anni ’70 si pensò alla figura di un professore di scuola media che fosse pure consigliere di orientamento scolastico per la scelta della secondaria, ma l’idea non andò in porto.
Ora, la soluzione che sul piano dei fatti si è imposta nel corso degli anni, al di là di ogni logica progettuale, è di garantire il percorso scolastico e universitario a tutti lasciando poi che ognuno se la sbrighi per proprio conto una volta conseguito il titolo. Non si tratta di una scelta liberale, bensì della mera accettazione dei desiderata. La selezione è stata semplicemente rinviata, affidandola per lo più a situazioni contingenti. Lasciato, pertanto, che le cose andassero da sé, tutto è stato paradossalmente consequenziale. Sulla scuola e sull’università non si è voluto investire quanto sarebbe stato auspicabile e dunque in maniera considerevolmente inferiore a molti paesi europei. Insegnanti mal pagati e organico insufficiente. Di qui il fenomeno delle cosiddette classi-pollaio e della gravissima riduzione degli strutturati nelle università.
Il problema dell’organico (e della sua valorizzazione) non è affatto secondario. Né si può risolvere ricorrendo ad assunzioni indifferenziate o a tempo determinato. Ad avviso dello scrivente, ad esempio, per quanto riguarda l’Università, dove egli ha trascorso più di mezzo secolo della sua vita, la carenza dell’organico è drammatica. D’altra parte è assurdo pensare a continuare a mantenere l’Abilitazione Scientifica Nazionale (che poteva anche essere concepita come una ripresa dell’antica libera docenza) se si creano soltanto delle liste di attesa. Sarebbe un gesto coraggioso e intelligente che il governo volesse chiamare in ruolo tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione universitaria di professore associato (sospenderei, nella fattispecie, quella per ordinario che richiede una valutazione più soppesata) immettendo così nuove forze nell’università ed evitando che i diversi contesti locali scelgano in base a situazioni particolari. Si avrebbe così un adeguato aumento dell’organico e un ringiovanimento dello stesso, libero da ogni appartenenza precostituita. Sull’avvaloramento della ricerca non occorre esitare, né lesinare alcuna risorsa.
Al contrario, volendo usare una battutaccia, l’imperativo di fondo di questi decenni è stato arrangiatevi! E di conseguenza dirigenti e docenti di ogni ordine e grado hanno fatto quello che hanno giudicato opportuno, che poteva essere quello della coscienza, quello della scienza, della mera rassegnazione non importa.