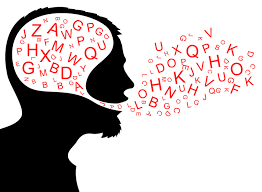Per l’induismo lo scopo ultimo della vita umana è la Realizzazione. Dobbiamo abbandonare la identificazione con il mondo materiale, che è illusorio, operata dalla mente inferiore e operare la identificazione con la Realtà, con l’Assoluto. La Realtà appartiene al nostro più intimo essere interiore, ma non ne siamo consapevoli per via della identificazione con il mondo illusorio. Si tratta di un risveglio, di una liberazione dall’illusione verso la Realtà (Brahman), che è la nostra anima individuale (ātman), cioè la nostra Coscienza autentica, della quale però abbiamo perso la memoria. All’inizio Coscienza e Potere erano uniti nel Brahman, in seguito si divisero e si manifestarono molti poteri settoriali, dei quali le diverse divinità induiste sono simboli. Le divinità sono molte, in particolare la Gayatri Devi è una divinità femminile che ha nello specifico il potere di far passare l’individuo dalla identificazione illusoria (Maya) al risveglio della Coscienza, cioè al ritorno alla conoscenza della vera Realtà. Gayatri Devi è considerata la madre dei Veda, i testi sacri dell’induismo. I Veda sono stati intuiti dai Rishi, che hanno cercato di mettere in parole umane quella rivelazione assoluta. La parola umana è imperfetta, quindi i 4 Veda (Samhita) tramandati oralmente per millenni in lingua vedica non racchiudono l’intera rivelazione. Tuttavia Gayatri Devi è la madre dei Veda in quanto essi si avvicinano, seppur imperfettamente, alla conoscenza assoluta, quella del risveglio della Coscienza, che era appannaggio dei Rishi, dalla quale hanno tratto i Veda. La prima manifestazione del Brahman è la Parola Assoluta (Shabda-Brahman), la quale ha dato luogo alla Nada, la prima vibrazione sonora alla base del mondo manifesto, dalla quale si dipartono come rami da un albero tutte le vibrazioni e le altre energie che costituiscono il mondo materiale e i mondi sottili. Tutto ciò che vediamo con i sensi e i mondi non sensibili sono costituiti da vibrazioni, le quali sono come l’eco, multiforme, della unica vibrazione originaria. Soprattutto gli induisti conoscono il potere dei mantra. Un mantra è una espressione che, mediante ripetizione continuata (japa), sarebbe in grado di esercitare degli effetti. Un mantra può essere costruito solo dai grandi Occultisti e dagli Adepti (quali erano i Rishi) i quali, conoscendo le vibrazioni come se fossero per loro un libro aperto, possono fare delle combinazioni e permutazioni di suoni di una lingua che abbiano efficacia. Sarebbe possibile usare queste vibrazioni, espresse dai suoni di una lingua, costruendo dei mantra che ripetuti possono sortire effetti positivi o negativi sul mondo circostante, materiale e sottile. In buona sostanza la disciplina contenuta nei Mantra-Sastra usa i mantra per sortire effetti materiali, cioè sul mondo materiale, siano essi positivi o negativi (molti esperti di magia nera fanno uso di mantra). Invece la disciplina del Mantra Yoga adotta i mantra per il risveglio della Coscienza. I principi dei Mantra-Sastra e del Mantra Yoga sono gli stessi, ma le applicazioni sono del tutto differenti. Bisogna aggiungere che i Rishi, che hanno messo in parole umane i Veda, hanno usato la lingua vedica, ma il potere di un mantra non sta nel vedico, ma unicamente nei suoni, i quali riecheggiano le vibrazioni di cui è costituito il mondo. I grandi Occultisti e gli Adepti possono costruire mantra, fondandosi sulla disciplina delle vibrazioni, anche in altre lingue. Il principio che sta alla base del Mantra Yoga è che tutto è vibrazione, o meglio un insieme di vibrazioni, le quali dipendono dalla vibrazione originaria. Sia il mondo materiale sia i mondi non materiali sono formati da vibrazioni. Per questo i mantra possono sortire effetti sia materiali sia sulla Coscienza. Ripetendo un mantra sarebbe possibile utilizzare quelle vibrazioni per sintonizzarci sulla vibrazione originaria. Noi stiamo tutti in uno stato dormiente, siamo preda delle illusioni e la nostra Coscienza, che coincide con il Brahman, la vera Realtà, è ottenebrata. I mantra sarebbero in grado di risvegliare l’individuo facendolo accedere alla conoscenza della vera Realtà, cioè alla unione della sua anima individuale con l’Assoluto, la Coscienza, la vera Realtà. La vibrazione esercitata dalla ripetizione del mantra sintonizzerebbe la nostra identità sulla conoscenza della Realtà. Siamo come radio difettose che prendono solo frequenze basse e non quelle più importanti. Il mantra rettificherebbe la nostra capacità di sentire le frequenze più alte, cioè di accedere alla vera conoscenza. Il risveglio può essere ottenuto in vari modi, tra cui i mantra. E tra i mantra, dopo la sacra sillaba AUṂ, il più importante per l’induismo, quello che costituisce la parte più importante di tutti i Veda (Rig-Veda III, 62, 10), è questo: Meditiamo sullo splendore eccelso del divino Sole, il quale possa illuminare le nostre menti. Questo mantra prende il nome dalla Gayatri Devi e si chiama per l’appunto Gayatri. Evoca il potere di questa dea di esercitare il risveglio della Coscienza. Il Sole di cui si parla è la Realtà, alla quale si chiede di risvegliare l’individuo. Quando si recita il mantra non si venera solo il Sole fisico, ma il Parabrahman (Principio Universale Supremo) che è nel Sole, cioè il Dio Assoluto. Quindi si venerano lo Shiva Solare, il Vishṇu Solare ed il Brahma Solare perché anche loro sono parte del Parabrahman Solare. Quando si prega il Dio Solare si ricevono tantissime benedizioni. La Gayatri quindi è sia un mantra sia una preghiera. La Gayatri viene recitata in vedico ogni giorno dagli induisti: (Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ) tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt. Si crede possedere una forza straordinaria, anche in ragione del fatto che è composto di 24 sillabe, quali sono le sostanze primordiali. Queste concezioni dell’induismo sono in un certo modo simili a quelle della cabala ebraica. La cabala è stata per l’ebraismo ciò che la gnosi è stata per il cristianesimo. Ebraismo e cristianesimo sono religioni rivolte a tutti, invece cabala e gnosi sono gli insegnamenti esoterici, riservati a pochi iniziati. Per la cabala il mondo è stato creato da Dio attraverso le 22 lettere dell’alfabeto ebraico. Quindi nella Bibbia ebraica ci sarebbero i principi fondamentali del mondo manifesto, ma criptati in codici che solo i cabalisti sanno decifrare. La prima espressione del primo libro della Bibbia è: “In principio Dio creò”, in ebraico be-reshit barà ‘Elohim. Be-reshit significa “in (be-) principio/inizio (reshit)”. L’alfabeto ebraico ha anche un valore numerico e la lettera Bet, quella di be-, ha valore numerico di 2. Quindi per i cabalisti il vero messaggio dell’espressione ebraica sarebbe: “Dio creò un secondo (be-) inizio (reshit)”. Questa sarebbe una seconda creazione, il Mondo della Rettificazione. Per i cabalisti prima di Adamo e Eva ci sarebbero state ben 974 generazioni. Si trattava di mondi instabili, dominati dall’egoismo, che andavano tutti in dissoluzione. Era il Mondo del Caos. Fino a quando Dio non compie un secondo inizio. Questa seconda creazione, modellata dalle 22 lettere dell’alfabeto ebraico, contiene in esse i principi, in codici da decrittare, affinché noi esseri umani possiamo imparare a rettificare noi stessi e il mondo. Facciamo un solo esempio. La lettera Dalet apre la porta della nostra conoscenza alla povertà (dalut). I cabalisti dicono che Dio ha creato i poveri affinché noi possiamo provvederli (gamol) con bontà. Quindi la Dalet esprime la povertà, invece la Ghimel è associata all’armonia. Dio fa esistere i poveri affinché noi possiamo aiutarli. Da un punto di vita linguistico, la parola ha due aspetti fondamentali: il Significante è quello esterno (la forma grafica, il suono), il Significato è il contenuto. Il termine “parola”. La definizione di parola è molto discussa; tuttavia, insostituibile perché fa parte del lessico comune, per indicare un’unità significante della lingua, un segno linguistico sia esso minimo o scomponibile in unità più piccole. “Termine”, “segno linguistico”, “vocabolo” vanno in questo contesto considerati sinonimi di “parola”. Ma soffermandoci di più sulle sue definizioni, sicuramente la più comune è quella di Bloomfield del 1933: secondo il linguista, la parola è la più piccola unità di significato in una data lingua, tale che possa essere adoperata anche da sola e costituire così una frase (parola-frase o frase monorematica): parole sono ad esempio “vado” o “basta” che da sole possono anche essere parola-frase. Le parole possono essere: lessicali: si tratta di una classe aperta (sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi (hanno un significato definibile); oppure grammaticali: si tratta di una classe chiusa (pronomi, determinanti, preposizioni, congiunzioni e interiezioni. La definizione di Bloomfield ha però dei limiti, alla luce dell’evoluzione della linguistica testuale e degli studi sul lessico. Es: “macchina per cucire”, è una parola, sono due o tre? Per questo si preferisce parlare di lessema. Il registro è una varietà della lingua distinguibile per I’ uso che se ne fa in determinate situazioni: “a variety of language distinguished according to its use is register”. È il ripetersi di alcune condizioni in relazione a fattori determinati dai partecipanti, dal contesto e dalle funzioni comunicative che porta a sviluppare marcatori peculiari (stilistici) in termini di struttura e di uso della lingua. E, naturalmente, il grado di formalità o informalità della situazione comunicativa è una delle variabili determinanti il registro. Siamo quindi nell’ambito della variazione diafasica, quella variazione che un dato codice subisce per far fronte alla situazione nella quale la comunicazione avviene. Sempre valide per orientarsi nell’individuazione delle caratteristiche di registro sono le categorie hallidayane di campo, tenore e modo. Per essere utile a ben comprendere un atto comunicativo, l’analisi del registro in termini di campo, ovvero contenuto, idee, focus istituzionale; tenore, ovvero status dei partecipanti e rapporto (gerarchico) tra loro; modo o canale di comunicazione (di base, se scritta o orale), deve spostare l’attenzione dal cosa al perché e al come della lingua in atto. Anche Sobrero sottolinea come i livelli stilistici a disposizione dipendano da fattori situazionali che egli però individua nel destinatario, nell’argomento e nello scopo lasciando da parte l’altro attore della comunicazione — il mittente (invece contemplato nel concetto di tenore del discorso) — e la modalità comunicativa (ovvero il modo del discorso nel modello di Halliday), menzionando invece un altro aspetto importante, ossia Io scopo della comunicazione. Soprattutto se finalizzata alla traduzione, l’analisi delle peculiarità linguistiche deve arrivare a comprendere il perché di determinate scelte in relazione alla situazione comunicativa. Le scelte di registro (campo, tenore e modo) saranno ovviamente influenzate da fattori extralinguistici quali lo scopo della comunicazione e il genere prescelto. Lo stesso Halliday ci mette in guardia poiché tali variabili si influenzano a vicenda. Halliday nota come la distinzione tra forma (style o form o manner) e contenuto sia illusoria perché non si può separare ciò che si dice da come lo si dice e neppure dal perché lo si dice. Il rapporto tra le varietà di una lingua e la lingua “di base” o common core (Pit Corder) può essere osservato da due diverse e contrapposte prospettive:
- Esiste un nucleo di base (common core) sul quale si fondono tutte le varietà di una lingua e che è evidentemente condiviso da queste ultime;
- Non è possibile far riferimento a un common core, un “nucleo comune” alla varietà di una lingua, poiché la lingua si concretizza sempre in una determinata varietà.
Dudley-Evans e St John sviluppano un approccio all’analisi dei registri volto a identificare item e strutture grammaticali particolarmente frequenti in un campo specifico. Lo sviluppo di software per l’analisi delle concordanze ha spinto molto avanti questo tipo di studi, consentendo anche l’individuazione di cooccorrenze significative. Balboni ritiene che le caratteristiche (sintattiche) ravvisabili in alcuni contesti comunicativi presentavo “atipicità quantitative”, non qualitative. È bene, quindi non dimenticare mai che qualsiasi evento comunicativo attinge al common core di una determinata lingua, sebbene possa mostrare delle costanti che, se reiterate in testi appartenenti allo stesso dominio, iniziano ad essere considerate tipicità legate a quel registro all’interno di un certo contesto. La lingua assume caratteristiche e peculiarità determinate da una serie di variabili:
- Variazione diacronica: variazioni temporali (es.: italiano contemporaneo e del secolo scorso)
- Variazione diafasica: riguarda le interazioni tra individui (es.: linguaggio familiare, burocratico, etc.)
- Variazione diastratica: dipendente da variabili di tipo sociale (varietà linguistiche alte e basse)
- Variazione diatopica: determinato da varianti spaziali (es. italiano settentrionale o lombardo).
- variazione diamesica: condizionato dal mezzo usato nella comunicazione (orale/scritto/tecnologie).
La traduttologia contemporanea dà molta importanza all’elemento lessicale, inteso però “in contesto”. Già nel 1977 Vinay e Darbelnet riprendevano le definizioni saussuriane di significante (rappresentazione materiale del segno) e significato (contenuto concettuale) per muovere alcune osservazioni a cavallo tra due lingue: se un termine ha un equivalente esatto in un’altra lingua, può verificarsi il caso di un significato che ha due significanti diversi (in due codici diversi). L’esatta equivalenza è molto rara: esempio bread/pain/pane; è diverso per aspetto ma anche per importanza alimentare nelle diverse culture. Quindi è il contesto socioculturale che determina le associazioni connotative di un termine in contesto. Allora anche in presenza di un traducente “trasparente” la traduzione potrebbe avere bisogno di alcuni adattamenti atti a garantire un effetto equivalente in lingua d’arrivo. P. Vinay e J. Darbelnet analizzano il il processo di traduzione. Esso comprende cinque fasi:
- Individuazione delle unità traduttive Rifiutano la parola singola insieme di unità lessicologica e unità di pensiero. L’unità traduttiva è il segmento più piccolo dell’enunciato i cui segni sono collegati in modo tale da non dover essere tradotti singolarmente
- Analisi del testo nella lingua di partenza, valutando il contenuto descrittivo, affettivo e intellettuale delle unità
- Ricostruzione del contesto metalinguistico del messaggio
- Valutazione degli effetti stilistici
- Produzione e revisione del testo di arrivo.
Dare per scontato l’equivalente di un termine impedisce di vedere altre possibili traduzioni e le eventuali sfumature di senso legate alla sua collocazione in un dato contesto. La pluralità di significati di un elemento lessicale crea problemi di comprensione innanzitutto a livello intra-linguistico. Molte sono le parole polisemiche, soprattutto a cavallo di contesti comunicativi diversi. Per esempio “capo”: parte del corpo / colui che da ordini. Ancora una volta è importante è il contesto. La posizione di un termine all’interno di un testo, ossia la conoscenza dell’ordinamento sintattico, affiancata da un corretto uso del dizionario e da una conoscenza sia pure non approfondita dell’argomento trattato, permettono una traduzione efficace. L’operazione che un buon traduttore deve compiere, pertanto, consiste nel ricondurre i singoli segni linguistici a ciò che significano non in quanti tali ma nella specifica combinazione semantica, “in contesto”. È bene privilegiare la componente semantica affinché il senso sia rispettato, ma il significato di un testo viene colto appieno solo se si tengono ben presenti le relazioni tra le varie parti di cui è composto. Si inizia a ragionare in termini di equivalenza tra due sistemi linguistici quando la traduzione parola per parola non rende il significato del testo. Questo concetto ha preso corpo grazie agli studi di Vinay e Darbelnet, Jakobson, Nida, Catford (tra gli anni ‘50/’60). Gli studiosi muovono da considerazioni fondate sull’analisi contrastiva tra due lingue, soprattutto a livello grammaticale. Il loro punto di vista è che tradurre equivale a “sostituire” un testo in una lingua con un testo in un’altra lingua. Quindi, il lavoro del traduttore consiste nel tentare di ridurre o azzerare la distanza tra due lingue operando dei cambiamenti laddove la “traduzione diretta”, cioè letterale, con il ricordo a prestiti e a calchi, non funziona. La “traduzione obliqua” è fatta di quelle “trasposizioni”, “modulazioni”, “adattamenti” necessari ogniqualvolta la traduzione diretta non è in grado di funzionare. Per creare equivalenza ci si basa perlopiù su una corrispondenza formale e non funzionale tra testo di partenza e testo di arrivo. R. Jakobson (On linguistic aspects of translation, 1959) scrive un saggio di fondamentale importanza nell’ambito delle riflessioni teoriche sulla traduzione, sul ruolo che la traduzione riveste nelle riflessioni in campo semiotico, sulla traduzione come concetto. Analizzando il concetto di equivalenza, nel saggio troviamo due affermazioni, una di Russel e l’altra di Jacobson che non è proprio d’accordo con quella del collega:
- “Nessuno può comprendere la parola formaggio, se prima non ha un’esperienza non linguistica del formaggio” (B. Russel)
- “Nessuno può capire la parola formaggio se non conosce il significato attribuito a parola nel codice lessicale italiano” (R. Jakobson).
Jakobson afferma che “il senso delle parole è un fatto semiotico”. Effettivamente qualsiasi concetto può essere spiegato tramite la definizione, parafrasi, e così via. Infatti, egli continua affermando: Qualsiasi membro di una collettività culinaria che ignora il formaggio capirà la parola italiana formaggio se sa che in questa lingua tale parola significa “alimento ottenuto con la fermentazione del latte cagliato” e se ha la conoscenza linguistica di “fermentazione” e “latte cagliato”. In effetti, le parole come “ambrosia” e “nettare” sono dei concetti di cui nessuno ha avuto mai esperienza, ma che conosciamo perché fanno parte di mitologia greca, essendo cibo e bevanda degli dei. Inoltre, egli dice: “Non esiste significato senza segno”, cioè il senso di una parola non deve essere attribuito all’oggetto, ma al segno e poi dice che “E’ necessario ricorrere a una serie di segni linguistici se si vuol far comprendere una parola nuova”. Così come in italiano, quando qualcuno vuole farci comprendere un concetto, lo spiega per rendercelo più comprensibile. Quello che Lui osserva alla fine è che: “Il senso di una parola altro non è che la trasposizione di esso in un altro segno che può essere sostituito a quella parola, specialmente in un altro segno ‘nel quale si trovi sviluppata più completamente’, come afferma Peirce”. Quando spieghiamo con altre parole una determinata cosa, non facciamo altro che trasporre quel determinato segno in un altro segno o in una serie di segni. Da qui, Lui arriva a formulare la “tripartizione della traduzione”, cioè individua più forme diverse di traduzione:
- La traduzione endolinguistica (intralinguistica) o riformulazione: all’interno della stessa lingua (es. definizioni condizionali, sinonimi)
- La traduzione interlinguistica o traduzione vera e propria: tra lingue diverse
- La traduzione intersemiotica o trasmutazione: quando avviene il passaggio da una lingua naturale ad un altro sistema che non sia della lingua naturale (es. traduzione di “Pinocchio”, lingua dei segni).
Dunque, “la traduzione endolinguistica di un termine si serve di un altro termine, più o meno sinonimo, o ricorre a una circonlocuzione”, però quando si parla di sinonimi, Jakobson dice che “non esiste un’equivalenza perfetta” anche perché sappiamo che i sinonimi spesso sono “quasi” sinonimi, cioè non possono essere usati indifferentemente negli stessi contesti. Per cui in alcuni casi si può utilizzare, ad esempio, “vecchio scapolo” e “celibe” che non sono intercambiabili “ogni vecchio scapolo è un celibe, ma ogni celibe non è un vecchio scapolo”.
Bibliografia
- C. Chalier, Le lettere della creazione. L’alfabeto ebraico, Firenze 2011;
- B. Di Sabato, E. Di Martino, Testi in viaggio. Incontri fra lingue e culture, attraversamento di generi e di senso, traduzione, Torino 2011;
- I. K. Taimni, Gayatri. La madre dei Veda, Roma 2017.