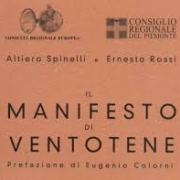Quando mi è stato chiesto di scrivere per il Pannunzio Magazine la critica (si fa per dire) del film: “Il traditore”, mi sono immediatamente venuti in mente i ricordi di quando Alberto, il fratello di Marco Bellocchio, mi parlava dei suoi fratelli un poco pazzi. Marco aveva appena girato: “I pugni in tasca”, l’altro fratello, Pier Giorgio, militava nei gruppuscoli estremi, entrambi epigoni del 68 che era alle porte.
Io e Alberto, eravamo i boys di Piero Boni, mitico segretario socialista della FIOM, quello che in un congresso storico sconfisse Bruno Trentin e la corrente comunista. Fu la vera svolta sindacale che cambiò radicalmente il Movimento.
Perché questi ricordi?
Guardando su commissione il film, che tra l’altro ho trovato molto bello, ho considerato come si cambia nella vita. Alberto era il socialista saggio della famiglia ed ora fa il poeta. Pier Giorgio è un distinto critico letterario, nonché scrittore, nonostante nel 62 fondasse i “Quaderni Piacentini” sulla falsariga del “Quaderni rossi” del mio amico Vittorio Rieser, per di più nel 69 fu direttore responsabile di “Lotta Continua”
Pochi credo ricordano “i pugni in tasca” (1965), un’allegoria sulla famiglia borghese che aprirà la strada della contestazione di un’istituzione che, pur allora mostrando i segni del tempo, non meritava certo tanto estremismo. Che dire poi de “La Cina è vicina” del 67, che aprirà la strada dell’innamoramento sessantottino per Mao, vista l’ormai palese impresentabilità sul mercato marxista dell’URSS.
Secondo me, la metamorfosi di Marco Bellocchio raggiunge il suo culmine con “il traditore”.
Per la verità i segni c’era tutti. Nella sua ultima filmografia la contestazione della società e dei costumi lascia il posto alla matura riflessione: in questo caso, storica e di costume.
Tornando al “Il Traditore”, il film inquadra magistralmente, il primo pentito mafioso della nostra storia, scolpito nelle sembianze popolane di Favino che disegna il personaggio Buscetta come meglio non si poteva, marcandone tutte le contraddizioni, non solo all’interno della cupola mafiosa, nell’ambito della quale, sicuramente per sua scelta, non ricoprì, credo volontariamente, un ruolo di grande rilievo dedicandosi alle donne e agli affari di droga in Brasile che ne faranno un uomo ricco e rispettato.
E’ evidente che Bellocchio, mostra una certa simpatia per il personaggio, simile forse a quella che provò Falcone.
Il film, inizia con la cerimonia di pacificazione tra le fazioni mafiose nella notte di Santa Rosalia, quando i Corleonesi di Totò Riina suggellarono una pace che tradiranno poco dopo.
Prudentemente, Buscetta scappa in Brasile facendo perdere le sue tracce dedicandosi al traffico di droga, sotto falso nome e dopo aver fatto una plastica facciale. Ne faranno le spese in Sicilia, due dei suoi figli, il cognato e il fratello e un certo numero di picciotti suoi amici, segno che Buscetta non veniva considerato un semplice soldato.
La svolta che ne farà un pentito, credo, più che la strage dei familiari, è l’arresto in Brasile dove anche sotto tortura non farà nomi, fino a che il giudice Falcone ne chiederà l’estradizione in Italia.
La parte più debole del film, secondo me, è una certa superficialità nel descrivere il rapporto tra l’inquirente Falcone e Buscetta. Forse sarebbe valsa la pena dare una maggiore attenzione al personaggio Falcone e ai veri motivi del pentitismo, al di là delle scontate affermazioni buscettiane sulla vecchia mafia che rispettava donne e bambini e, cosa risibile, aiutava la povera gente, liquidate con l’espressione di incredulità da parte del giudice.
Il film riprende vigore nelle scene del maxi processo, dove Buscetta inchioda senza appello i mafiosi dietro le sbarre in quell’aula di tribunale.
Ho letto alcune critiche da sinistra; non potendo criticare troppo un regista d’area si è preferito descrivere i personaggi in gabbia come un tentativo allegorico del regista. Ciò dovuto al fatto che per una certa “antimafia”, non passa l’idea che quella fu una delinquenza rozza e ignorante, descritta invece magistralmente dal regista, il quale forse per dare un contentino fa comparire Andreotti in mutande mentre prova un vestito dallo stesso sarto di Buscetta, quella scena descritta anch’essa come “allegorica” è invece la prima marchetta di sinistra del Film.
Magistrale e molto esemplificativa, la scena dell’ultima testimonianza di Buscetta al processo Andreotti.
L’uomo, appare l’ombra del personaggio sicuro di sé del primo processo, balbetta, è smarrito, non regge alle pressanti contestazioni dell’avvocato Coppi (qui un’altra marchetta facendo passare un vero principe del foro come un leguleo difensore di mafiosi). Tuttavia pochi spettatori saranno rimasti con l’impressione che Buscetta avesse paura di un’Andreotti detronizzato, piuttosto della sensazione sul tentativo di servirsi da parte dei novelli giudici antimafia del grande pentito di un tempo.
Tempo di Falcone e non del professionismo dell’antimafia. Ma si sa, ognuno i Film li legge come crede.
Tito Giraudo