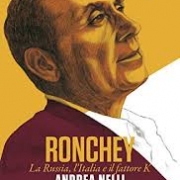I contenuti della riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 ottobre 2019, n. 240, è stato pubblicato il testo della legge costituzionale che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo il numero dei parlamentari. Pubblicazione ai soli fini conoscitivi, perché l’iter che precede l’entrata in vigore non si è ancora concluso.
Le modifiche costituzionali hanno un contenuto chiaro, semplice da descriversi. Quanto all’articolo 56 della Costituzione: il numero dei deputati, attualmente quantificato in 630, è ridotto a 400. Di questi, il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, attualmente quantificato in 12, è ridotto ad 8. Un’ulteriore modifica riguarda il quarto comma dell’articolo 56: per la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, occorre dividere il numero degli abitanti della Repubblica, risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, per il nuovo divisore 392 (dato dal numero 400 meno gli 8 deputati eletti nella circoscrizione Estero). Poi i seggi sono distribuiti in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Quanto all’articolo 57 della Costituzione: il numero dei senatori elettivi, attualmente quantificato in 315, è ridotto a 200. Di questi, il numero dei senatori eletti nella circoscrizione estero, attualmente quantificato in 6, è ridotto a 4. Al terzo comma si stabilisce che nessuna Regione, o Provincia autonoma (le Province autonome sono soltanto due: Trento e Bolzano), possa avere un numero di senatori inferiore a tre. Il testo vigente riguardava esclusivamente le Regioni e stabiliva, invece, un numero minimo di sette. Restano invariate le specifiche previsioni per il Molise (due senatori) e per la Valle d’Aosta (uno). La modifica relativa al quarto comma dell’articolo 57 della Costituzione riguarda la ripartizione dei seggi del Senato fra le Regioni e le Province autonome, in proporzione alla loro popolazione. Anche in questo caso la novità sta nell’aver attribuito rilevanza alla dimensione della “Provincia autonoma”; tutto ciò ha pratiche conseguenze soltanto nel caso della Regione Trentino-Alto Adige.
Quanto all’articolo 59 della Costituzione: si fissa un limite più chiaro al potere del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, fra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori a vita nominati dal Presidente non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Il testo della novella costituzionale finisce qui, ma occorre considerare attentamente pure quanto stabilito riguardo alla “Decorrenza delle disposizioni”. Si prevede che le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, che, come si è visto, riguardano, rispettivamente, la composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si applichino a decorrere: a) dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all’entrata in vigore della presente legge costituzionale; b) in ogni caso, non prima che siano decorsi sessanta giorni dal momento in cui la predetta legge costituzionale entra formalmente in vigore. Le due parole “scioglimento” e “cessazione” che si leggono sub a) si riferiscono, rispettivamente, all’ipotesi della conclusione anticipata della Legislatura ed all’ipotesi della conclusione naturale alla scadenza del quinquennio (articolo 60, primo comma, della Costituzione).
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, una riforma costituzionale che non sia stata approvata con una maggioranza di due terzi, in seconda deliberazione, tanto dal Senato quanto dalla Camera, può essere sottoposta a Referendum confermativo, quando lo richiedano: a) un quinto dei membri di una delle due Camere; b) cinquecentomila elettori; c) cinque Consigli regionali. Nel nostro caso, la maggioranza di due terzi si è raggiunta alla Camera, ma non nella, precedente, seconda deliberazione al Senato.
I fatidici tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale scadranno nel mese di gennaio del 2020; solo allora si saprà se sarà in campo una richiesta di Referendum popolare confermativo, validamente formulata. Qualora si effettui il Referendum, la legge costituzionale sarà promulgata soltanto se approvata dalla maggioranza dei voti validi. Com’è noto, nel Referendum costituzionale confermativo non c’è quorum di validità; prevale, dunque, la maggioranza relativa dei votanti.
Per riassumere: la legge costituzionale entrerà in vigore se, dopo tre mesi dalla pubblicazione, non sarà stato chiesto il Referendum nelle forme e modalità prescritte; oppure se, dopo lo svolgimento del Referendum, risulterà approvata dalla maggioranza dei voti validi.
L’ultimo passaggio parlamentare, quello dell’8 ottobre 2019 alla Camera dei deputati, indurrebbe a pensare che la novella costituzionale incontri un consenso vastissimo fra le forze politiche, sia da parte dei Gruppi parlamentari che sostengono il Governo, sia da parte dei Gruppi parlamentari di opposizione. La riforma, infatti, ha ottenuto 553 voti favorevoli, mentre i “No” sono stati soltanto 14 e gli astenuti 2.
Tra i Gruppi attualmente all’opposizione, la Lega e Fratelli d’Italia hanno convintamente sostenuto la riforma costituzionale in tutte le fasi dell’iter parlamentare; anche il Gruppo di Forza Italia si è sempre dichiarato a favore, in questo caso però con qualche distinzione individuale.
A ben vedere, in questa seconda deliberazione della Camera, le considerazioni di ordine strettamente politico hanno sicuramente inciso sul voto dei deputati: ad esempio, il Gruppo del Partito Democratico che, in precedenza, si era sempre opposto alla riforma, ha votato a favore per non contraddire, sul nascere, la nuova alleanza di governo con il Movimento Cinque Stelle.
Si assiste così al curioso fenomeno di deputati i quali, dopo aver votato “Si” nell’ultimo voto per la riforma, hanno, pochi giorni dopo, sottoscritto la richiesta di Referendum.
2. Le precedenti proposte di riduzione del numero dei parlamentari.
L’opposizione più vivace ai contenuti della riforma costituzionale si è manifestata finora nella società civile ed è stata alimentata da forze politiche di minoranza, come ad esempio il Partito Radicale transnazionale, non rappresentate in Parlamento. Le critiche possono essere ricondotte fondamentalmente a tre argomenti. Il primo è la difesa di principio della democrazia rappresentativa, o democrazia parlamentare, anche definita “democrazia liberale” tout court. Il secondo argomento è la protesta contro la asserita compressione della rappresentanza. L’ultimo argomento è la protesta contro chi vorrebbe realizzare qualche modesto risparmio di spesa pubblica, tagliando i “costi della democrazia”.
I sostenitori della democrazia rappresentativa, o parlamentare, o liberale, che dir si voglia, muovono da un classico sillogismo. Premessa maggiore: la riforma costituzionale è stata concepita e voluta dal Movimento Cinque Stelle, il quale ne ha fatto un proprio cavallo di battaglia. Premessa minore: il Movimento Cinque Stelle avversa la democrazia parlamentare ed è fautore della democrazia diretta. Conclusione: la riforma costituzionale contraddice la democrazia parlamentare e tende a ridimensionarla o, addirittura, a sovvertirla.
Poiché anche noi, nella nostra modestia, abbiamo qualche rudimento di logica, diciamo subito che il predetto modo di argomentare costituisce un’evidente forzatura. É discutibile che tutti i deputati e tutti i senatori del Movimento Cinque Stelle siano degli avversari dichiarati della democrazia rappresentativa; non foss’altro perché siedono in Parlamento e svolgono, si presume con consapevolezza, un ruolo rappresentativo. Anche ammesso e non concesso che coltivino, segretamente, disegni di sovversione del sistema rappresentativo, c’è una considerazione insuperabile: considerati i rapporti di forza nell’attuale diciottesima Legislatura del Parlamento, il Movimento Cinque Stelle non ha i numeri per imporre una revisione della Costituzione perfettamente conforme ai valori di riferimento del Movimento medesimo, qualunque sia l’interpretazione che si dà di questi valori.
Si è visto quanto sia complicato e difficile modificare le disposizioni della Costituzione; perché i Padri Costituenti che la scrissero introdussero, giustamente, delle procedure che forniscono a tutti il massimo di garanzie, inclusa la possibilità di rimettere l’ultima decisione al Corpo elettorale, attraverso il ricorso al Referendum popolare confermativo. Basta leggere quanto scritto nell’articolo 138 della Costituzione.
Qualora il Movimento Cinque Stelle, ad esempio, avesse voluto modificare l’articolo 67 della Costituzione, secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», avrebbe avuto grandi difficoltà a raccogliere, intorno a questa proposta, il consenso della maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori. In ogni caso, noi avremmo avversato tale proposta.
La verità è che la riforma costituzionale di cui ci stiamo occupando ha un contenuto esattamente circoscritto; è una riforma “minimale”, in tutti i sensi. Si può condividerla, o si può criticarla; ma bisogna restare nel merito. Non c’entra alcunché la democrazia diretta, così come niente c’entra la proposta di introdurre il mandato imperativo per i parlamentari.
L’argomento della asserita compressione della rappresentanza si scontra contro un fatto incontestabile: a partire dalla Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presieduta dal deputato liberale Aldo Bozzi, relazione presentata alle Camere il 29 gennaio 1985, il tema della riduzione del numero complessivo dei parlamentari è sempre stato presente nei progetti di riforma.
Nella citata Relazione della Commissione Bozzi si legge: «Per quanto riguarda la composizione, la Commissione auspica una riduzione del numero complessivo dei parlamentari, consigliata anche dal minor carico di lavoro che dovrebbe gravare sulle Camere a seguito delle riforme proposte, e in particolare a seguito della differenziazione delle funzioni e della delegificazione» (1). Tra le soluzioni allora vagliate dalla Commissione: «quella di ancorare la composizione della Camera e della parte elettiva del Senato ad un numero fisso, ma più ridotto dell’attuale: le proposte presentate in Commissione in questo senso prospettano una Camera di 480-500 deputati, e un Senato comprendente 240-250 senatori elettivi» (2).
Vediamo di render conto, sinteticamente, di quanto accaduto nei 34 anni trascorsi dal tempo della Commissione Bozzi, con specifico riferimento alle proposte di nuova definizione della composizione del Parlamento.
I] Testi elaborati dalla Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nella XIII Legislatura. Previsione: il numero dei deputati non può essere inferiore a 400 e superiore a 500 ed è determinato dalla legge. Il numero dei senatori elettivi è di 200.
II] Progetto di legge costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare di centrodestra e sottoposto a Referendum popolare, con esito negativo, il 25-26 giugno 2006, nella XIV Legislatura. Previsione: la Camera dei deputati è composta da 518 deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il Senato federale è composto da 252 senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. Partecipano all’attività del Senato federale, senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
III] Cosiddetta “bozza Violante”, ossia il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007, nella XV Legislatura. Previsione: il numero dei deputati è di 500, oltre a 12 eletti nella circoscrizione Estero. Il Senato federale è eletto su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Il numero dei senatori eletti dai Consigli regionali va da un minimo di cinque, nelle Regioni con popolazione sino a un milione di abitanti, ad un massimo di dodici nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti. L’elezione avviene con voto limitato, affinché possano essere rappresentati sia l’indirizzo politico maggioritario, sia le più consistenti minoranze consiliari. Le Regioni Valle d’Aosta e Molise eleggono, ciascuna, un senatore; le Province autonome di Trento e Bolzano eleggono due senatori per ciascuna. In ogni Regione, il Consiglio delle autonomie locali elegge un senatore nelle Regioni sino ad un milione di abitanti e due senatori nelle Regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
IV] Disegno di legge costituzionale, elaborato quando era in carica il governo presieduto da Mario Monti, approvato in prima lettura dall’Assemblea del Senato il 25 luglio 2012 e trasmesso alla Camera (denominato n. 5386 / Atti Camera), nella XVI Legislatura. Previsione: il numero dei deputati è di 508, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il Senato federale è composto da 250 senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Partecipano ai lavori del Senato federale, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo Regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli Enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all’inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun Consiglio o Assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol, i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato federale non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità.
V] Progetto di legge costituzionale “Renzi – Boschi”, approvato da una maggioranza parlamentare di centrosinistra e sottoposto a Referendum popolare, con esito negativo, il 4 dicembre 2016, nella XVII Legislatura. Previsione: il numero dei deputati è di 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi istituzionali territoriali dai quali sono stati eletti. Secondo la predetta previsione, dunque, dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, 74 ricoprono, contemporaneamente, la carica di consiglieri regionali e 21 ricoprono, contemporaneamente, la carica di sindaci. A fronte di tale composizione del Senato, nel progetto “Renzi – Boschi”, così viene riformulato l’articolo 55 della Costituzione, per la parte relativa alle attribuzioni del medesimo Senato (si veda il quinto comma): «Il Senato della Repubblica rappresenta le Istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato». Attribuzioni di grande rilevanza, come si vede, rispetto alle quali c’è fortemente da dubitare che la prevista composizione del Senato sia adeguata allo svolgimento dei compiti di istituto. Tanto più che, secondo la formulazione delle modifiche costituzionali proposte, i medesimi senatori non lavorerebbero a tempo pieno per il Senato, dovendo contemporaneamente assolvere altri rilevanti impegni istituzionali nei consigli regionali, o nelle amministrazioni comunali di cui sono membri.
Alla luce di questo excursus storico, la nostra conclusione è che il numero alla fine individuato dalla riforma costituzionale approvata nel 2019, 400 deputati e 200 senatori, sia equilibrato. Un Senato di 200 membri può funzionare perfettamente.
3. La riduzione del numero dei parlamentari nell’attuale bicameralismo paritario.
I critici della riforma hanno ragione su un punto: la Relazione della Commissione Bozzi, del gennaio 1985, affermava l’esigenza di superare il bicameralismo paritario, nel senso di differenziare le attribuzioni della Camera e del Senato e di non coinvolgere entrambi i Rami del Parlamento nel procedimento legislativo, fatta eccezione per gli atti di maggiore rilevanza (disegni di legge costituzionale, eccetera). Come si è visto dal sommario excursus storico, richiamato nel paragrafo precedente, tutti i progetti di riforma tentati nelle successive legislature erano, in qualche misura, rivolti al medesimo obiettivo della differenziazione delle attribuzioni di ciascuna Camera. Non a caso in molti progetti il Senato veniva definito “federale”; con ciò stesso diventava l’assemblea direttamente rappresentativa del sistema delle Regioni e delle autonomie locali.
Calibrare attribuzioni e competenze delle due Camere, tuttavia, non è cosa semplice, né facile. Questa scelta è immediatamente connessa alla disciplina del procedimento legislativo: ci saranno ipotesi in cui entrambe le Camere sono chiamate a concorrere all’iter legislativo perché vengono in considerazione atti di particolare rilevanza; ipotesi in cui l’attività legislativa è di competenza della sola Camera dei deputati, quale Organo di rappresentanza generale; ipotesi in cui il Senato, in relazione alle materie trattate, può chiedere di pronunciarsi comunque, sia pure in modo non vincolante, su progetti di legge di competenza della Camera; ipotesi in cui, trattandosi, ad esempio, di materie quali l’ordinamento delle autonomie locali, spetta soltanto al Senato legiferare. Passare da questo schema concettuale alle disposizioni normative che dovrebbero codificarlo, è tutt’altro che agevole. Si pensi alle infinite polemiche provocate dalla proposta di riformulazione dell’articolo 70 della Costituzione, contenuta nel progetto di legge costituzionale “Renzi – Boschi” del 2016. Di fronte a tante ipotesi differenziate di procedimento legislativo, ciascuna suscettibile di ulteriori varianti, tanto il tecnico del diritto, quanto il comune cittadino, finiscono, per ragioni diverse, per provare sentimenti di fastidio e di smarrimento. Si ha la sensazione che una riforma così concepita complichi le procedure, invece di semplificarle.
Il passaggio al bicameralismo differenziato sconta una ulteriore difficoltà. Alcune forze politiche – e tra queste si può citare, senza timore di smentite, il Partito Democratico – ritengono che il sistema bicamerale non sia più attuale, né più rispondente all’esigenza di assumere decisioni in tempi rapidi. Di conseguenza, sono, tendenzialmente favorevoli a che ci sia una sola Assemblea parlamentare rappresentativa, la Camera dei deputati, con conseguente soppressione del Senato. Considerato poco più di un residuo storico.
Il progetto di legge costituzionale “Renzi – Boschi” del 2016 tendeva, appunto, a ridimensionare l’importanza del Senato, senza però arrivare ad una sua formale soppressione.
Tutte le questioni sollevate sono tuttora molto controverse e non si vede all’orizzonte alcuna possibilità che si formi un orientamento largamente maggioritario fra le forze politiche.
Nelle condizioni descritte, la riforma costituzionale del 2019 ha l’immenso pregio della semplicità. Consegue l’obiettivo di ridurre il numero dei parlamentari, ma lascia impregiudicata l’eventualità che, in futuro, possa essere introdotta una nuova disciplina delle attribuzioni delle due Camere. Il riformatore costituzionale del 2019 procede per piccoli passi ed invita quanti hanno progetti riformatori più ambiziosi a continuare a studiare.
4. Conservatori e innovatori.
Noi non pensiamo che quanti hanno smania di innovare abbiano, per principio, ragione. In tempi non troppo lontani, l’amore del “nuovo” fine a sé stesso ha caratterizzato il movimento dei “Futuristi” ed il futurismo, come sappiamo, si è trovato in perfetta consonanza con il fascismo. Piero Gobetti, il quale era un liberale e non un conservatore, ha descritto in poche righe un vizio di fondo della mentalità politica italiana: «Si potrebbe cercare, senza intenzione riposta d’arguzia, la più grave deficienza del liberalismo italiano nella lunga mancanza di un partito politico francamente conservatore. Senza conservatori e senza rivoluzionari, l’Italia è diventata la patria naturale del costume demagogico. Di fronte al pericolo del clericalismo, ora reale ora immaginato da fantasie garibaldine, anche i retrivi si sono ridotti ad amoreggiare col radicalismo» (3).
La proposta di ridurre il numero dei membri del Parlamento italiano esercita, da sempre, su di noi il fascino delle buone cause. In questo caso, la buona causa coincide con il dovere di contrastare la cattiva politica.
La cattiva politica si riconosce subito per le seguenti caratteristiche. La prima è che tende ad aumentare il più possibile il numero di persone che “vivono” di politica, mantenute dal pubblico denaro. Non si fa riferimento esclusivamente ai titolari di funzioni pubbliche elettive, ma anche ai politici non più rieletti e temporaneamente “parcheggiati” nei consigli di amministrazione di Enti, Aziende, Fondazioni culturali, Istituti di credito, eccetera, per nomina politica. A costoro si aggiunge l’esercito dei collaboratori dei politici, dei funzionari di partito, degli addetti stampa e, in genere, dei giornalisti che lavorano in organi di informazione di partito, oppure formalmente indipendenti, ma, nella sostanza, a servizio di un partito. La seconda caratteristica è la tendenza a moltiplicare il numero degli “Enti”: livelli di governo territoriale, nuovi enti pubblici territoriali, organi di decentramento, organi di raccordo fra più enti diversi. Qui si contraddice una regola che, in filosofia, è nota come “Rasoio di Ockham” (italianizzato in Occam): “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“, ossia non bisogna aumentare il numero degli enti, se non quando ciò sia strettamente necessario. Guglielmo di Ockham, eminente filosofo e frate francescano inglese, visse a cavallo tra la fine del tredicesimo e la prima metà del quattordicesimo secolo. La formula del “Rasoio di Ockham”, trasportata dalla filosofia al diritto pubblico, è una regola basilare di buona amministrazione. Chi vuole più “Enti” lo fa per creare più posti nei quali sistemare persone (siano colleghi di partito, o riconducibili ad una clientela personale), sempre a spese del pubblico denaro, ossia della collettività.
I politici di professione, per difendere sé stessi, sono soliti liquidare come manifestazione di “antipolitica” tutte le critiche nei loro confronti. Sono abilissimi nel ricondurre a nobili esigenze ideali le peggiori pratiche. Nobile ideale è quello di garantire adeguata rappresentanza istituzionale ad ogni comunità territoriale.
Si parte dal presupposto che più alto sia il numero dei rappresentanti, maggiore sia la capacità rappresentativa. Peccato non si tenga conto che, per rappresentare una medesima comunità territoriale, vengano in considerazione: consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari nazionali (deputati e senatori), parlamentari europei. Alcuni si sentono orfani dei consiglieri provinciali, da quando questi ultimi non sono più eletti direttamente dal Corpo elettorale. A ben vedere, tanti rappresentanti, rispettivamente eletti ai diversi livelli di governo territoriale, non aumentano la complessiva capacità rappresentativa. Al contrario, possono determinare una situazione di confusione istituzionale, in cui non sia più chiaro a quale assemblea rappresentativa competa un determinato adempimento ed i diversi livelli di governo territoriale si rimpallino, fra loro, le responsabilità per quanto non è stato fatto, o per quanto dovrebbe farsi con carattere d’urgenza.
Altro nobile ideale, continuamente evocato, è quello della “partecipazione democratica”. Libertà è partecipazione, cantava Giorgio Gaber nel 1972. Ci permettiamo di obiettare che c’è una parolina magica la quale consente di distinguere ciò che davvero è nobile, da quanto nobile non è. Questa parolina è: “gratis“. Ad esempio, il volontariato è nobile cosa nei limiti in cui è dono gratuito agli altri del proprio impegno e del proprio tempo. Allo stesso modo, la politica è attività nobile quando è fatta volontariamente, per passione ideale e per amore nei confronti della comunità sociale della quale si fa parte. A noi piace aggiungere: per amore della propria Patria.
Ovviamente, una cosa è l’interesse per la politica che dovrebbe contraddistinguere ogni buon cittadino, altra cosa è la scelta di candidarsi a cariche elettive, o amministrative, o di governo. In questo secondo caso, c’è il salto di qualità, perché ci si carica di responsabilità istituzionali. Si passa dalla dimensione dei comuni cittadini a quella dei “decisori politici”.
Nell’opinione pubblica italiana dei giorni nostri c’è la molto radicata convinzione che la rappresentanza parlamentare, fatte sempre le dovute eccezioni e considerata nella sua media, sia di mediocre qualità.
La qualità della rappresentanza non è frutto del caso. Dipende essenzialmente da due fattori: a) la legge elettorale vigente, in forza della quale vengono selezionati deputati e senatori; b) le caratteristiche della forza politica che esprime le candidature per la Camera e per il Senato.
Con riferimento alla storia dell’Italia repubblicana, si possono distinguere quattro diversi periodi, nei quali la selezione della rappresentanza parlamentare è stata determinata da quattro differenti leggi elettorali.
Il primo periodo comprende le prime undici legislature. Una legge proporzionale, senza previsione di soglia di sbarramento, e con la facoltà degli elettori di esprimere preferenze, si è tradotta in un sistema multipartitico, nel quale tutte le principali correnti politico-ideali avevano rappresentanza parlamentare.
Il secondo periodo comprende le legislature dalla dodicesima alla quattordicesima. A partire dalle elezioni politiche del 27 marzo 1994, ha trovato applicazione la legge elettorale 4 agosto 1993, n. 277, (legata al nome di Sergio Mattarella). Ai sensi di questa nuova normativa, il 75 per cento dei seggi della Camera dei deputati erano attribuiti in altrettanti collegi uninominali, con sistema maggioritario. Una legge elettorale dello stesso tenore disciplinava le elezioni del Senato. Il collegio uninominale deriva dall’esperienza storica inglese. Ogni territorio ha il suo rappresentante istituzionale assicurato e questo ruolo va al candidato più votato nel collegio di riferimento, con esclusione di tutti gli altri. Per avere più probabilità di vincere nei singoli collegi, più partiti hanno interesse a coalizzarsi fra loro per esprimere candidati comuni nei collegi. Il sistema politico tende così, naturalmente, ad assumere un carattere “bipolare”, nel senso che si costituiscono due grandi alleanze politiche, fra loro antagoniste ed alternative. Nella concreta esperienza storica italiana, il bipolarismo si è risolto nell’alternativa tra uno schieramento di centrodestra ed uno schieramento di centrosinistra.
In teoria, nulla impediva che a coalizzarsi fossero gli stessi partiti “storici” che erano stati protagonisti delle prime undici legislature repubblicane. Nella realtà, il sistema politico italiano risultò completamente sconvolto dal fatto che il mutamento della legge elettorale si accompagnò alla scomparsa dei partiti tradizionali e all’affermazione di soggetti politici nuovi.
I partiti che in precedenza erano stati alleati nella formula del “pentapartito” ed avevano condiviso la responsabilità del governo, DC, PSI, PSDI, PRI e PLI, decisero, l’uno dopo l’altro, il proprio auto-scioglimento, anche perché travolti dalle inchieste giudiziarie del periodo cosiddetto di “Tangentopoli”. Il Partito Comunista, dopo l’abbattimento del muro di Berlino nel 1989 ed il successivo crollo dell’Unione Sovietica, decise di cambiare nome e nel 1991 divenne il “Partito Democratico della Sinistra”, in sigla PDS, con Segretario politico Achille Occhetto.
Nella parte settentrionale del Paese si affermò La Lega Nord di Umberto Bossi, la quale già nelle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, le ultime con la legge elettorale proporzionale, elesse 55 deputati e 25 senatori, mentre cinque anni prima, nelle elezioni del giugno 1987, la Lega Lombarda aveva ottenuto soltanto due rappresentanti in Parlamento (un deputato e un senatore). La Lega Nord si caratterizzò allora come partito di protesta contro il malaffare politico, in perfetta sintonia con le inchieste giudiziarie condotte dalla magistratura. Nel contempo, aveva le caratteristiche di un partito “antisistema”; infatti puntava, addirittura, alla secessione di una parte del territorio nazionale, la “Padania”, in radicale contrasto con il principio costituzionale secondo cui la Repubblica è «una e indivisibile» (articolo 5 della Costituzione, inserito tra i Princìpi fondamentali).
La maggior parte dell’elettorato che prima votava per la Democrazia Cristiana, per il Partito Socialista e per i Partititi laici (PSDI, PRI, PLI) ebbe come suo nuovo riferimento politico il movimento di Forza Italia, fondato dall’imprenditore Silvio Berlusconi. Anche la destra propriamente detta ritenne opportuno modificare la propria offerta politica. Così, nelle elezioni del 1994, le prime con la nuova legge elettorale maggioritaria, si presentò con la denominazione di “Alleanza Nazionale”. Nel gennaio del 1995, fu deciso lo scioglimento del Movimento Sociale italiano – Destra nazionale e restò in campo la nuova Alleanza Nazionale, guidata da Gianfranco Fini.
Ci fu un tentativo di resistenza da parte di quel mondo politico che in precedenza si era riconosciuto nella Democrazia Cristiana. Così, nelle elezioni del 1994, il Partito Popolare italiano, guidato da Mino Martinazzoli, ed il “Patto Segni”, del quale era leader Mario Segni, si presentarono alleati nei collegi uninominali, con la denominazione di “Patto per l’Italia”; scelsero una posizione centrista, senza alleanze né a destra, né a sinistra. Questo cartello elettorale conseguì, sul piano nazionale, sei milioni e 19 mila voti (15,63 % del totale dei voti validi), ma, per la logica stessa del sistema maggioritario di collegio, ottenne soltanto quattro seggi in tutta Italia. Ci riferiamo alle elezioni della Camera. Con il secondo voto, per la quota proporzionale, il PPI conseguì 29 seggi ed il Patto Segni 13 seggi. Si ebbe così la conferma che la scelta di non entrare a far parte di alleanze più ampie, risultò fortemente penalizzante in termini di rappresentanza parlamentare.
Il sommarsi di questi due fenomeni, passaggio ad una legge elettorale prevalentemente maggioritaria e sostituzione dei precedenti partititi “storici” con nuovi soggetti politici, ebbe effetti tanto rilevanti che, nel linguaggio giornalistico, si affermò la tesi che nel 1994 aveva avuto inizio una “seconda Repubblica”.
I partiti politici nati in Italia negli anni Novanta del ventesimo secolo hanno subito assunto caratteristiche molto diverse rispetto ai partiti costituitisi negli anni 1943-1945, dopo la caduta del fascismo.
Anche nella cosiddetta “prima Repubblica”, in tutti i partiti c’erano personalità decisamente dominanti. Facciamo degli esempi. Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Aldo Moro, nella Democrazia Cristiana. Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, nel Partito Comunista. Pietro Nenni, Bettino Craxi, nel Partito Socialista. Giuseppe Saragat nel Partito Socialista Democratico. Giovanni Malagodi, nel Partito Liberale. Ugo La Malfa nel Partito Repubblicano. Giorgio Almirante nel Movimento Sociale italiano – Destra Nazionale. Questi uomini politici, pur eminenti, incontravano comunque dei limiti proprio perché inseriti in veri partiti politici.
Ogni partito aveva una propria tradizione storica, una quasi sempre vivace dialettica interna, esprimeva altri dirigenti politici e rappresentanti istituzionali, molti dei quali di notevole livello qualitativo. Ogni partito si configurava come un “soggetto collettivo”, un’intelligenza collettiva. Il modello di partito restava quello che aveva avuto le proprie origini nell’Inghilterra del diciottesimo secolo, con la dialettica fra Tories e Whigs, e che poi si era affermato ovunque nel diciannovesimo secolo. Ogni partito aveva una forte caratterizzazione ideale; anzi, sarebbe più esatto scrivere “ideologica”. Ciò comportava che le campagne di tesseramento e le adesioni di nuovi iscritti non dipendevano esclusivamente dalla linea politica attuale del partito; ma una quantità significativa di persone decidevano di iscriversi per il fatto di condividere una data concezione ideale, una determinata visione della storia. Gli organismi direttivi dei partiti avevano certamente un potere di indirizzo della linea politica; ma questa doveva poi essere confermata e legittimata da assemblee congressuali, prima a tutti i livelli territoriali, poi in ambito nazionale. In questo modo, dirigenti, militanti e semplici iscritti avevano l’impressione di dare un proprio contributo di elaborazione; erano, o si illudevano di essere, protagonisti: spettava loro esprimere consenso, o dissenso, rispetto a nuove analisi della realtà, a nuove riflessioni progettuali, alla individuazione di nuovi obiettivi per l’azione pratica.
Questo era esattamente il modello di partito che avevano in mente i padri Costituenti quando, nell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana, hanno scritto: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
I partiti della cosiddetta “seconda Repubblica” appaiono, invece, dominati, anzi ossessionati, dall’esigenza di dotarsi di una leadership forte. Le riunioni nelle sezioni territoriali, i congressi, vengono considerati perdite di tempo. Bisogna decidere in tempi sempre più rapidi. Si afferma la mentalità secondo cui soltanto il leader ed il gruppo ristretto di consiglieri che gli sta intorno siano in grado di assumere decisioni con la velocità richiesta dall’incalzare degli eventi. La caratteristica saliente dei soggetti politici di formazione più recente si può, quindi, così riassumere: tutto il potere decisionale si concentra in un vertice, tendenzialmente sempre più ristretto; la base degli iscritti, a prescindere dalle sue dimensioni numeriche, serve soltanto per esprimere consenso al vertice.
La trasformazione descritta dello strumento attraverso cui si opera politicamente ha determinato precise conseguenze nella selezione della rappresentanza parlamentare. La scelta delle candidature è stata ricondotta al vertice ristretto. Questo, ovviamente, nel selezionare i candidati, non poteva non tenere conto dell’esigenza di consolidare sé stesso. Il primo criterio di selezione, prioritario rispetto ad ogni altro, è diventato quello della affidabilità e della fedeltà dei candidati: meglio scegliere persone mediocri, ma pronte a seguire le indicazioni del vertice del partito, piuttosto che persone intelligenti e brillanti, ma dal temperamento troppo indipendente. L’introduzione dei collegi uninominali ha favorito la tendenza predetta. In teoria, in ogni collegio uninominale bisognerebbe candidare una persona molto radicata nel territorio di riferimento. Nella realtà, poiché le candidature nei collegi sono normalmente decise in una logica di coalizione fra più partiti, e ad ogni partito coalizzato spettano un certo numero di collegi ritenuti “sicuri”, o nei quali la vittoria sia comunque probabile, capitava spesso che alla fine venisse “paracadutato” in un collegio un candidato che risultava completamente estraneo rispetto alla comunità territoriale di cui avrebbe dovuto diventare il rappresentante istituzionale. É successo tante volte e le immancabili proteste della base del partito sono sempre stata superate dall’argomento che non era possibile rimettere in discussione un accordo complessivo fra una pluralità di partiti coalizzati.
La nuova legge elettorale prevalentemente maggioritaria indusse la maggior parte delle forze politiche a ritenere che il Governo del Paese fosse direttamente deciso dal Corpo elettorale. Ciò significava considerare superata la democrazia parlamentare, che pure era il sistema previsto dalla Costituzione. Quando, nel 1997, si insediò la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta da Massimo D’Alema, il mutamento della “Forma di governo” fu messo all’ordine del giorno. Com’è noto, le proposte elaborate dalla Commissione in materia rimasero sulla carta. Una diversa disciplina costituzionale della “Forma di governo” fu invece realizzata per le Regioni. Con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, furono modificati, in particolare, gli articoli 122 e 126 della Costituzione. L’articolo 122 stabilì che il Presidente della Regione è eletto «a suffragio universale e diretto», salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente. L’articolo 126 affermò che i reciproci rapporti tra il Presidente della Regione, eletto direttamente dal Corpo elettorale, e il Consiglio regionale fossero basati sul criterio, cosiddetto, del “simul stabunt, simul cadent“: che significa, o si reggono insieme, o insieme cadranno. Nell’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, fu stabilito che tanto l’eventuale approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Regione, quanto le dimissioni presentate dal medesimo Presidente, avrebbero automaticamente comportato «le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». Lo stesso effetto fu previsto nel caso di eventi riguardanti la persona fisica del Presidente: l’impedimento permanente, o la morte.
Nelle vicende della selezione della rappresentanza parlamentare, il terzo periodo è quello che si apre con l’approvazione della legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270, (legata al nome di Roberto Calderoli). Con questa legge si votò in tre elezioni consecutive: nell’aprile del 2006, nell’aprile del 2008 e nel febbraio del 2013. Di conseguenza, ben tre Legislature repubblicane, dalla quindicesima alla diciassettesima, sono state determinate, quanto all’elezione dei parlamentari, dalla legge citata. Questo è, senza dubbio, il periodo più oscuro ed infelice dal punto di vista del palese contrasto fra la normativa elettorale e le disposizioni della Costituzione. La legge Calderoli, in linguaggio giornalistico anche detta “Porcellum”, abrogò i collegi uninominali. Ciò indusse alcuni commentatori ad equivocarne la natura; forse ignorando che non tutte le leggi di impianto maggioritario storicamente sperimentate si basano sui collegi uninominali. Qualche sprovveduto arrivò a parlare allora di “ritorno al proporzionale”. In realtà, si è trattato di una legge maggioritaria; per molti versi modellata sul precedente storico della legge elettorale Acerbo, voluta da Benito Mussolini, con la quale si votò nelle elezioni del 6 aprile 1924. Fu anche grazie alla maggioranza parlamentare ottenuta in attuazione di quella legge che il fascismo poté diventare regime.
La legge n. 270/2005 garantiva comunque alla coalizione più votata, nelle elezioni per la Camera, una maggioranza di 340 seggi, corrispondenti al 55 % dei 617 seggi da assegnare (in questo computo non si consideravano i 12 seggi assegnati nella circoscrizione Estero ed il seggio spettante alla Valle d’Aosta). Si rifletta su un dato che si fonda sulla logica, prima che sul diritto costituzionale: la maggioranza parlamentare predeterminata per legge contrasta in modo stridente con la Forma di governo parlamentare. Un deputato che “per legge” è chiamato ad integrare i numeri della maggioranza parlamentare, non può avere altro compito che quello di votare disciplinatamente tutti i provvedimenti proposti dal Governo. La sua funzione si esaurisce nell’essere presente al momento delle votazioni e nel premere i bottoni giusti del sistema di voto elettronico. Nella Forma di governo parlamentare, invece, il Parlamento è il luogo privilegiato della politica. Il Governo, per reggersi, «deve avere la fiducia delle due Camere» (articolo 94 della Costituzione). Le Camere sono libere di revocare la fiducia ad un Governo ed accordarla ad un altro. Aumenta quindi il peso politico e, in misura corrispondente, la responsabilità, dei singoli deputati; tutti chiamati ad interpretare quello che, dal loro punto di vista, è il bene della Nazione, senza alcun vincolo di mandato. Si rilegga la formulazione dell’articolo 67 della Costituzione.
La legge n. 270/2005 ha, come si è detto, soppresso i collegi uninominali; contemporaneamente ha negato al cittadino elettore la facoltà di esprimere preferenze (nemmeno una) per la scelta dei candidati. Le liste dei candidati erano “bloccate”, nel senso che i seggi spettanti alle varie liste erano attribuiti secondo l’ordine di presentazione dei candidati nelle liste medesime. Di conseguenza, il potere di selezionare la rappresentanza parlamentare era interamente demandato ai ristretti vertici dei partiti. Questi, non soltanto decidevano chi candidare e chi no (potere già esercitato in precedenza), ma determinavano quali candidati avessero serie probabilità di essere eletti, relegando tutti gli altri nella non piacevole condizione di essere meri “riempitivi” delle liste. Agli elettori restava soltanto il potere di votare una lista, piuttosto che un’altra.
C’è stato tutto il tempo perché la legge elettorale detta “Porcellum” fosse studiata approfonditamente, in ogni sua magagna. Noi stessi ce ne siamo occupati tante volte. Poiché, alla fine, alcune disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, può sembrare che la declaratoria della Corte sia esaustiva e che tutti gli aspetti problematici siano stati giudicati e risolti. Non è così, perché la Corte Costituzionale decide nei limiti delle questioni sollevate. In questa sede ci preme mettere in luce soltanto un aspetto: una legge elettorale con le caratteristiche della legge n. 270/2005 è profondamente “manipolativa” della rappresentanza. A livello nazionale si determina come i 340 seggi della maggioranza garantita “per legge” debbano essere distribuiti fra le diverse liste che fanno parte della coalizione risultata più votata. C’è la certezza di quanti seggi spettino, complessivamente, a ciascuna lista, in proporzione ai voti da questa ottenuta; si tratta di un’operazione numerica, rispetto al cui esito non ci sono dubbi. Il problema nasce, invece, quando si tratta di assegnare, nelle circoscrizioni elettorali, i seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Qui le certezze si consumano rapidamente. Anche perché la legge medesima consentiva ad una stessa persona di essere candidata in una pluralità di circoscrizioni; così il vertice del partito poteva riservarsi un ulteriore potere decisionale: quello di determinare la scelta del candidato risultato eletto in più circoscrizioni, facendolo optare per una, piuttosto che per le altre.
Se si intende il significato del termine “partitocrazia”, si comprende la nostra conclusione che la legge n. 270/2005 è stata la legge elettorale più partitocratica che si potesse concepire. Un’autentica vergogna, rispetto alle caratteristiche delle leggi elettorali dei principali Paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito. Certo, quando si parta dal criterio che non ci debbano essere né collegi uninominali, né preferenze, non ci sono più limiti al degrado della rappresentanza parlamentare. Poche persone possono determinare come debba essere composto l’intero Parlamento. Hanno lo stesso potere dell’imperatore Caligola quando, per umiliare il Senato, decise di nominare senatore il proprio cavallo Incitatus.
Per completezza di ricostruzione storica, ci limitiamo a ricordare che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che attribuisce un premio di maggioranza senza predeterminare la soglia minima di voti, o di seggi, che la coalizione risultata più votata debba raggiungere per ottenere tale premio in seggi, con ciò determinando «una illimitata compressione della rappresentatività dell’Assemblea parlamentare». La Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che «priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti». La logica della rappresentanza, consegnata nella Costituzione, è ferita dalla circostanza che «alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione», manchi «il sostegno della indicazione personale dei cittadini».
L’ultima legge elettorale che viene in considerazione è la legge 3 novembre 2017, n. 165, (che porta il nome di Ettore Rosato). Essa prevede che circa un terzo dei parlamentari siano eletti in collegi uninominali con metodo maggioritario. Per l’esattezza, sono eletti con metodo maggioritario 232 deputati su un totale di 630; e 116 senatori, su un totale di 315. Si tratta di un sistema elettorale misto, che ricorda, per qualche aspetto, la legge Mattarella del 1993. Mentre quest’ultima, però, era prevalentemente maggioritaria, con il 75 % dei seggi disponibili assegnati nei collegi uninominali, la legge Rosato è prevalentemente proporzionale. Altra differenza rilevante è che nella legge Mattarella la competizione fra le liste per il voto proporzionale avveniva in circoscrizioni medio-grandi; viceversa, nella legge Rosato si fa riferimento a “collegi plurinominali”, di dimensioni medio-piccole.
La legge n. 165/2017 ha trovato applicazione nelle ultime elezioni politiche, del marzo 2018. Nelle elezioni della Camera, il Movimento Cinque Stelle, interpretando un voto di protesta, straordinariamente consistente e concentrato territorialmente, è riuscito a conquistare 76 collegi uninominali degli 80 complessivamente istituiti nelle otto Regioni dell’Italia meridionale e insulare: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Ciò ha sovvertito ogni previsione, perché il Movimento Cinque Stelle correva da solo, mentre il sistema dell’elezione nei collegi uninominali con metodo maggioritario, potenzialmente premia chi disponga di una capacità di coalizione più larga possibile. Nel voto alle liste, il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto 10 milioni 732 mila voti (pari al 32,68 % del totale dei voti validi espressi) e 133 seggi.
Alla Camera la attuale consistenza del Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle è davvero ragguardevole: 216 deputati, a fronte dei 124 deputati della Lega e degli 89 deputati del PD.
É importante, dunque, verificare come il Movimento Cinque Stelle abbia selezionato la propria rappresentanza parlamentare. Va ricordato che il Movimento è nato dall’iniziativa di due personalità carismatiche: Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, quest’ultimo morto nel mese di aprile del 2016. La logica iniziale è stata quella propria di un gruppo rivoluzionario, o di un partito leninista: una minoranza attiva, di persone legate fra loro da una forte affinità ideale, deve educare il popolo e guidarlo politicamente. Attualmente Grillo conserva un atipico ruolo di “garante” delle regole statutarie; è, comunque, un’anomalia che il leader più autorevole per gli aderenti al Movimento non partecipi alle elezioni e non ricopra cariche istituzionali. Mantenendo, peraltro, una forte influenza sugli aderenti al Movimento che ricoprono cariche istituzionali.
Fatta eccezione per il ristretto gruppo dei fondatori, tutti gli iscritti sono accomunati dalla regola secondo cui “uno vale uno”: nel senso che tutti si equivalgono e devono avere lo stesso peso politico. Proprio questa regola è stata applicata per l’individuazione delle candidature alla Camera o al Senato. Ogni iscritto poteva proporsi. Non si richiedeva che avesse alcuna particolare esperienza, o alcuna specifica competenza. L’unico requisito richiesto era l’onestà, intesa come assenza di precedenti penali. Nella totale mancanza di strutture organizzative nella dimensione regionale, che potessero fungere da filtro per le candidature, la scelta fra quanti si erano auto-candidati è stata rimessa alla piattaforma Rousseau. Nei giorni 16 e 17 gennaio 2018 si sono tenute le cosiddette “parlamentarie” del Movimento. Risulta che, tra le persone che avevano diritto a votare tramite la piattaforma Rousseau, i votanti effettivi siano stati 39.991 per la scelta dei candidati alla Camera e 38.878 per la scelta dei candidati al Senato. Ovviamente, la scelta di ogni votante era limitata al proprio ambito territoriale, ossia ai candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali compresi in quell’ambito. Alla fine, i candidati più noti, per lo più già con l’esperienza di un mandato parlamentare, sono stati approvati con un migliaio di voti. La stragrande maggioranza dei candidati, invece, sono stati approvati con poche centinaia, o addirittura, con poche decine di voti, ciascuno.
Si può concludere che il Movimento Cinque Stelle ha immesso nelle Istituzioni rappresentative tante donne e tanti uomini “nuovi”; ciò è sicuramente un fatto positivo. Considerando le cose da un diverso angolo visuale, tuttavia, si ha l’impressione che tanti deputati e senatori siano stati letteralmente “raccattati” dalla strada. Non a caso Beppe Grillo teorizza che sarebbe preferibile abolire le elezioni e scegliere i rappresentanti istituzionali per “sorteggio”.
Due concezioni ideologiche, fra loro molto diverse, hanno finito così per convergere nello stesso risultato di svalutare la rappresentanza parlamentare: da un lato, la preoccupazione, fortemente avvertita tanto dai gruppi del centro-destra, quanto dal Partito Democratico, di privilegiare la stabilità governativa, a discapito della capacità rappresentativa del Parlamento; dall’altro lato, la mentalità ultra-egualitaria del Movimento Cinque Stelle, per cui non c’è differenza fra un Cavour ed un qualsiasi deputato, perché l’unica cosa che importa è che il parlamentare segua fedelmente le direttive che riceve.
Alla luce del ragionamento svolto finora, bisogna sia chiaro che quanti si oppongono alla riduzione del numero dei parlamentari non intendono “conservare” il venerabile assetto costituzionale entrato in vigore nel 1948. No, vogliono “conservare”, invece, la situazione esistente, contraddistinta da un sempre più evidente e più accentuato fenomeno di scadimento qualitativo e di perdita di prestigio della rappresentanza parlamentare. A partire dalla dodicesima, fino all’attuale diciottesima legislatura, c’è stata una china soltanto discendente.
Il deputato semplice, che non abbia almeno il conforto di ricoprire una carica nell’Ufficio di presidenza di una Commissione parlamentare, è il primo a sentirsi frustrato. Viene chiamato “peone”, appellativo certamente non onorevole; ma quale può essere la considerazione di chi ha il ruolo di schiacciare, a comando, un bottone del sistema di voto elettronico?
La riduzione del numero dei parlamentari produrrà intanto un effetto, probabilmente non previsto da coloro che hanno concepito questa riforma costituzionale: la drastica riduzione dei “peones”.
Ai rappresentanti del popolo si possono applicare i medesimi criteri che spiegano il meccanismo dell’inflazione monetaria in economia: più aumenti il numero complessivo dei rappresentanti, meno vale il singolo parlamentare. Viceversa, se fissi un numero equilibrato, avrai un parlamentare “pesante”, realmente rappresentativo di un territorio. Avrai un singolo parlamentare che conta individualmente di più, quindi può essere più incisivo.
Quanti hanno un’idea chiara di cosa sia lo Storicismo si ricorderanno di Giambattista Vico e della sua teoria sul ruolo della Provvidenza, la quale costantemente realizza i propri fini avvalendosi di quelle stesse energie che gli esseri umani indirizzano, di volta in volta, al perseguimento di tutt’altri scopi. Può darsi che si parlerà di eterogenesi dei fini anche con riferimento al Movimento Cinque Stelle. Può darsi che, fra dieci anni, questa forza politica non esisterà più. Se la riforma costituzionale di cui stiamo discutendo entrasse in vigore, il Movimento lascerebbe comunque una traccia significativa di sé nella storia istituzionale del Paese.
La riduzione del numero dei parlamentari, se associata ad una legge elettorale appena appena dignitosa, determinerà una soluzione di continuità nei costumi politici italiani e potrà conferire nuova dignità al Parlamento.
5. Risparmiare sui costi della politica.
Il risparmio annuale derivante dalla soppressione di 345 posti di parlamentare non è un’entità trascurabile. Può apparire tale a chi si limiti a considerare l’importo dell’indennità parlamentare e poche altre voci di spesa a questa connesse. Sappiamo che il diritto dei membri del Parlamento a ricevere «un’indennità stabilita dalla legge» è garantito direttamente dalla Costituzione (si veda l’articolo 69 Cost.). É giusto che ai parlamentari sia corrisposta un’indennità perché il ruolo di rappresentanza politica deve poter essere svolto da qualunque cittadino che riceva un mandato elettivo e non esclusivamente da coloro che hanno le risorse economiche per potersi mantenere buona parte di ogni settimana a Roma. É giusto che l’importo di tale indennità sia congruo, perché ciò rende più liberi i singoli parlamentari, dotandoli di un’entrata certa che consenta loro di vivere dignitosamente, senza aver bisogno di mendicare favori. Lo Statuto Albertino, che fu la Costituzione del Regno d’Italia, disponeva all’articolo 50 che: «Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità». Tale disposizione non favoriva certamente la moralità del ceto parlamentare. Fu soltanto nel 1912, quando Presidente del Consiglio era Giovanni Giolitti, che si riuscì ad aggirare la pur chiara disposizione dello Statuto, prevedendo un’indennità sotto forma di rimborso annuale per spese di corrispondenza; a questa si aggiungeva un’ulteriore somma per quei parlamentari che non fossero già percettori di stipendi o pensioni in qualità di dipendenti dello Stato.
La natura giuridica del ruolo dei parlamentari, tuttavia, è stata diversamente valutata nel corso del tempo. Al tempo in cui Gaetano Mosca scrisse Teorica dei governi e governo parlamentare, nel 1884, si dava per scontato che i parlamentari fossero dei “funzionari elettivi”, i quali andavano nettamente distinti dai funzionari facenti parte delle Amministrazioni dello Stato. In tempi a noi più vicini, è prevalsa la tesi di considerare il lavoro parlamentare alla stregua di qualsiasi altro lavoro dipendente. Così oggi ai parlamentari viene riconosciuto un “Trattamento di fine rapporto” (TFR) ogni qual volta non vengano più eletti in un’Assemblea rappresentativa della quale, in precedenza, facevano parte. Questo TFR, in teoria, dovrebbe essere interamente finanziato da trattenute mensili dalla busta paga dei parlamentari medesimi, per tutto il periodo in cui dura il loro mandato. In pratica, non avviene sempre così. C’è qualcosa di stridente nel fatto di sapere che ai parlamentari temporaneamente non rieletti venga corrisposta una buonuscita. Soprattutto quando, a distanza di poco tempo, magari li vediamo nuovamente eletti in un’altra Assemblea rappresentativa.
Si toccano con mano un’ostilità, un risentimento, un rancore, una diffusa, complessiva, sfiducia, dei comuni cittadini nei confronti del ceto politico, ossia di quanti fanno della politica la propria professione. Questo fenomeno è stato evidente già nella prima parte degli anni Novanta del secolo scorso, quando le cronache erano dominate dalle inchieste giudiziarie su “Tangentopoli”. Non può dirsi che detto fenomeno si sia oggi attenuato; basti considerare il consenso elettorale che, recentemente, ha premiato forze politiche, quali il Movimento Cinque Stelle, caratterizzate proprio dalla volontà di esprimere e di alimentare la protesta popolare.
Noi non pensiamo che si tratti di critiche destituite di fondamento, riconducibili esclusivamente ad ignoranza, demagogia, populismo.
Quanti seguono attentamente le vicende della politica possono valutare se siano esagerate le seguenti considerazioni che abbiamo scritto in un libro pubblicato nel 2011, in occasione del centocinquantesimo anniversario della fondazione dello Stato italiano unitario: «In tutti i casi in cui, nelle Camere del Parlamento, ma anche nelle Assemblee rappresentative delle Regioni a statuto speciale e, come linea di tendenza, nei Consigli regionali delle Regioni ordinarie, vengano in considerazione poteri di auto-organizzazione interna costituzionalmente o statutariamente garantiti, con connesse autonomia regolamentare e contabile, questi poteri si traducono in situazioni di sempre maggiore privilegio per i titolari di funzioni pubbliche elettive, in termini di trattamento economico complessivo, benefits di varia natura, trattamento pensionistico» (4). In questa materia, lo Stato di diritto fa acqua da tutte le parti. Le decisioni di spesa sono deliberate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere. Tali Uffici sono rappresentativi di tutti i Gruppi parlamentari (di maggioranza e di opposizione). Di conseguenza, si procede con una logica consociativa, nel senso che una decisione di spesa non si nega a nessuno, affinché tutti poi siano corresponsabili dell’insieme. Gli Uffici di Presidenza, quando decidono di adottare un provvedimento, di qualsiasi natura, non si limitano ad operare in conformità ad un corpo di disposizioni regolamentari “certe”, “emanate in precedenza”, da chiunque conoscibili, ma hanno il potere di creare sul momento una nuova disposizione regolamentare, o di modificarne una precedente, cosicché il provvedimento che adottano sia sempre e comunque formalmente legittimo, perché coerente con la nuova normativa. In materia di spese deliberate dalle Camere, non si può introdurre alcuna disciplina per legge, perché c’è una riserva di regolamento parlamentare. I giudici, ordinari, amministrativi e contabili non possono intervenire e quando la Corte dei Conti ha compiuto qualche timido passo, si è gridato al golpe. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari, ha trovato comodo attestarsi sulla linea della inammissibilità del giudizio, con la motivazione che la medesima Corte deve giudicare la legittimità costituzionale delle leggi, mentre i regolamenti parlamentari non sono leggi.
Siamo di fronte ad una condizione in cui i decisori di spesa sono giuridicamente irresponsabili. Condizione certamente non positiva, né favorevole alle esigenze dell’etica pubblica.
Non è vero che problemi di questa natura non possano avere soluzione. Altrove, in altri Stati civili, sono stati presi in considerazione e, in qualche modo, risolti. Consideriamo, ad esempio, l’ultimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, il 27°, definitivamente approvato il 7 maggio 1992. La procedura per modificare, o integrare, la Costituzione degli Stati Uniti è estremamente complessa: oltre all’approvazione da parte dei due Rami del Congresso (Camera dei Rappresentanti e Senato), la proposta emendativa deve essere distintamente approvata da ciascuno dei cinquanta Stati che compongono l’Unione federale. In questo caso, la procedura fu avviata nel diciottesimo secolo. L’emendamento di cui ora ci occupiamo riguarda i compensi da corrispondere ai membri del Congresso (Compensation of Members of Congress). La soluzione individuata è geniale, nella sua semplicità: «Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di Senatore o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una [nuova] elezione dei Rappresentanti». Ciò significa che i membri del Congresso, quando si pronunciano sulla materia del loro trattamento economico, non possono deliberare provvedimenti che immediatamente trovino applicazione per loro stessi. Delibereranno a vantaggio dei parlamentari futuri.
Quanti ritengono modesti i risparmi derivanti dalla soppressione di 345 posti di parlamentare ci ricordano una mentalità “spagnolesca” che, purtroppo, ben conosciamo nell’Italia Meridionale e in Sicilia. Sono abituati a fare gli “splendidi” con il denaro pubblico. L’equilibrio nei conti pubblici è un valore costituzionale. L’articolo 81 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, così recita al primo comma: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Lo stesso principio vale per tutte le pubbliche amministrazioni (articolo 97 Cost.) e per il sistema delle Regioni e delle autonomie locali. L’articolo 119 della Costituzione, anch’esso riformulato dalla predetta legge costituzionale n. 1/2012, afferma, al primo comma: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea».
Per risanare i conti pubblici, i costumi “spagnoleschi” sono controindicati. Bisognerebbe, invece, seguire l’esempio di solidi piemontesi di scuola liberale, come Quintino Sella, ministro delle Finanze che non si vergognava di teorizzare, e soprattutto di praticare, la “politica della lesina”, e come Luigi Einaudi che ebbe modo di difendere l’equilibrio dei conti pubblici ed il risparmio italiano, ricoprendo, in successione di tempo, le responsabilità istituzionali di Governatore della Banca d’Italia, di ministro del Bilancio, di Presidente della Repubblica.
Ogni risparmio di spesa, qualunque sia la sua entità, è utile; l’importante è moltiplicare le voci di risparmio e poi sommarle. Quando si chiedono sacrifici ai cittadini per provvedere, tramite le entrate fiscali, a finanziare i servizi pubblici diretti alla generalità, proprio i rappresentanti della classe politica devono (“dovrebbero”) essere i primi a dare il buon esempio. Ciò significa non soltanto rinunciare a benefits che non sono strettamente necessari per lo svolgimento del mandato rappresentativo e che, nella misura in cui non servono a questo scopo, sono meri privilegi. Significa anche quantificare in modo razionale i numeri della rappresentanza, a tutti i livelli: deve trattarsi di numeri equilibrati. Il superfluo, proprio perché viene mantenuto a spese dei cittadini contribuenti, va tagliato. Senza troppi complimenti.
Nel mese di maggio del 2007 i giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella scrissero un libro che ebbe uno straordinario successo di vendite: La Casta. Nel capitolo titolato Un palazzo di quarantasei palazzi, si legge, ad esempio: «Camera e Senato nel 1948 occupavano quattro edifici. Oggi ne hanno una trentina» (5). Secondo dati aggiornati al 2006, il Senato spendeva a titolo di canoni di affitto di immobili la somma annuale di 5 milioni e 750 mila euro, nonostante potesse fruire dell’uso gratuito di una serie di palazzi storici appartenenti al demanio, quali palazzo “Madama”, il “Carpegna, il “Giustiniani”, il “Cenci” (6).
La tendenza delle due Camere del Parlamento ad acquisire sempre nuovi palazzi nel pieno Centro di Roma si inquadra anch’essa in un certo rilassamento dei costumi morali che si accompagna costantemente ad una fase di decadenza della politica. I parlamentari volevano mettersi comodi: quindi disporre di uffici adeguati, in dimore prestigiose, per sé stessi e per i propri collaboratori, oppure per le attività dei Gruppi parlamentari, senza trascurare gli ex parlamentari titolati (tutti già “presidenti” di qualche cosa), ai quali pure non si poteva negare un ufficio di rappresentanza. Il tutto, ovviamente, pagato con denaro pubblico.
I contratti di locazione comprendevano, normalmente, una serie di servizi (pulizia, custodia, eccetera), forniti in un pacchetto unico dal locatore. Poiché non sono in molti ad avere la disponibilità di palazzi prestigiosi nel Centro di Roma, i locatori tendevano ad essere sempre i medesimi, nel procedere del tempo. Tale circostanza ha finito per richiamare l’attenzione dell’Autorità giudiziaria. Le cronache ricordano una serie di scandali, tutti molto caratterizzati nell’ambiente romano, che certamente non hanno giovato al prestigio del Parlamento.
Tra le voci di risparmio, suggeriamo, quindi, di tenere conto pure del fatto che ci sarebbe bisogno di un minor numero di immobili da affittare.
Sempre tra le possibili voci di risparmio, suggeriamo pure di considerare che la riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe l’esigenza di rivedere le piante organiche degli apparati burocratici serventi della Camera e del Senato. Ci sarebbe bisogno di un minor numero di impiegati e di funzionari, di tutte le qualifiche. Il livello qualitativo dei dipendenti della Camera e del Senato è, mediamente, molto alto. Perché, tuttavia, corrispondere un trattamento economico pari, in ipotesi, ad otto, quando un trattamento di sei sarebbe già considerato molto buono e potenzialmente tale da attrarre persone molte qualificate da tutti gli Stati europei? Sempre nel già citato libro pubblicato nel 2011, scrivevamo: «Rientra fra i costi impropri della politica anche il trattamento economico e pensionistico privilegiato dei dipendenti delle strutture burocratiche di supporto delle Camere, degli altri Organi costituzionali, delle Assemblee di quelle Regioni che equiparano il trattamento delle proprie strutture burocratiche a quello dei dipendenti delle Camere. La circostanza che vengano pagati in modo esagerato i pubblici funzionari che, per ragioni del loro lavoro, stanno a stretto contatto con i titolari del potere politico, ha una valenza corruttiva» (7). Precisavamo, ovviamente, che l’espressione “corruttiva” va intesa nel suo significato morale e non in quello tecnico-giuridico del diritto penale.
C’è stata una stagione in cui l’esigenza di ridurre i costi della politica era considerata un argomento serio. Tanto da non poter essere ignorata da alcuna parte politica. Ad esempio, al tempo dell’ultimo Governo presieduto da Silvio Berlusconi, fu approvato il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che, all’articolo 14, fissava, per le Regioni a Statuto ordinario, il numero massimo dei consiglieri regionali, in proporzione alla popolazione residente. Così, ad esempio, nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti, il numero dei consiglieri non può essere superiore a 20. Nelle Regioni con popolazione eccedente gli otto milioni di abitanti, il numero dei consiglieri non può essere superiore a 80. Quella normativa era tutt’altro che risolutiva. Richiedeva provvedimenti attuativi da parte delle singole Regioni e ciò non sempre è avvenuto. In ogni caso, la Regione in assoluto più popolosa, la Lombardia, elegge 80 consiglieri regionali.
Nelle ultime elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017, gli elettori hanno eletto 70 deputati regionali. Nelle precedenti sedici legislature (a partire dal 1947), i deputati regionali erano, invece, 90. Poiché lo Statuto speciale della Regione Siciliana è stato approvato con legge costituzionale, la modifica del numero dei deputati regionali ha richiesto una legge costituzionale. Con doppia lettura da parte delle due Camere, eccetera, secondo la procedura fissata dall’articolo 138 della Costituzione. Viene appunto in considerazione la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana”. Tale legge costituzionale, promulgata dal Presidente della Repubblica Napolitano, è stata controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Monti e dal Ministro Guardasigilli Severino. Il Partito Democratico votò sempre a favore della riduzione, in tutte e quattro le letture. Mentre ha votato contro la proposta di riduzione del numero dei parlamentari della quale ora ci stiamo occupando, nelle prime tre letture.
Ma c’è di più. La procedura di modifica dello Statuto regionale fu avviata dalla stessa Assemblea regionale siciliana, con una cosiddetta “legge-voto”, presentata al Parlamento nazionale. Tale legge-voto fu approvata durante la quindicesima Legislatura dell’ARS, quando, per la cronaca, nessun deputato del Movimento Cinque Stelle sedeva fra i banchi di Sala d’Ercole. Si era partiti da un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Presentato, è il caso di ricordarlo, da un deputato regionale del Partito Democratico (8).
Oggi alcuni trovano comodo liquidare la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, assumendo che essa sia una tipica manifestazione della deriva “populista” del Movimento Cinque Stelle. In realtà, in questo caso, il Movimento si è limitato a mettersi in sintonia con un diffuso sentimento popolare di sfiducia nei confronti della classe politica, genericamente intesa. Tale sentimento si basa certamente anche su pregiudizi, esagerazioni, mancata conoscenza delle regole di funzionamento delle Istituzioni. Non avrebbe potuto crescere tanto, tuttavia, se i cittadini non avessero fatto ricorrente esperienza di episodi di malcostume politico. L’antipolitica, se vogliamo usare questo termine, è alimentata dalla cattiva politica.
A noi preme mettere in luce, però, che la critica nei confronti di quella che Gaetano Mosca ha definito la “classe politica” non nasce soltanto da risentimento e da pulsioni irrazionali. Viene in considerazione un pensiero; il quale si traduce nella coscienza che sia possibile intendere in modo diverso la politica e l’attività svolta a servizio delle Istituzioni.
Intendiamo riferirci ad una consolidata tradizione di pensiero che si collega, addirittura, alla storia dell’antica Roma, o meglio al modo in cui quella storia è stata narrata e tramandata. Facciamo riferimento alla concezione delle virtù repubblicane, di cui si fecero assertori, ad esempio, Marco Porcio Catone, detto l’Uticense, e Marco Tullio Cicerone. La Repubblica romana restò un modello per i pensatori del quindicesimo e sedicesimo secolo, come l’italiano Niccolò Machiavelli, del diciassettesimo secolo, come l’inglese John Milton, del diciottesimo secolo, come lo svizzero-francese Jean-Jacques Rousseau. Pure un padre della Patria italiana, Giuseppe Mazzini, discende da quella corrente di pensiero. Anche se di questa tradizione molti non hanno più chiara consapevolezza, qualcosa sempre rimane nella coscienza collettiva, non foss’altro per quei pochi elementi che vengono veicolati attraverso l’istruzione scolastica.
Per venire ad Autori a noi più vicini nel tempo, potremmo raccogliere le citazioni di Gaetano Salvemini e di Ernesto Rossi contro il malcostume politico e la partitocrazia. Ne verrebbe fuori un volume di grande formato. Ci limitiamo a ricordare qui qualche titolo di Ernesto Rossi: Settimo: non rubare (Bari, Laterza, 1952), oppure Aria fritta (Bari, Laterza, 1956). In quest’ultimo è compreso l’articolo Le serve padrone, pubblicato nel settimanale Il Mondo del 24 giugno 1950. Si tratta di un articolo pionieristico per l’Italia appena uscita dalla seconda guerra mondiale, sul problema del finanziamento dei partiti politici. Le “serve” sono le strutture organizzative dei partiti, le quali, nate come apparati serventi, finiscono poi con il condizionare il modo di essere dei partiti stessi, nella costante ricerca di fonti di finanziamento.
Si obietterà che Salvemini e Rossi erano dei “moralisti”; il termine viene oggi usato come un insulto, ma sarebbe molto facile replicare che è sempre meglio essere “moralisti” che comportarsi da mascalzoni. Preferiamo allora citare un intellettuale raffinato, che può piacere sia ai progressisti, per essere stato una delle bandiere della “sinistra liberale” in Italia; sia alle persone un po’ snob, dal sentire aristocratico, perché Mario Pannunzio – di lui siamo parlando – aveva queste caratteristiche soggettive. Nell’ultimo numero del settimanale Il Mondo, dell’8 marzo 1966, nel prendere definitivamente commiato dai propri lettori, Pannunzio scriveva, tra l’altro: «Non ci piacciono le mezze verità; non ci piacciono la deferenza e l’unzione per le idee che detestiamo. Ci siamo sempre battuti per dare il loro nome ai fatti e ai personaggi. Problemi ideali e problemi concreti non stanno su piani diversi. Gli intellettuali, per noi, non si trovano soltanto fra i poeti e i novellieri. Né tanto meno fanno parte di una corporazione privilegiata, separata dalle altre. L’intellettuale per noi è una figura intera. L’uomo politico, se non vuole essere un puro faccendiere, è anch’esso un intellettuale che vive pubblicamente e che fa con naturalezza la sua parte nella società» (9). La distinzione fra uomini politici degni di chiamarsi tali e meri “faccendieri” è sempre rimasta per noi imprescindibile criterio di orientamento.
L’etica pubblica non è cosa da “moralisti”. Basta avere un po’ studiato il clima ideale del Risorgimento italiano, per averne esatta contezza. Giuseppe Mazzini, repubblicano e padre della Sinistra storica, considerava naturale che i singoli individui anteponessero un bene superiore, quale l’unità e l’indipendenza dell’Italia, ai propri interessi soggettivi. Chi, poi, per seguire il proprio tornaconto, si fosse appropriato di risorse da destinare alla causa italiana, sarebbe stato considerato da Mazzini alla stregua del più miserabile dei traditori e trattato come tale. Tra i liberali, seguaci di Cavour, che ricordiamo con la denominazione collettiva di Destra storica, c’erano i cosiddetti “hegeliani di Napoli”. Tra questi Silvio Spaventa (il quale, per la precisione, era abruzzese). A Napoli avevano conosciuto il regime borbonico: la quintessenza dell’inefficienza e della corruzione. Comprensibile, quindi, che, per reazione, si sentissero attratti da quella idealizzazione dello Stato che trovavano nella filosofia di Hegel. Lo Stato prussiano era un modello di organizzazione, di disciplina, di efficienza, di subordinazione dell’interesse particolare all’interesse generale della comunità. Lo Stato prussiano era, nel contempo, un concreto esempio di Stato di diritto, Rechtsstaat, come dicono i tedeschi; ossia uno Stato che non lasciava i cittadini esposti alle decisioni arbitrarie dei potenti, ma garantiva giuridicamente le legittime situazioni soggettive e patrimoniali dei cittadini medesimi. I politici della Destra storica, quali Quintino Sella, Silvio Spaventa, Marco Minghetti, si sforzarono appunto di dare al nuovo Stato italiano unitario caratteristiche tali, da non sfigurare nel consorzio dei principali Paesi europei.
La politica, quindi, non è una attività che apra una “carriera” come un’altra; non si esaurisce nella meschina logica di approfittare di risorse finanziarie pubbliche per realizzare interessi privati molto circoscritti. C’è anche un “dover-essere” della politica e questo si nutre di concetti senza tempo (quindi, eterni) come il “senso dello Stato”, l’amore della propria Patria, la passione per la giustizia.
Gaetano Mosca (1858-1941), palermitano, si affermò nel campo degli studî, fino ad essere considerato uno dei più autorevoli studiosi di Scienza politica. Piero Gobetti, che lo ebbe come professore all’Università di Torino, ha scritto: «l’Università giuridica torinese ha avuto tre uomini europei come Einaudi, Mosca e Ruffini» (10). Mosca fu un critico severo della Forma di governo parlamentare; era convinto che «anche nei governi rappresentativi e malgrado l’adozione del suffragio universale, il potere politico rimane sempre in mano di una ristretta minoranza» (11). Il medesimo concetto veniva espresso così in modo ancora più chiaro: «Chiunque abbia assistito ad una elezione sa benissimo che non sono gli elettori che eleggono il deputato, ma ordinariamente è il deputato che si fa eleggere dagli elettori: se questa dizione non piacesse, potremmo surrogarla con l’altra che sono i suoi amici che lo fanno eleggere. Ad ogni modo questo è sicuro che una candidatura è sempre l’opera di un gruppo di persone riunite per un intento comune, di una minoranza organizzata che, come sempre, fatalmente e necessariamente s’impone alle maggioranze disorganizzate» (12).
La Teorica dei governi e governo parlamentare, prima opera importante di Mosca, fu quasi interamente scritta durante l’anno 1882. L’Autore, quindi, aveva già maturato certe convinzioni; senza essere influenzato da una circostanza che sarebbe intervenuta in un momento successivo: il fatto di lavorare per dieci anni, dal 1887 al 1897, come dipendente della Camera dei deputati, con la qualifica di revisore dei resoconti parlamentari. Quell’esperienza lavorativa, che gli assicurò un osservatorio privilegiato sugli usi e costumi del ceto politico italiano, non migliorò il suo giudizio sul funzionamento del Parlamento; valse anzi a confermare la sua visione pessimistica. Egli non si occupava tanto dei deputati, quanto dei loro burattinai, i “grandi elettori”. Val la pena di riportare alcune sue considerazioni sulla moralità dei grandi elettori. «Naturalmente nessuno vuole il male per il male, ed in generale come aspirazione astratta tutti desiderano anzi che lo Stato prosperi e che l’azione del governo sia onesta e corretta; ma poi in particolare e nel caso pratico, ognuno non pensa che al suo privato vantaggio, cioè a strappare alle pubbliche amministrazioni quante maggiori utilità gli è possibile, e a contribuire quanto meno può riguardo ai carichi e agli oneri. Ed è naturale: perché pochi hanno la serenità d’intelligenza necessaria a capire che un atto, il quale singolarmente sembra innocente, ripetuto moltissime volte e divenuto quasi generale, diventa esiziale a tutti; e forse più pochi ancora [hanno] la scrupolosità di coscienza che ci vuole per astenersene, quando esso individualmente riesce utile, e lo si vede nello stesso tempo fare a tutti gli altri» (13).
Di fronte al “così fan tutti”, non basta fare appello alle coscienze. Si può essere “frenati” soltanto da circostanze esteriori, che si impongono indipendentemente dalla volontà. Servono buone regole, a presidio dei buoni comportamenti. Per questo motivo ci sembra vada salutata con favore la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Si tratta di introdurre uno sconvolgimento che azzeri abitudini e prassi consolidate; dando così spazio effettivo alla possibilità di regole nuove.
Per non lasciare incompleto il discorso su Gaetano Mosca, va precisato che il regime dittatoriale proposto dal fascismo gli sembrò non migliorasse, ma anzi aggravasse, i problemi della vita pubblica italiana. Egli, nominato senatore del Regno nel 1919, svolse, alla fine dell’anno 1925, un intervento molto critico sul progetto di legge relativo alle attribuzioni del Capo del governo, che poi era Benito Mussolini. Va anche ricordato che Mosca sottoscrisse il Manifesto degli intellettuali antifascisti, voluto da Giovanni Amendola e scritto da Benedetto Croce.
6. Una legge elettorale conseguente.
Il secondo Governo presieduto da Giuseppe Conte è sostenuto da una maggioranza parlamentare della quale fanno parte quattro forze politiche: il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico, Liberi e Uguali (LeU), Italia Viva. Queste forze di maggioranza sembrano orientate a modificare la legge elettorale vigente per approvare, al suo posto, una legge elettorale proporzionale. Non ancora è chiaro quali caratteristiche tale legge dovrebbe avere: il Movimento Cinque Stelle sostiene che bisogna riconoscere agli elettori la facoltà di esprimere preferenze. Si discute, inoltre, di introdurre una soglia di sbarramento per l’accesso alla rappresentanza; in questo caso, bisogna vedere come la si quantifica.
Una legge elettorale, tuttavia, riguardando le regole del gioco democratico, dovrebbe avere il consenso più ampio possibile fra i gruppi parlamentari; non soltanto di maggioranza, ma anche di opposizione.
La nostra opinione è che non sia consigliabile puntare tutto su una legge elettorale proporzionale. La quale, se accompagnata da una rilevante soglia di sbarramento, avrebbe comunque esiti molti diversi rispetto alla legge elettorale vigente nel periodo della prima Repubblica.
La proporzionale ha funzionato in Italia quando c’erano partiti capaci di raccogliere grande consenso popolare, quali la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista, cosicché il restante sistema politico si orientava intorno ai due partiti maggiori. Poi c’era la divisione del mondo in due blocchi, che obbligava la dialettica parlamentare italiana a restare entro confini precisi.
Nelle condizioni odierne abbiamo: partiti “nani” (quanto a capacità di raccogliere consenso), “decerebrati” (ossia, privi di una chiara fisionomia ideale e programmatica), personalistici ed anarcoidi (potenzialmente sempre pronti ad assecondare spinte centrifughe). Con partiti di questa natura, il Parlamento, in regime di proporzionale, sarebbe il campo dei veti reciproci, dei ricatti, delle incessanti pratiche trasformistiche. Diverremmo come la Polonia storica, al tempo in cui si voleva che la sua Dieta deliberasse all’unanimità.
La legge elettorale dovrebbe servire, invece, a ristrutturare il sistema politico italiano; favorendo la nascita di partiti più omogenei e consentendo il costituirsi di coalizioni fra partiti, sulla base di convergenze programmatiche. I collegi uninominali, oltre a garantire che ogni territorio abbia un proprio rappresentante istituzionale, sono anche lo strumento per realizzare, appunto, coalizioni fra diversi partiti, che presentano candidati comuni nei collegi.
La nostra proposta è quella di mantenere i collegi uninominali già previsti dalla vigente legge elettorale (legge n. 165/2017); confermandone numero e delimitazione territoriale. Resterebbero così i 232 attuali collegi uninominali per la Camera, e i 116 attuali collegi uninominali per il Senato. In questo modo nessuno avrebbe motivo di lamentarsi di una supposta compressione della capacità rappresentativa del singolo parlamentare; infatti, restando immutato l’assetto dei collegi uninominali, la capacità rappresentativa del parlamentare eletto rimarrebbe invariata. Ogni territorio, a partire dalla Valle d’Aosta, avrebbe il proprio rappresentante istituzionale garantito.
Se si confermasse l’attuale numero dei collegi uninominali, pur in presenza della riduzione del numero dei parlamentari, le leggi elettorali della Camera e del Senato assumerebbero automaticamente un carattere prevalentemente maggioritario. Resterebbero da eleggere, con metodo proporzionale, 160 deputati (più otto nella circoscrizione Estero) e 80 senatori (più quattro nella circoscrizione Estero).
Con riferimento alla legge elettorale per la Camera dei deputati, si tratterebbe, dunque, di ridurre il numero dei collegi plurinominali, nei quali si assegnano i seggi con metodo proporzionale fra le liste concorrenti.
Se, in ipotesi, il numero dei collegi plurinominali fosse drasticamente ridotto, i collegi medesimi sarebbero più ampî, nel senso che in ciascuno di essi verrebbe assegnato un relativamente alto numero di seggi. La regola (questo è un dato scientifico) della legge proporzionale è: quanto più ampio è il collegio (meglio sarebbe scrivere “circoscrizione”) in cui si assegnano i seggi, tanto più alto sarà il numero delle liste che otterranno rappresentanza. Noi pensiamo, ad esempio, ad un assetto in cui il numero delle circoscrizioni elettorali sia limitato alle seguenti tredici: 1) Nord-Ovest, costituita dalle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria; 2) Lombardia, l’intera Regione; 3) Nord-Est, costituita dalle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia; 4) Emilia -Romagna, l’intera Regione; 5) Toscana, l’intera Regione; 6) Marche e Umbria, costituita dalle due Regioni omonime; 7) Lazio, l’intera Regione; 8) Sardegna, l’intera Regione; 9) Abruzzo e Molise, costituita dalle due Regioni omonime; 10) Campania, l’intera Regione; 11) Puglia, l’intera Regione; 12) Basilicata e Calabria, costituita dalle due Regioni omonime; 13) Sicilia, l’intera Regione (14).
Si potrebbero prevedere soglie di sbarramento per l’accesso alla rappresentanza; ma, in un impianto normativo già caratterizzato in senso maggioritario, noi saremmo contrari. Bisogna, infatti, contemperare due diverse finalità: a) registrare la quantità di consenso che le liste di ogni singola forza politica sono in grado di raccogliere nel Paese, così da dare a quella forza politica un corrispondente peso parlamentare in numero di seggi; b) non privarsi della presenza parlamentare di forze politiche che, pur essendo minoritarie, possono dare un contributo di qualità all’attività parlamentare, facendosi portatrici di punti di vista critici e di proposte innovative. Per questa via, con un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, ma misto, si garantirebbe l’effettivo pluralismo del Parlamento.
Con riferimento alla legge elettorale per l’elezione del Senato, c’è poco da fare perché l’elezione avviene su base regionale; quindi, il collegio per l’assegnazione proporzionale deve coincidere con il territorio regionale.
Una normativa come quella ora proposta non presenterebbe complessità tecniche; quindi potrebbe essere approvata in tempi molto rapidi. Ciò che più importa, risulterebbe facilmente comprensibile agli elettori.
7. Eventuali altre modifiche della Costituzione.
I gruppi parlamentari dell’attuale maggioranza hanno raggiunto un accordo per approvare poche, limitate, riforme della Costituzione, logicamente connesse alla riduzione del numero dei parlamentari. Viene in considerazione la proposta di legge costituzionale n. 2238 / Atti Camera, avente come primi firmatari i deputati Fornaro, Boschi, Del Rio, Gebhard, Francesco Silvestri.
Si tratterebbe, in primo luogo, di modificare la natura del Senato. Il primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sarebbe sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale». Non più su base regionale, come avviene adesso. Distinte proposte di legge costituzionale, presentate in precedenza, come la n. 1440 / Atti Senato, tendono ad abbassare il limite di età per eleggere i senatori (dagli attuali 25 anni a 18 anni). Si discute di modificare pure l’elettorato passivo per il Senato. Si potrebbe essere eletti senatori all’età di 25 anni e non di 40, come attualmente.
A noi sembra del tutto irrazionale la proposta di fare del Senato un perfetto doppione, ma di dimensioni ridotte, della Camera dei deputati. Un Senato eletto su base regionale, quale lo vollero i padri Costituenti, non è una bizzarria. In futuro, un più complessivo progetto di riforma della Costituzione potrebbe anzi valorizzare tali caratteristiche del Senato, in materie come l’ordinamento degli enti locali, l’eventuale razionalizzazione dell’assetto delle Regioni esistenti (nel senso di ridurne il numero), la finanza regionale e locale.
I padri Costituenti vollero due Camere, con caratteristiche fra loro diverse, perché pensavano che il procedimento legislativo fosse una cosa seria, quindi dovesse essere approfondito e meditato, e che una seconda Camera potesse servire a rimediare a eventuali errori e sviste della prima, migliorando così la qualità complessiva della legislazione. Tutto ciò può funzionare a condizione che Senato e Camera abbiano una natura diversa, fra loro. Altrimenti, piuttosto che concepire un doppione in scala ridotta, sarebbe più serio proporre un sistema monocamerale.
I rappresentanti della maggioranza si sono accordati, poi, per ridurre il numero dei delegati regionali designati ai sensi dell’articolo articolo 83, secondo comma, della Costituzione. Elettori che, attualmente, sono, complessivamente, 58. Se venisse approvata la modifica proposta, diverrebbero 39: «due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale», ed un solo delegato per la Valle d’Aosta. C’è da chiedersi poi, come si faccia ad assicurare «la rappresentanza delle minoranze» quando i delegati da eleggere sono soltanto due. Ciò equivale a dire che uno sarà espresso dai gruppi di maggioranza, l’altro dai gruppi di opposizione.
Ci sembra che le riforme costituzionali proposte siano di corto respiro, frutto di miopia politica. L’attuale maggioranza coltiva, forse, l’aspirazione ad eleggere, con le sole proprie forze parlamentari, il prossimo Presidente della Repubblica, alla scadenza del mandato del Presidente Mattarella. Di conseguenza, conta i numeri col bilancino del farmacista. Bisognerebbe preoccuparsi, invece, di esaltare il ruolo del Presidente della Repubblica quale “Capo dello Stato” e rappresentante della “unità nazionale”, come recita l’articolo 87 della Costituzione.
Di conseguenza, non soltanto bisognerebbe confermare gli attuali 58 cosiddetti “grandi elettori” regionali. Bisognerebbe fare uno sforzo ulteriore.
Ad esempio, si potrebbe pensare di inserire, in Costituzione, un articolo aggiuntivo, dopo l’83, del seguente tenore:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, secondo comma, partecipano di diritto all’elezione del Presidente della Repubblica, in ragione della loro carica:
a) i presidenti delle Regioni e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, secondo i dati della popolazione residente quali risultano dall’ultimo censimento generale della popolazione.
Nel caso in cui, per malattia, o altro impedimento, un elettore di cui al presente articolo non possa partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica, la persona che, nell’Istituzione di riferimento, ne esercita le funzioni in via transitoria lo sostituisce anche durante tutte le fasi dell’elezione del Presidente della Repubblica».
I sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione, sarebbero esattamente tredici, secondo i dati Istat del Censimento generale della popolazione dell’ottobre 2011: Catania, Verona, Messina, Padova, Taranto, Brescia, Prato, Reggio Calabria, Modena, Parma, Reggio Emilia, Livorno, Ravenna. Di conseguenza, secondo l’impostazione di questo eventuale articolo aggiuntivo, parteciperebbero all’elezione del Presidente della Repubblica ulteriori 55 grandi elettori, oltre ai 58 già previsti dall’articolo 83, secondo comma, della Costituzione.
Bisogna preoccuparsi del prestigio e della buona funzionalità delle Istituzioni: tanti presidenti delle Regioni e sindaci che contribuissero ad eleggere il Presidente della Repubblica, aumenterebbero la dignità politica della sua carica e renderebbero l’immagine plastica dell’unità nazionale che si realizza intorno a lui.
L’unica cosa consolante è che l’attuale maggioranza non sembra possedere forza numerica e compattezza parlamentari sufficienti per approvare le ulteriori riforme costituzionali di corto respiro di cui si è detto. Meglio così, perché con la Costituzione non si scherza. Accontentiamoci, dunque, della riduzione del numero dei parlamentari; la quale, se entrerà in vigore, sarà una effettiva, rilevante, novità.
Palermo, 27 novembre 2019
Livio Ghersi
NOTE:
(1) Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985, Camera dei deputati / Senato della Repubblica, IX Legislatura, Doc. XVI-bis, n. 3, Volume primo, p. 21.
(2) Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, cit., pp. 21-22.
(3) Piero Gobetti, La Rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, in Opere complete di Piero Gobetti, volume primo Scritti politici, a cura di Paolo Spriano, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1960, p. 949. Il Saggio citato fu pubblicato nel 1924, a Bologna.
(4) Livio Ghersi, Liberalismo unitario (Scritti 2007-2010), Roma, Bibliosofica Editrice, 2011, pp. 308-309.
(5) Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili, Milano, Rizzoli, 2007, p. 41.
(6) S. Rizzo, G. A. Stella, La Casta, cit., p. 42.
(7) L. Ghersi, Liberalismo unitario, cit., pp. 309-310.
(8) Primo firmatario dell’iniziativa legislativa era l’onorevole Giovanni Barbagallo.
(9) Paolo Bonetti, Il Mondo 1949/1966. Ragione e illusione borghese, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 206-207.
(10) P. Gobetti, Le Università e la cultura. Torino, pubblicato nella rivista Conscientia il 23 gennaio 1926, ora raccolto in Opere complete di Piero Gobetti, volume primo Scritti politici, cit., p. 911.
(11) Gaetano Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, in Scritti politici di Gaetano Mosca, a cura di Giorgio Sola, volume primo, Torino, Utet, 1982, p. 193.
(12) G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, cit., p. 476.
(13) G. Mosca, op. cit., p. 481.
(14) L. Ghersi, Il problema della selezione della rappresentanza politica, in Croce e Salvemini. Uno storico conflitto ideale ripensato nell’Italia odierna, Roma, Bibliosofica Editrice, 2007, p. 579.