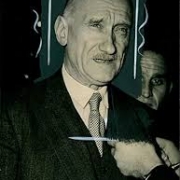Nel marzo 2004, con un voto pressoché unanime, il Parlamento ha approvato l’istituzione della giornata del ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, fissando la data al 10 febbraio, giorno in cui nel 1947 è stato firmato il Trattato di pace che ha assegnato l’Istria, Fiume e le isole Quarnerine alla Jugoslavia. Da allora il tema è stato sdoganato e ha smesso di essere politicamente “indicibile”, ma non per questo si è trasformato in coscienza nazionale condivisa: molti continuano ad ignorarne il significato, i media se ne ricordano solo una volta l’anno, e non manca qualche irriducibile del negazionismo che ne contesta l’esistenza. In realtà, la vicenda delle foibe e ancor più quella della loro rimozione è uno spaccato della storia d’Italia, paradigmatica delle sue contraddizioni e delle sue ipocrisie intellettuali e politiche.
I fatti, in primo luogo. Le foibe sono fenditure tipiche del paesaggio carsico, che si aprono al fondo di una depressione del terreno e che l’erosione millenaria delle acque ha scavato nella spugna delle rocce in forme gigantesche e tortuose. Qui, alla fine della seconda guerra mondiale, sono stati gettati i cadaveri di migliaia di cittadini italiani eliminati per motivi politici dall’esercito partigiano jugoslavo. Le spiegazioni del fenomeno riconducono ad una duplice realtà: da un lato, la politica di italianizzazione forzata perseguita durante il Ventennio fascista nell’Istria e nelle aree mistilingue del confine orientale, con la sistematica snazionalizzazione delle comunità slovena e croata e gli antagonismi nazionali che si sedimentati; dall’altra, la politica espansionistica del maresciallo Tito e l’ambizione di annettere alla nuova Jugoslavia comunista la Dalmazia, l’Istria, Trieste. Nel maggio-giugno 1945, quando le forze titoiste arrivano per prime a Trieste e stabiliscono sul territorio proprie autorità amministrative, si scatena una repressione brutale nella quale si mescolano risentimenti nazionali e volontà epurativa politica. Perché al tavolo delle trattative di pace venga riconosciuta la sovranità di Belgrado su tutto il territorio giuliano, bisogna infatti eliminare le persone che possono difenderne l’italianità, impedire l’affermarsi di autorità antifasciste capaci di legittimarsi agli occhi degli Alleati, sopprimere le personalità di orientamento moderato. Di qui un clima cupo di violenza, di sospetto e di accuse, e una strage che colpisce un numero tuttora indefinito di italiani, ma oscillante tra le 8 e le 10mila unità: cittadini prelevati dalle proprie case, uccisi senza processo, eliminati occultandone i corpi nelle “foibe”.
In secondo luogo, la rimozione: perchè per tanti decenni non si è parlato degli “infoibati”? e perché non si è detto nulla dei circa trecentomila profughi, cittadini italiani che dopo il 1947 lasciano le loro terre d’origine passate sotto sovranità jugoslava e raggiungono la penisola, ospitati in 109 campi di raccolta sparpagliati in tutte le regioni? La spiegazione di questa “memoria negata” rinvia a tre silenzi, pesanti come macigni.
Il primo è il “silenzio internazionale”. Nel 1948, quando Stalin e il Cominform rompono i rapporti con Tito accusandolo di deviazionismo, per l’Occidente la Jugoslavia diventa un interlocutore e la prima regola della diplomazia è che gli interlocutori politici non si mettono in difficoltà con domande imbarazzanti: da quel momento, non c’è più interesse a far chiarezza né sugli infoibati, né sulle ragioni per cui centinaia di migliaia di giuliani abbandonano l’Istria e la Dalmazia.
Il secondo è il “silenzio di partito”. Per il Partito comunista parlare di foibe significherebbe esplicitare la posizione di Togliatti e del suo gruppo dirigente sul confine nordorientale e mettere in evidenza le contraddizioni di un movimento che in Parlamento opera come partito nazionale, ma che in politica estera conserva la visione internazionalista e la subalternità alle indicazioni di Mosca.
Il terzo è il “silenzio di Stato”. L’Italia fascista ha scatenato la seconda guerra mondiale insieme alla Germania e l’ha persa, ma la “nuova” Italia del 1945 si sforza di autorappresentarsi come Paese vincitore e utilizza l’esperienza della resistenza partigiana (nobile e determinante per il futuro del Pese, ma sicuramente minoritaria) come alibi per assolversi dalle proprie responsabilità e per cancellare in un colpo il periodo 1922-1943. Questa rielaborazione assolutoria del passato, che rigetta le responsabilità esclusive della dittatura e della guerra su Mussolini e sul re, giova tanto alla sinistra comunista (che nella resistenza trova la propria legittimazione), quanto alle forze moderate, che puntano alla normalizzazione dello Stato e alla continuità della classe dirigente. Aprire i conti con il passato significa rischiare rivisitazioni dagli esiti imprevedibili e individuare responsabilità che possono pregiudicare gli equilibri del Paese: meglio fingersi vincitori e garantire a tutti una ritrovata verginità politica e morale.
Perché la rappresentazione dell’Italia del 1945 come paese vincitore possa funzionare, non è però sufficiente l’autocelebrazione dell’antifascismo: occorre anche rimuovere in modo radicale dalla memoria collettiva ciò che ricorda la sconfitta. Nascono così i silenzi, le negazioni,le pagine indicibili della storia nazionale. “Indicibili” sono i prigionieri di guerra (di cui ancor oggi non si sa il numero esatto) perché il prigioniero rinvia all’idea della sconfitta; “indicibili” sono i crimini di guerra italiani e i presunti criminali di cui si nega l’estradizione; “indicibili”, soprattutto, sono le foibe e l’esodo, perché nessun Paese vincitore subisce, dopo la fine del conflitto, la strage di migliaia di cittadini, né la fuga di centinaia di migliaia di altri. Nella memoria dell’Italia repubblicana non c’è così posto per chi è stato ucciso nel Nord-est, né per chi ha lasciato le proprie terre e si è trovato a vivere l’esperienza tormentata di esule. L’istituzione della giornata del ricordo è un risarcimento postumo, che certamente ha contribuito a sottrarre il tema delle foibe al becerume della polemica politica: ma nonostante la buona volontà di molti, la strada per trasformare la tragedia del confine nordorientale in coscienza collettiva è ancora lunga e chissà se verrà mai percorsa.
GIANNI OLIVA