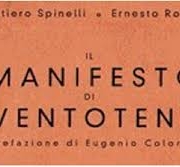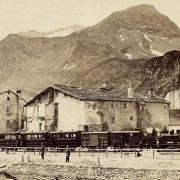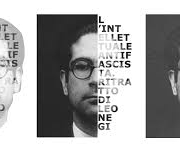Sono passati 75 anni, tantissimi, il tempo di tre generazioni: la maggior parte dei protagonisti non c’è più e non c’è più il racconto, quello che parla all’emozione prima ancora che alla ragione. Inutile nascondercelo: per i più giovani la Resistenza è un’esperienza lontana che conoscono appena, per la generazione di mezzo un ricordo più o meno sbiadito. Basta guardare le piazze sempre più rade e rituali del 25 aprile (e quest’anno nemmeno quelle) per capire che la memoria sta sfumando e che a coltivarla sono rimasti in pochi.
Perché, allora, insistere a commemorare e a parlarne ancora? Perché il significato di ‘Resistenza” va ben al di là del periodo storico al quale si riferisce. In quanto fenomeno di opposizione armata all’occupazione tedesca e al regime di Salò, il 1943-45 è stato oggetto di diverse interpretazioni storiografiche che si sono susseguite nel corso dei decenni: per gli studiosi liberali, quarta guerra di indipendenza che si ricollega alla tradizione patria risorgimentale e al volontariato che ne ha caratterizzato tante pagine; per gli studiosi comunisti, guerra di popolo che ha le sue avanguardie sociali nelle lotte degli operai del marzo ’43, le avanguardie militari nelle brigate “Garibaldi” e nei Gap, le avanguardie politiche nel ruolo dei comunisti nei comitati di liberazione nazionale; per la scuola azionista, una grande occasione mancata di rottura e di rigenerazione morale, dove le spinte al rinnovamento vengono spente dallo sforzo di rapida normalizzazione; per i maestri più attenti alla complessità dei fenomeni, come Norberto Bobbio e Claudio Pavone, un intreccio di guerra sociale, guerra di liberazione e guerra civile, che spesso coesistono nella coscienza dei singoli combattenti.
Lasciamo queste interpretazioni alla storia della storiografia e agli approfondimenti universitari. Per rivolgersi ai più giovani servono altri spunti. Proviamo a proporne due. Primo: le derive contro le quali hanno combattuto i partigiani non sono vergogne irripetibili, ma rischi sempre attuali. “Tutto questo è accaduto, dunque può ancora accadere”, scriveva Primo Levi. Dietro il sistema concentrazionario, le camere a gas, lo sterminio di massa, i forni crematori c’era la Germania degli anni ’40, la nazione con il più alto tasso di alfabetizzazione al mondo, dove si erano formati Bertold Brecht, Thomas Mann, Albert Einstein, dove da due secoli si studiavano i valori dell’uomo (da Kant in poi i maggiori filosofi, filologi, storici, artisti sono stati tedeschi). Eppure, in pochi anni, il totalitarismo ha trasformato un popolo di Tedeschi in un popolo di nazisti che per convinzione, per viltà, per indifferenza hanno collaborato e taciuto sino alla fine. E’ questa la forza feroce dei totalitarismi, la capacità di plasmare le generazioni controllando l‘educazione e l’informazione e mettendo a tacere le voci discordanti. “I nostri aguzzini non erano mostri, non erano uomini geneticamente tarati – sono ancora parole di Primo Levi – Erano come noi: ma erano stati educati male”: e una cattiva educazione li aveva portati a credere lecito e legittimo ciò che oggi suscita orrore. Per questo, se “tutto ciò è accaduto, può accadere ancora”.
Secondo spunto, legato al primo. Ciò che significa “resistenza” l’ha espresso al meglio un pastore tedesco, Martin Neimoeller (che, peraltro, non si riferiva alla lotta partigiana ma alle colpe del silenzio): “hanno portato via gli ebrei e non ho detto nulla perché non ero ebreo;/ poi hanno portato via i comunisti e non ho detto nulla perché non ero comunista;/ poi hanno portato via i sindacalisti e non ho detto nulla perché non ero un sindacalista:/ poi hanno portato via me, e non c’era più nessuno che potesse dire qualcosa”. “Resistenza” significa questo: fare in modo che ci sia qualcuno che può ancora dire qualcosa. E’ questo il valore profondo del 25 aprile: chi allora ha scelto la “montagna”, chi ha resistito con le armi o senza le armi, ha testimoniato un modello di valori diverso da quello imposto, ha fatto in modo che ci fosse ancora qualcuno in grado di dire qualcosa. Si possono fare mille distinguo sul ruolo militare della lotta partigiana, relativizzandone importanza strategica e consistenza numerica: ma non se ne può ridimensionare il valore morale. E non si può ignorare l’attualità di quel messaggio.
“Resistere” è un concetto più volte evocato in anni recenti, di fronte a rischi di deriva democratica veri o presunti. Ma per “resistere” non bisogna aspettare la pressione dell’emergenza. “Resistere” significa avere coscienza di sé, capacità di discernere e giudicare senza condizionamenti, libertà di pensiero, coraggio di parola. “Resistere”, in fondo, è un modo di essere: come tale, si addice alle generazioni che hanno ascoltato i racconti partigiani, ma altrettanto a quelle che hanno poca dimestichezza con le memorie passate e piuttosto che il 25 aprile ricordano l’11 settembre.