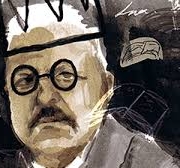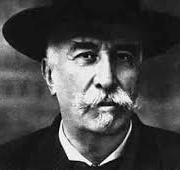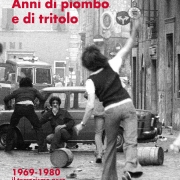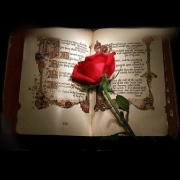Nelle pagine di diario da lui stesso pubblicate sui “Quaderni della Critica” tra il 1946 e il 1947 con il titolo Quando l’Italia era tagliata in due, alla data del 22 aprile 1944, Benedetto Croce ricordava un incontro avvenuto quel giorno nella sua casa di Sorrento: «Visita di Klaus Mann, figlio di Thomas, col quale abbiamo conversato scambiando notizie di comuni amici; l’ho pregato di mandare i miei saluti a suo padre, quando avrà occasione di scrivergli. Io non so altro di lui da più anni».1 Molti anni dopo, precisamente nel 1981, Klaus Mann pubblicava, presso un editore di Monaco, un volume dal titolo La svolta. Storia di una vita, dove riportava il testo di una sua lettera indirizzata alla madre sotto la data del 22 marzo 1944 – un mese prima, quindi, di quella segnata da Croce nel suo diario – dove, tra le altre cose, raccontava la sua visita, in occasione di un viaggio in Italia, a Benedetto Croce che, scriveva, «abitava in un luogo bellissimo presso il mare». E così proseguiva: «Croce è un caso rarissimo! Ed ecco che l’astuta tenacia che egli ha affermato lottando per un ventennio contro il fascismo – non all’estero ma restando in patria – ora ha la sua ricompensa. Il suo prestigio è enorme; il vecchio filosofo ha oggi più autorità morale, più influenza, più potere che qualsiasi uomo politico». Con me, diceva ancora, «fu delizioso. Temevo all’inizio di trovarlo senile: ha quasi ottant’anni e li dimostra. Ma nella conversazione il volto pergamenaceo si animò; e a un tratto mi apparve giovane o, quanto meno, senz’età: un agile coboldo pieno di saggezza e di umorismo. Parlò molto della Germania, spesso con amarezza, ma poi di nuovo con ammirazione. Mi recitò Goethe con una pronuncia tutta sua, ma senz’errore. Con molta cordialità ricordò un lontano incontro con GIROLAMO COTRONEO CROCE E THOMAS MANN annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 23 24 voi, a Monaco, […]. E almeno tre volte mi ammonì di ricordarmi di salutarvi da parte sua appena vi scrivessi».2 Di questo incontro si trova un brevissimo riferimento nei Taccuini di lavoro di Croce, il quale, il 28 settembre del 1931, nel corso di un soggiorno a Monaco, aveva scritto: «Sono andato alla Biblioteca per scorrere il catalogo dei manoscritti italiani, e ho sbrigato altre faccende. […] Nel pomeriggio, a casa del Feist, con Thomas Mann».3 A quell’incontro, il solo, a quel che risulta, tra i due scrittori, avevano partecipato sia la figlia di Croce, Elena, che la moglie di Thomas Mann, come conferma una lettera di Croce a Thomas Mann, che porta la data del 6 dicembre 1931, che si concludeva con queste parole: «La prego di porgere i miei ossequii alla Sua Signora, alla quale e a Lei anche la mia figliuola si ricorda».4 Quell’incontro era stato preceduto da un breve contatto epistolare. Il 3 settembre del 1930, Croce al Congresso Internazionale di filosofia, tenuto in quell’anno a Oxford, aveva letto una «piccola conferenza», come egli stesso l’aveva definita, dal titolo Antistoricismo, che aveva portato a termine il 12 luglio.5 Un estratto di quella relazione Croce lo inviò a Thomas Mann, il quale l’anno precedente aveva ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. Le ragioni per cui, ha scritto Cutinelli Rèndina, «proprio con questo testo Croce decidesse di prendere contatto con Mann sono chiaramente inscritte nella diagnosi e nelle preoccupazioni che le sue pagine esprimono, e nella convinzione che esse avrebbero destato un moto di pensoso consenso».6 Era infatti quello della “piccola conferenza”, un tema – che qui trattava senza alcun riferimento ad esso – di cui Croce aveva parlato occupandosi, nel 1920, di un importante scritto di Thomas Mann, le notissime Considerazioni di un impolitico, apparse nel 1919. Prima di parlare di questo libro – soprattutto di ciò che Croce ne diceva – mi sembra opportuno segnalare alcuni concetti da lui 2 K. Mann, La svolta. Storia di una vita, tr. G.A. De Toni, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 402. 3 B. Croce, Taccuini di lavoro 1927-1936, ed. cit., p. 273. 4 Croce – Mann, Lettere 1930-36, con una scelta di scritti crociani su Mann e la Germania, pref. E. Paolozzi, nota introduttiva E. Cutinelli Rèndina, tr. e note R. Diana, Flavio Pagano editore, Napoli 1991, p.5. Nella lettera di risposta, datata 13 dicembre 1931, Mann scriveva: «Mia moglie ed io ricambiamo di vero cuore i Suoi ossequi, nel ricordo di un incontro che ha lasciato in noi una traccia molto profonda, e La preghiamo di augurare ogni bene anche alla Sua figliuola». Op. cit., p.8. 5 Sotto quella data scriveva nel suo diario: «Terminata di scrivere la conferenza, che sarà intitolata Antistoricismo e nel pomeriggio copiata per passarla in tipografia». Taccuini di lavoro, cit., p. 198. Alla data del 3 settembre scriveva: «Nella sezione in cui si trattava dei rapporti tra metafisica e religione ho esposto in francese le tesi della mia relazione sull’Antistoricismo […]. La piccola conferenza ha suscitato interesse toccando il punto che duole, le condizioni spirituali di quasi tutta l’Europa». Op. cit., p. 208. 6 E. Cutinelli Rèndina, Nota introduttiva a Croce-Mann, Lettere 1930-36, cit., p. XIII. Un consenso indiretto, una vicinanza ideale tra di loro si ritrova in una nota in cui Croce riprendeva una vecchia polemica nei confronti di Oswald Spengler (Cfr. Il tramonto dell’Occidente, in L’Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra, Laterza, Bari 1965, pp.314 segg.), scrivendo queste parole: «In una bella lettura fatta di recente da Thomas Mann alla gioventù di Lubeck, si accenna sprezzantemente a quest’ultima fatica dello Spengler, e contro la pretesa verità che costui asserisce e vanta, si ricorda il detto del Goethe: “che il vero si riconosce soltanto dalla sua capacità a promuovere la vita”; il che proprio non è, come si è visto, l’effetto delle teorie dello Spengler, atte soltanto, in chi presti loro fede, ad accrescere pessimismo e scoraggiamento, cosa della quale non c’è bisogno ora nel mondo, e meno che altrove in Germania». Conversazioni Critiche, Serie terza, Laterza, Bari 1939, IV sezione – Filosofia, p. 298. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 24 25 7 Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, a cura di M. Marianelli e M. Ingenmey, Adelphi, Milano 1997, p. 40. 8 B. Croce, Antistoricismo, in La mia filosofia, a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1993, p.79. 9 Op. e loc. cit. Proseguiva dicendo che il futurismo, che, in altra occasione, diceva essere stato l’incubatrice del fascismo, «adora la forza per la forza, il fare per il fare, il nuovo per il nuovo, la vita per la vita, alla quale non giova mantenere il legame col passato e inserire la sua opera sull’opera del passato». Op. cit., pp. 79-80. 10 Op. cit., pp. 80-81. 11 Op. cit., p. 82. 12 Op. cit., p. 86. Su questo saggio, ovviamente in relazione al rapporto tra Croce e Mann, cfr. E. Paolozzi, Prefazione a Croce-Mann. Lettere 1930-36, cit., pp. 7-11. espressi in quella sede, che segnavano un punto di convergenza – non dichiarato – con quanto, più di dieci anni prima, aveva detto Thomas Mann, il quale inaugurava quel libro dicendo di avere «prestato servizio» al suo tempo «senza uno schietto amore, […] senza disciplina, piuttosto con ostinazione, con cento segni di riottosa amicizia e di malvolere».7 Da parte sua Croce, parlando anch’egli del suo tempo – il medesimo di Thomas Mann, anche se allora il fascismo non era ancora andato al potere in Italia, Hitler non era ancora comparso sulla scena politica tedesca e la natura della rivoluzione russa non si era ancora manifestata – inaugurava il suo discorso con queste parole: «Più o meno presso ogni popolo di Europa, nella varie sfere della vita intellettuale ed artistica, morale e politica, si nota oggi una sorta di decadenza del sentimento storico, quando non addirittura uno spiccato atteggiamento antistorico».8 I fenomeni che gli dettavano queste parole erano il futurismo, che «idoleggia», scriveva, «un futuro senza passato, un andare innanzi che è un saltare, una volontà che è un arbitrio»,9 e un «secondo modo» che «aborre l’idea stessa della storia come il regno del relativo e del contingente, del mobile e del diverso, del vario e individuale», e aspira «all’assoluto, al fermo, all’uno, a trarsi fuori della storia, a superare lo storicismo, per acquistare sicurezza e pace».10 Croce vedeva quindi presenti nella cultura europea di quegli anni due atteggiamenti mentali che volevano organizzare, per così dire, «l’uno in forma anarchica, l’altro in forma autoritariamente disciplinata»,11 la società civile e politica europea. Dopo avere detto che non era la prima volta che l’antistoricismo si presentava nella cultura occidentale, così concludeva: «L’antistorico cristianesimo apportava la virtù della charitas, l’antistorico illuminismo si ammorbidiva di umanitarismo e di sensiblerie, ma l’odierno antistoricismo è tutto sfrenatezza di egoismo o durezza di comando, e par che celebri un’orgia o un culto satanico».12 Ho parlato di questo scritto dove Croce manifestava lo scarso amore che nutriva per il proprio tempo, per dare ragione del perché inviava il testo di quella “piccola conferenza” a Thomas Mann: in essa infatti si trovano momenti e problemi che hanno un preciso riscontro – anche se con tutt’altri toni – nelle pagine delle Considerazioni, un testo al quale poco dopo la sua comparsa in Germania, Croce aveva dedicato un’attenta nota critica, indirizannali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 25 26 zata, scriveva, ai «pochi che amano ancora pensare e che gustano i libri scritti bene»;13 e ne indicava lo “spirito” con queste parole: «Il tema del libro è l’opposizione allo spirito politicien, democratico, demagogico, frasistico e letterario: tema non nuovo, ma qui sentito a nuovo e trattato con finissime osservazioni».14 Che in quel libro Croce ritrovasse molte delle sue convinzioni relative al Novecento, non è certo difficile riscontrarlo in queste parole, dove Mann indicava il “Nuovo Pathos”, che si presentava «come democrazia, come illuminismo politico e filantropia della felicità», rivelando che «la politicizzazione di ogni ethos era opera sua: la sua aggressività, la sua intolleranza dottrinaria consistevano […] nel negare e nello schernire ogni ethos che non fosse politico. L’“umanità” concepita come internazionalismo umanitario, la “ragione” e la “virtù” come repubblica radicale, lo spirito come qualcosa fra il club giacobino e la loggia del Grande Oriente, l’arte come letteratura sociale e retorica sdilinquita con malizia a servizio delle “aspirazioni” sociali: ecco nell’ambiente biologico della politica che gli era proprio, il Nuovo Pathos come l’ho visto io da vicino».15 Chiunque conosca il pensiero di Croce, la sua visione etico-politica, non potrà non notare la vicinanza tra i suoi convincimenti, la sua idea, particolarmente in quegli anni, di “democrazia”,16 e quelli qui espressi da Thomas Mann. Ai quali ne può venire aggiunto un altro di sapore chiaramente antilluministico, che anticipava, per così dire, un tema che in tempi successivi avrebbe molto occupato i pensieri di Croce: «Uguaglianza e libertà», scriveva Mann «evidentemente si escludono a vicenda: quanto alla fraternità, è priva di qualsiasi valore morale se pretende di poggiare sull’eguaglianza».17 Parole come queste erano destinate ad essere fraintese:18 e Mann lo sape13 B. Croce, Le considerazioni di un non-politico, in Pagine sparse, voll. 3, Laterza, Bari 1960, p. 185. Croce iniziava la sua nota con queste parole, dove appare un riferimento a se stesso, in quanto anch’egli scrittore assai polemico nei confronti del suo tempo: «Sono pagine scritte durante la guerra dal celebre romanziere autore di Buddenbrooks: scritte “a forza”, per non potere fare altrimenti, com’è accaduto anche a qualcun altro in questi anni: pagine (dice assai bene l’autore) che sono piuttosto che un “frutto”, un “residuo”, un “contraccolpo”, una “traccia”, e una “traccia di sofferenze”». Op. e loc. cit. Cfr. Considerazioni, cit., pp. 31-32. 14 Le considerazioni di un non-politico, cit., p.185. 15 Considerazioni di un impolitico, cit., p. 49. 16 Mi limito qui a segnalare il secondo capitolo – Le fedi religiose opposte – della Storia d’Europa nel secolo decimonono (Laterza, Bari 1965, pp.22 sgg.), e il saggio del 1943, Intorno al Tocqueville, ora, con il titolo Liberalismo e democrazia, in La mia filosofia, cit., pp.271 sgg. 17 Considerazioni di un impolitico, cit., p.440. Cfr. B. Croce, Libertà e giustizia, in La mia filosofia, cit., pp.95 sgg. Questo concetto, che condivideva con Croce, Mann lo ribadiva ancora nel 1950, in uno discorso tenuto all’Università di Chicago, di cui dirò altro più avanti: «Divergenti sono i princìpi fondamentali della democrazia: libertà e uguaglianza. Questi si contradicono e non potranno mai giungere a una fusione ideale perché l’uguaglianza contiene la tirannide e la libertà il dissolvimento anarchico». Th. Mann, Il mio tempo, in Romanzo di un romanzo. La genesi del “Doctor Faustus” e altre pagine autobiografiche, tr. E. Pocar, Mondadori, Milano 1952, p.263. 18 «Nell’ottica oggi prevalente le Considerazioni sono un libro reazionario, che espone opinioni reazionarie servendosi fino alla comicità dei cliché della sinistra liberale. La forma di vita più onesta più degnamente umana, vi si può leggere ad esempio, è quella del proprietario terriero. Lo Stato dell’autorità costituita, tanto criticato, è e rimane la forma di Stato più adeguata e congeniale al popolo tedesco, quella che in fondo lui stesso si è scelta. […] Le Considerazioni di un impolitico sono state sempre valutate in base a queste idee, annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 26 27 va così bene che scriveva: «Io non sono un Junker col monocolo, come se lo immagina la fantasia dei popoli dell’Intesa, non sono un violento né un attaccabrighe; non ho l’aspetto del Bismarck visto da Zola, cioè quella di un bianco mastodonte con la risata del bruto. Io mi sento un uomo che appartiene a un popolo la cui unità nazionale fu preparata e resa possibile da un’epoca di grande letteratura, di alta formazione umana; sono il discendente consapevole di una borghesia che ha accolto in sé tutta la tradizione di una grande epoca e che è, come in nessun altro Paese, il resultato di una formazione umanissima».19 E concludeva il suo discorso con questa dichiarazione: «Conservatore io? Va da sé che non lo sono; e anche se volessi esserlo per ragionamento, non lo sarei comunque per la mia intima natura , la quale in fondo è quella che opera. In casi come il mio si incontrano forze distruttive e tendenze conservatrici, e se si può parlare di effetto, si verifica appunto questo duplice effetto».20 Molti anni dopo, precisamente nel 1950, nel già ricordato discorso tenuto all’Università di Chicago, un discorso che se lo avesse conosciuto non avrebbe certo incontrato il consenso di Croce, per via di alcuni giudizi sul comunismo,21 Thomas Mann diceva che l’avere scritto I Buddenbrook – dove il dissolvimento di una famiglia borghese voleva essere il paradigma «di un dissolvimento e di una fine più vasti, di una ben più larga cesura culturale e sociale» – lo aveva poi «obbligato alla donchisciottesca e diuturna e annosa fatica di difendere la borghesia romantica, il nazionalismo, la guerra tedesca», in quelle Considerazioni di un impolitico che, aggiungeva, «mi resero reazionario o almeno mi fecero per un poco apparire tale». Quel libro, diceva ancora, «nel suo intimo era più romanzo sperimentale e pedagogico che trascurando il fatto che il medesimo libro distingue in molti punti fra la realtà e le opinioni. La realtà è ciò che conta, le opinioni sono invece vuote chiacchiere fintanto che non coincidono con la realtà. Nel suo caso solo le opinioni sono conservatrici, la realtà e lo stile sono invece internazionaliste, intellettualistiche, letterarie, democratiche: questo è l’aspetto decisivo e fondamentale delle Considerazioni». H. Kurzke, Thomas Mann. La vita come opera d’arte, tr. I. Mauro–A. Ruchat, Mondadori, Milano 2005, p. 242. In effetti, in quel libro Thomas Mann faceva di tutto per essere considerato un “reazionario”, anche se il suo discorso non era privo di ironia. A proposito del “proprietario terriero” scriveva: «E se poi è vero che la più onesta, la più degnamente umana di tutte le forme della vita sociale, quella del signore terriero, è nel contempo la più arretrata e spregevole politicamente, anche questo fatto parla contro la possibilità di instaurare quando che sia un simile reciproco rapporto fra politicità e umanità». Considerazioni di un impolitico, cit. p. 438. E a proposito della Germania: «Io mi dichiaro profondamente convinto che il popolo tedesco non potrà mai amare la democrazia politica per il semplice motivo che non può amare la politica stessa, e che il tanto deprecato “Stato dell’autorità costituita” è e rimane la forma di Stato che più gli è adeguata e congeniale, quella che in fondo lui stesso si è scelta. Occorre un certo coraggio», concludeva, «per esprimere oggi questo convincimento». Op. cit., p. 50. 19 Op. cit., p.449. 20 Op. cit., p. 582. 21 Dopo avere detto che la rivoluzione sovietica «è la grande rivoluzione sociale dopo quella politica del 1789 e, come questa, lascerà le sue orme in ogni convivenza umana», aggiungeva che a imporgli il rispetto verso di essa era «la sua immutabile opposizione al fascismo di tinta italiana e tedesca, a questa scimmiottatura meramente reattiva e melensa del bolscevismo, rivoluzione falsa e mediocre senza alcun rapporto con l’idea dell’umanità e del suo avvenire»; dopo avere detto questo, dunque, «io», concludeva «della mia cultura devo troppo al pensiero russo, all’anima russa , perché la politica del potere possa spingermi a odiare la Russia; e in quanto al comunismo che mi è estraneo ma ha radici profonde nell’uomo russo, è di ieri il fatto che la democrazia occidentale per salvare la propria vita si unì al comunismo russo nella guerra contro il nazifascismo». Th. Mann, Il mio tempo, cit., pp. 260 e 261. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 27 28 manifesto politico. […] Era appena terminato, nel 1918, allorché me ne staccai».22 Croce tuttavia non lo giudicava in questo modo, anzi sembrava convenire con quasi tutte le affermazioni di Thomas Mann. Indicava però da quanto dissentiva: «Si potrebbe forse giungere alla conseguenza», scriveva concludendo la sua nota sulle Considerazioni, «che il tema del libro, annunziato come l’opposizione tra il vero spirito tedesco e quello dei paesi latini, ritrae in forma simbolica o mitologica (di storico mitologismo) l’eterna ed umana opposizione tra aristocrazia e volgo. E certo bisogna pure protestare contro il volgo, definirlo, satireggiarlo, respingerlo da sé con violenza; la pazienza ha i suoi limiti. Ma, fatto questo (e pochi certo lo hanno fatto così bene come il Mann)», proseguiva, «il volgo resta: resta perché opera (a suo modo, ben s’intende), e adempie i suoi molteplici uffici, tra i quali anche di stimolare ed accrescere, nell’aristocrazia, la coscienza dell’aristocrazia. Nessuna guerra, nessuna conquista, nessun assoggettamento, nessuna invasione di popoli lo ha mai distrutto; e se la Germania (la Germania che pensa e sente come il Mann) per caso si propose questo fine, non fa meraviglia che abbia perduto la guerra, e l’abbiano guadagnata invece coloro che hanno saputo fare meglio i conti con la realtà».23 Si tratta di un dissenso che definirei più filosofico che politico, dettato dal diverso ruolo storico assegnato al “volgo”. Comunque sia, l’ultima espressione di Croce non era particolarmente felice, perché l’autore dei Buddenbrook non credo vedesse tra i compiti della Germania, della sua grande e nobile cultura alla quale, come abbiamo visto, si dichiarava orgoglioso di appartenere, quello di “distruggere” il volgo. Certo, nella sua visione l’“aristocrazia dello spirito” veniva opposta alla “massa”, come del resto accadeva a Croce quando, nel 1943, scriveva che «non si dice cosa peregrina se si dice che gli uomini che pensano e che operano profondamente sono pochi e che perciò le sorti della società umana sono legate a quelle dell’aristocrazia». Ma diversamente da Mann, che non utilizzava il metodo dialettico, Croce aggiungeva che questa premessa non doveva far pensare «alle vecchie aristocrazie chiuse», ma a un’aristocrazia aperta «alla quale i nuovi elementi le vengono dalla cosiddetta massa»; e per questa ragione «essa non può trattarla da nemica né da estranea né da materia indifferente, che calchi col piede e sulla quale superbamente passi».24 Discutere se davvero quello indicato da Croce nelle ultime righe della sua nota sulle Considerazioni, sia veramente il senso profondo di quel testo, richiederebbe un discorso molto lungo. Quel che qui importa è che Croce 22 Op. cit., p.253. Poco più avanti, per segnalare il suo distacco dai contenuti di quell’opera scriveva che «se nei suoi ultimi anni il Goethe affermava che ogni uomo ragionevole è un liberale moderato, diremo oggi che ogni uomo ragionevole è un socialista moderato». Op. cit., p. 264. 23 Le considerazioni di un non-politico, cit., pp. 186-187. 24 Aristocrazia e masse, in La mia filosofia, cit. p. 171. Concludeva pertanto che «masse ed aristocrazia non sono […] entità separate e separabili, due mondi ciascuno chiuso in sé e che non può far pressione sull’altro se non dall’esterno; ma, tra loro comunicanti, compongono entrambi l’unica società umana in continuo intimo fervore di reciproci scambi e di trasformazioni». Op. cit., p. 174. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 28 29 aveva prestato a quel libro non poca attenzione e ne aveva condiviso molte delle idee in esso presenti, alcune delle quali sarebbero poi ricomparse nella relazione oxfordiana del 1930, che Croce proprio per questo è da credere che aveva inviato a Thomas Mann. Tornando allora a quel momento, ricevuto l’estratto del fascicolo della “Critica” dove Croce lo aveva pubblicato, Thomas Mann il 28 novembre 1930 gli scriveva: «Stimato signore, Lei mi ha molto onorato e rallegrato inviandomi gentilmente il Suo saggio “Antistoricismo”, che non a caso ha scritto per una rivista chiamata “Critica”. La critica che in esso Lei muove al nostro tempo è tanto pertinente quanto giusta ed amorevole, ed oggi è certo necessaria per tutti i Paesi europei, forse a maggior ragione per noi tedeschi, che siamo fin troppo un popolo incline a cominciare-sempre-di-nuovo in assenza di presupposti e tendente all’oblio della storia».25 Questa lettera – che inaugurava un rapporto epistolare, costituito da una decina di lettere e due telegrammi, e durato fino al primo marzo 193626 – non richiedeva, visto il consenso che Mann manifestava verso le tesi di Croce, una risposta: e infatti non ci fu. Circa un anno dopo, però, precisamente il 6 dicembre 1931, Croce inviava a Mann la sua Introduzione alla Storia d’Europa, 27 accompagnata da queste parole: «Le mando, come Le promisi a Monaco, la mia Introduzione alla storia del secolo XIX. Questa storia è tutta scritta, verrà fuori nel prossimo anno e in varie lingue. Ora io le domando se Ella mi permette di dedicarla al Suo nome. Ricordo i concordi pensieri della nostra conversazione monacense, e provo il naturale desiderio d’indirizzarla a uno dei pochi (non sono molti in Europa) che coltivano ancora taluni ideali».28 Prima di ricordare la risposta di Thomas Mann, credo meriti di venire segnalato che – ha notato Domenico Conte – quella dedica «era senz’altro l’omaggio al grande scrittore», ma era anche «qualcosa di più, ossia di sim25 Croce-Mann, Lettere 1930-36, p.3. 26 Molte di queste lettere saranno citate nel testo. Merita qui di essere ricordato un telegramma inviato a Croce da Thomas Mann il 25 febbraio 1936, in occasione del settantesimo anniversario del filosofo, così formulato: «Mille auguri al grande pensatore e maestro dell’Italia e dell’umanità», e al quale Croce ha così risposto: «A Thomas Mann. Con animo grato ha ricevuto il suo troppo benevolo telegramma di augurii, e prende questa occasione per ringraziarlo ancora una volta dei libri inviatigli negli ultimi tempi. Nella Critica, ha riportati tradotti alcuni periodi della Meerfahrt, che sono stati assai gustati. Ossequia la Sua Signora, alla quale e a lui la figlia Elena, grande lettrice dei libri di Thomas Mann, vuol essere ricordata. Cordialmente Benedetto Croce». Op. cit., p. 19. 27 Su questo opuscolo e le sue vicende, cfr. Croce-Mann, Lettere 1930-36, pp. 5-6, n. 8; B. Croce, Taccuini di lavoro 1927-1936, cit., pp. 236 sgg. 28 E proseguiva: «Dalla lettura dell’Introduzione Ella vedrà quale sia la linea di questa storia. Le debbo anche dire che nel corso di essa sono interpretazioni della storia prussiana, bismarckiana, treitschkiana, nazionalistica, ecc., non certamente favorevoli. Ma pensi che io mi sono educato sui libri e nel pensiero tedesco, e che molte delle mie critiche sono critiche a me stesso, alle mie idee di un tempo. E ormai tutti abbiamo fatto e facciamo il nostro esame di coscienza». Croce-Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 5. Ha osservato Emanuele Cutinelli Rèndina che «la dedica della Storia d’Europa nel secolo XIX è certo la circostanza saliente del rapporto tra Croce e Mann; di un rapporto che, rimasto alquanto formale e mai veramente intrinseco sul piano personale, trovò un punto di consenso intellettuale autentico e profondo forse più nella complessa diagnosi crociana della decadenza europea e del ruolo primario che da decenni la Germania vi stava avendo, sicuramente nell’atteggiamento di ferma opposizione agli svolgimenti politici che questa decadenza aveva ormai prodotto». Nota introduttiva a op. cit., p. XIV. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 29 30 boleggiare, per mezzo di essa l’esistenza e la persistenza di quella Germania che ancora si amava, e di cui Thomas Mann rappresentava, evidentemente, agli occhi di Croce, una testimonianza tra le più alte».29 La risposta di Thomas Mann non si fece attendere: pochi giorni dopo, esattamente il 13 dicembre, dopo avergli detto di non avere «ancora avuto il tempo per [fare] una lettura più approfondita» del testo inviatogli da Croce, così proseguiva: «Ma non voglio e non posso più a lungo esitare per la splendida offerta che mi fa nella Sua lettera, affinché Lei non dubiti, anche per un solo giorno, del profondo apprezzamento con cui la ricevo. Io non voglio parlare», aggiungeva, «dell’onore che Lei mi concede con la dedica del Suo saggio, un onore che in tutto il mondo sarà sentito come qualcosa di grande e di bello, ma sottolineare la gioia suscitata in virtù di una simpatia che unisce in questi nostri tempi bui un numero di spiriti dotati di buona volontà e ben disposti verso la vita, e che nella Sua dedica si esprime con la mia inclusione in questa società spirituale».30 Dopo avere detto che «ciò che oggi in maniera oscura passa sull’Europa è un torbido incidente la cui fine noi vedremo, ne sono convinto, se il nostro impulso vitale resisterà ancora un poco», così concludeva: «Karl Vossler, a cui feci leggere la Sua lettera, mi disse di avere l’impressione che con la Sua storia del ventesimo secolo vedeva la luce un’opera in cui si poteva scorgere il primo bagliore di un’aurora. Accettando la dedica di questo libro, io fisso lo sguardo con gratitudine in questo primo cielo aurorale, e desidererei tanto essere d’aiuto, secondo le mie deboli forze, per realizzarlo».31 Questo momento dei rapporti tra Croce e Thomas Mann si colloca negli anni immediatamente precedenti l’ascesa di Hitler al potere; evento che costrinse lo scrittore tedesco ad abbandonare il suo Paese, divenutogli ostile. Nel febbraio del 1933, una sua conferenza su Wagner presso l’Università di Monaco venne ripetutamente disturbata da un gruppo di nazisti presenti tra il pubblico. Di una malinconica vicenda che seguì questo brutto episodio, Croce ebbe notizia da una lettera di Karl Vossler, che il 3 maggio di quell’anno gli scriveva: «Il povero Thomas Mann si trova in brutte condizioni: pare che adesso stia a Basilea. Un gruppo di intellettuali e artisti di Monaco, ha pubblicato una protesta, parte stupida, parte di malafede e di vile opportu29 D. Conte, Storia universale e patologia dello spirito. Saggio su Croce, Il Mulino, Bologna 2005, p.168. 30 Op. cit., p.6. E, con diretto riferimento a quanto gli aveva detto Croce a proposito della Germania [v. nota precedente] scriveva: «Io fui profondamente colpito dalle parole della sua lettera, nelle quali si affermava che buona parte della Sua critica alla storia tedesca più recente era una critica a se stesso ed alle Sue proprie idee. Questo è esattamente il processo che anche io ho attraversato e conosciuto nel corso di quest’ultimo quindicennio, l’esperienza di un’autocorrezione e di un auto superamento a cui, a dire il vero, fui ben preparato da una grande, vissuta esperienza di formazione: la familiarità con la vita e il pensiero di Nietzsche. Nelle Sue parole, […] parla la fede nell’Idea, nella Verità, parla la passione disinteressata per entrambe, e ciò che tiene insieme quella società spirituale, di cui io parlo, è proprio il suo rifiuto di credere che l’Idea, la Verità e la passione per esse possa invecchiare e risultare sorpassata in seguito a qualche rivoluzione. Rivoluzioni che si dirigono contro la più alta umanità sono rivoluzioni false e infami, che usurpano il loro nome solo per confondere gli spiriti. Ciò è quanto mi separa da un nazionalismo che rivendica per sé l’appellativo di giovane e nuovo». Op. cit., pp. 6-7. 31 Op. cit., pp.7-8. Va da sé che quel “ventesimo secolo” è una banale svista di Thomas Mann. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 30 31 nismo contro il suo discorso in onore di Wagner, facendo finta che si tratti di un atto di vilipendio dell’arte tedesco-wagneriana, la quale in realtà fu celebrata ed esaltata forse anche troppo dal Mann. Così ti cambian le parole in bocca quando fa loro comodo. Mi dicono che Riccardo Strauss, che è tra i sottoscrittori della protesta, ha dovuto confessare che non aveva neanche letto il discorso incriminato».32 Questa ultima frase non fa certo onore a chi aveva messo in musica il celebre Also Sprach Zarathustra di Nietzsche, un filosofo peraltro caro a Thomas Mann.33 In ogni modo, Croce rispondeva a Vossler pochi giorni dopo, il 18 maggio, commentando la difficile situazione in cui versavano gli intellettuali tedeschi, ma senza riferimento alcuno a Thomas Mann: «Apprendo un po’ dai giornali e molto più da lettere e da alcuni tedeschi di origine ebraica venuti qui, quello che sta accadendo in Germania. […] Spero tu non abbia avuto noie. Del resto questa persecuzione degli studiosi e della libera scienza è odiosa, ma anche stupida, e si rivolge nel contrario come la storia attesta».34 Ancora una volta Croce mostrava la sua fiducia nella “pazienza” della storia. Ma a Thomas Mann si era rivolto direttamente il mese precedente, sarebbe a dire il 27 aprile di quel tragico 1933, con queste parole: «Stimatissimo Amico, da molto tempo volevo mandarle un saluto ed esprimerle il mio dolore per la cagione che la tiene lontano dalla sua patria».35 Dopo averlo ringraziato per l’invio del suo ultimo libro su Goethe,36 cosi proseguiva: «Io non riconosco la Germania che avevamo studiato e amato, quella di Goethe e dell’idealismo filosofico, la Germania del Nathan der Weise e della Weltlitheratur, nella Germania odierna, che rinnova le barbare persecuzioni medievali, con questo di peggio: che allora un odio di religione le animava, 32 Carteggio Croce-Vossler 1899-1949, a cura di E. Cutinelli Rèndina, Bibliopolis, Napoli 1991, p. 354. Sempre nel 1933, precisamente l’11 ottobre, Vossler parla ancora a Croce di Thomas Mann in questi termini: «Thomas Mann si è ormai stabilito a Küssnacht presso Zurigo. Sta pubblicando il suo nuovo romanzone intorno a Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli, ricostruzione e rievocazione archeologico-poetica, epica idillica ironica del mondo orientale, che temo gli vada a suscitar intorno un nuovo scandalo e nuove burrasche filo- e anti-semitiche. Non si poteva scegliere un momento meno opportuno per la pubblicazione». Op. cit., p. 364 33 Thomas Mann faceva un riferimento a Nietzsche – cosa che certo non avrà entusiasmato Croce – già nella prima lettera da lui inviatagli, dove scriveva: «Nietzsche ha inveito, in modo tipicamente tedesco, contro lo storicismo ed aveva ragione, se si tratta di un principio che indebolisce la vita»; e ancora nella lettera del 13 dicembre 1931, quando, dopo avere riconosciuto giusto il discorso di Croce sulla storia della Germania, aggiungeva: «Questo è esattamente il processo che anche io ho attraversato e conosciuto nel corso di quest’ultimo quindicennio, l’esperienza di un’autocorrezione e di un auto superamento a cui a dire il vero, fui ben preparato da una grande, vissuta esperienza di formazione: la familiarità con la vita e il pensiero di Nietzsche». Croce-Mann, Lettere 1930-1936, cit., pp. 3 e 7. 34 Carteggio Croce-Vossler, cit., p. 355. 35 Croce-Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 15 e n. 26 36 Qualche tempo prima Mann aveva inviato a Croce il suo «bel libro» su Goethe e Tolstoi, «nel quale», scriveva Croce il 23 marzo 1932, «ho ammirato come il parallelo non l’abbia mai indotta a sforzare le fisionomie dei due personaggi». E non mancava di parlare della questione che stava a cuore a entrambi, la situazione europea di quegli anni: «Mi hanno profondamente interessato le pagine sulle condizioni presenti dell’Europa e la caratteristica della opposta angustia della Francia e della Germania. Il curioso è che in Italia, e da coloro che esaltano la Romanità, si promuove la simpatia per l’Antiromanità degli hitleriani. Ma siamo dappertutto in una grande confusione mentale». Op. cit., pp. 13-14. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 31 32 ed ora la spinta feroce è in stolte dottrine razzistiche. Ma sono cose delle quali spero di poter discorrere con Lei a viva voce».37 Questa discussione non ebbe mai luogo. Come si ricorderà, nel 1944 Croce scriveva nel suo diario di non avere da anni notizie di Thomas Mann, il quale tornò dagli Stati Uniti – non in Germania ma in Svizzera38 – nel 1952, lo stesso anno della morte di Benedetto Croce. Della loro corrispondenza meritano ancora però di venire segnalati almeno due passaggi. Il primo riguarda una delle più grandi opere della letteratura europea del Novecento, La montagna incantata del 1924, nella quale, come è noto, a uno dei personaggi Thomas Mann aveva dato il nome di Ludovico Settembrini. Il 27 gennaio del 1932 – pochi mesi dopo il loro incontro a Monaco – Mann scriveva a Croce: «Guarito da un’influenza che ha fatto accumulare in modo preoccupante la mia corrispondenza, non potrei mancare di ringraziarLa per il suo amabile invio del 18 ultimo scorso, per le Sue cortesi righe ed in particolare per il regalo delle memorie di L. Settembrini. Ho constatato con piacere che fra il protagonista di questo libro ed il mio Settembrini sussiste non soltanto una comunione di idee, ma anche molta affinità di carattere».39 Quali “affinità di carattere” tra i “due” Settembrini, Thomas Mann avesse riscontrato, non sarebbe molto difficile indicare. Ma, trattandosi di un fatto del tutto casuale, non è molto importante: lo è, invece, l’invio allo scrittore tedesco delle Ricordanze della mia vita, che lascia subito intendere che il “caso Settembrini” era stato oggetto di discussione tra di loro nell’ incontro di Monaco. Croce, nel 1928 aveva pubblicato la Storia d’Italia, ma dopo l’incontro con Mann, alla “annotazione” a proposito del dibattito tra “neutralisti” e “interventisti” alla vigilia della prima guerra mondiale dove aveva scritto: «Nel recente romanzo di Thomas Mann, Der Zauberberg (1924), il tipo dell’italiano illuminista, democratico, interventista è rappresentato nel modo più serio e nobile dal personaggio al quale l’autore dà il nome di Settembrini»; a questa annotazione, dunque, aggiungeva: «Fu creduto, e io credetti, che con questo nome egli alludesse al nostro Luigi Settembrini; ma alcuni anni dopo, in un incontro col Mann in Germania, egli mi confessò di avere ignorato affatto l’esistenza di Luigi Settembrini, e di aver composto quel nome derivandolo dal “20 settembre”!».40 L’episodio non è insignificante, visto che Croce assumeva come paradigma di un certo tipo di intellettuale italiano, un personaggio di Thomas Mann, 37 Op. cit., p. 16. 38 In una nota del 1946, dal titolo Previsioni sull’avvenire della Germania, dettatagli da una lettera di Thomas Mann, dove quest’ultimo spiegava «le varie ragioni che lo consigliano a non tornare in Germania e a rimanere cittadino americano», apparsa nell’ottobre del 1945 nella “Neue Schweizere Rundschau”, dopo una lunga citazione del testo di Mann, Croce così concludeva: «Mi è lecito dire che messomi a leggere queste pagine col desiderio di avere qualche lume di speranza, sono rimasto deluso (e più deluso ancora quando, dopo aver letto, ho riletto) tanto poco persuadenti, e, direi, poco persuase mi sono suonate, questa volta, le parole del Mann?». B. Croce, Nuove pagine sparse, voll. 2, Laterza, Bari 1966, I, pp. 341-342. 39 Op. cit., p. 9. 40 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari 1967, p.321. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 32 33 in un’opera allora neppure tradotta in italiano. In ogni modo, questo episodio, pur avendo una sua rilevanza culturale, non ha lo stesso significato che mostrano le loro lettere sulle ragioni della loro vicinanza ideale, come ad esempio quella scritta da Mann a Croce il 15 febbraio del 1932, quando ricevette la Storia d’Europa. Dopo avere manifestato la sua «riconoscente emozione» per la dedica e i versi di Dante che l’accompagnavano,41 intesi a segnalare un comune modo di sentire, che era la comune ostilità alle tirannie e la loro decisione di non piegarsi ad esse; dopo questo, dunque, così gli diceva: «Già quando Lei mi comunicò l’intenzione di dedicarmi il libro, io Le espressi i sentimenti che in me muoveva questa notizia, ma ora che il volume è giunto vorrei ancora una volta dirLe quanto io senta questo suo gesto come un commovente onore. Leggo il libro spesso e con attenzione, e sebbene la lingua mi faccia vedere la Sua opera come attraverso un velo, la luce spirituale che da essa risplende viene di poco smorzata di questo velo. Ammiro il Suo immenso sapere, la Sua vivida arte della rappresentazione, ed amo l’idea che anima il tutto. È opportuno augurarsi fervidamente che questo nuovo dono del suo spirito possa essere presto tradotto nella nostra lingua. Sa Dio, la Germania di oggi ne avrebbe bisogno».42 La Storia d’Europa venne pubblicata per la prima volta in lingua tedesca a Zurigo nel 1935. Ma pur se la loro corrispondenza finisce proprio in quel periodo, la fine del fascismo e del nazismo vide ancora una volta Croce e Thomas Mann vicini nei pensieri. Il 27 luglio del 1943, due giorni dopo la caduta del fascismo, Croce scriveva nel suo diario: «Anche oggi […] ansiosa attesa di notizie e molta tristezza e sentimento di ribellione per le parole pronunciate contro l’Italia da statisti inglesi, che forse si apprestano a far pesare sopra di noi, nel nome della giustizia e della morale, la nostra sciagurata guerra. E nondimeno, nel bivio, era sempre per gli italiani da scegliere una sconfitta anziché l’apparente vittoria accanto alla qualità di alleati che il Mussolini ci aveva imposta, vendendo l’Italia e il suo avvenire e cooperando alla servitù di tutti in Europa».43 Qualche anno dopo, nel 1947, nelle pagine iniziali di uno dei suoi capolavori, Doctor Faustus, Thomas Mann faceva scrivere al “dottore in lettere” Serenus Zeitblom che raccontava la vita del suo amico musicista, queste parole: «C’è una cosa che alcuni di noi solo in momenti che a noi stessi sembrano delittuosi, altri invece sempre e francamente, temono più della sconfitta tedesca, ed è la vittoria tedesca. Io quasi non ho il coraggio di chieder41 «Pur mo veniano li tuoi pensier tra i miei / con simile atto e con simile faccia / sì che d’entrambi un sol consiglio fei». Dante, Inferno, XXIII, 28-30. Proseguendo il discorso poc’anzi citato, sulle affinità di sentimenti tra Croce e Mann, Domenico Conte ha aggiunto: «Anche se la terzina dantesca posta a corredo della dedica, col suo riferimento a pensieri presentantesi ”con simile atto e con simile faccia”, […] suggeriva l’idea di una vicinanza», questa, «a ben guardare, non era invece priva di zone di distacco ed anche di vere e proprie lontananze». Storia universale e patologia dello spirito, cit., p.168. 42 Croce-Mann, Lettere 1930-36, cit., pp. 11-12. Per quel che riguarda la reazione di Mussolini a questa dedica, Op. cit., p. 11, n. 17. 43 B. Croce, Taccuini di lavoro 1937-1943, ed. cit., p. 436. annali_2013_ultimo:impag annali 2012 11-02-2014 14:24 Pagina 33 34 mi a quale delle due categorie appartengo. Forse a una terza, quella che si augura la sconfitta costantemente e con chiara coscienza, ma non senza costante rimorso».44 Le parole di Mann sono più forti di quelle di Croce, soprattutto perché, a parte le differenze di sentire, è diverso il genere, la forma in cui si presentano. Ma di là di questo, mostrano un importante punto di convergenza tra di loro, nonostante nessuno dei due fosse a conoscenza di quello che pensava, sentiva, scriveva, l’altro. Croce era antifascista; Mann antinazista, ma pur sempre uno “italiano”, l’altro “tedesco”; e tutti e due capaci di separare la “patria” dai regimi che la opprimevano, e dei quali non potevano non desiderare fortemente la fine, pur consapevoli di quanto sarebbe costata. Quell’«amor di patria» che nel 1943 Croce chiamava «una parola desueta»,45 non era desueta per loro: ma quella che volevano era una patria “libera” politicamente e culturalmente: e Mann, nemmeno dopo la caduta del nazismo, la ritenne tale. A questo punto il mio discorso può considerarsi concluso.46 Se uno scopo aveva era di segnalare come questi due “grandi” del Novecento, i cui interessi culturali erano lontani, e la manifestazione dei loro pensieri – in forma storico-filosofica quella di Croce, artistico-letteraria quella di Mann – molto diversa, si incontrarono soprattutto nella resistenza alla cultura totalitaria che soggiogò a lungo i loro Paesi.47 Non sono stati molti gli intellettuali del Novecento che di fronte alle ideologie totalitarie, egemoni per lungo tempo, si siano opposti ad esse moralmente, più sul piano etico che su quello politico, più con il loro pensiero, i loro scritti, che non con l’azione, come hanno fatto Benedetto Croce e Thomas Mann: la libertà di cui oggi gode l’Europa deve loro molto. 44 Th. Mann, Doctor Faustus. La vita del compositore tedesco Adrian Leverkühn narrata da un amico, tr. E. Pocar, Mondadori, Milano 1957, p.39. 45 B. Croce, Una parola desueta: l’amor di patria, in La mia filosofia, cit., pp. 292 sgg. 46 Ci sono, oltre quelli ricordati, altri testi in cui Croce cita Thomas Mann, riportando, quasi a proprio uso, soltanto qualche passaggio, praticamente senza commenti, come nel caso di una nota del 1936, Da un nuovo libro di Thomas Mann, in Pagine Sparse, voll. 3, Laterza, Bari 1960, III, pp. 51- 52, dove riporta due brani sul Cristianesimo dal Meerfahrt mit Don Quijote; ancora Storia della poesia e storia di altre cose, del 1932, dove riporta un passaggio de La montagna incantata, Bari 1951, p.178; Sentimento e creazione artistica, del 1927, in Conversazioni critiche, Serie quinta, Laterza, Bari 1939, pp.77-78 dove cita una pagina da Tonio Kröger; o quando in una nota del 1941, dal titolo Poesia europea e nazionalismo, per sottolineare lo scarso valore di un libro sulla poesia europea contemporanea apparso nel 1939 in Germania, scriveva: «Basti dire che nel volume sono taciuti i nomi di Thomas Mann e del Werfel e degli altri romanzieri e poeti politicamente discordanti dal sentire dei loro storici o di sangue non eletto». Pagine sparse, cit., III, p.194. 47 Ha scritto Emanuele Cutinelli-Rèndina che il rapporto tra Croce e Thomas Mann è «così ricco di implicazioni e risonanze che a svolgerlo compiutamente – inutile dirlo – si coinvolgerebbe l’ampio e più impegnativo discorso del legame di Croce con la cultura tedesca e della continua e drammatica chiarificazione che le vicende della Germania contemporanea imposero a questo legame. Per quanto riguarda il rapporto inverso», ha proseguito, «quello di Mann con Croce, bisognerà tuttavia dire che esso non si presenta altrettanto ricco di echi e di implicazioni significative. Restringendosi ai non molti documenti disponibili e prescindendo da questioni generali come la debole conoscenza che Mann ebbe dell’italiano e il fatto che la cultura italiana fu ben lontana dall’essere per lui quello che per Croce era la cultura tedesca, si direbbe […] che in Mann c’era soprattutto la simpatia morale per un atteggiamento di intransigente opposizione politica e civile capace di andare oltre il valore della patria ottocentescamente e nazionalisticamente concepita». Nota introduttiva a Croce-Mann, Lettere 1930-36, cit., pp. XXIII-XXIV.
Potrebbero interessarti
Articoli recenti
Categorie
Archivio
- Giugno 2025
- Maggio 2025
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
Contatti
Centro Pannunzio
Associazione culturale libera fondata a Torino nel 1968
Via Maria Vittoria, 35 H
10123 Torino (TO)
Tel 011 8123023
redazione@pannunziomagazine.it
www.centropannunzio.it